La ragione contro il potere – Noam Chomsky
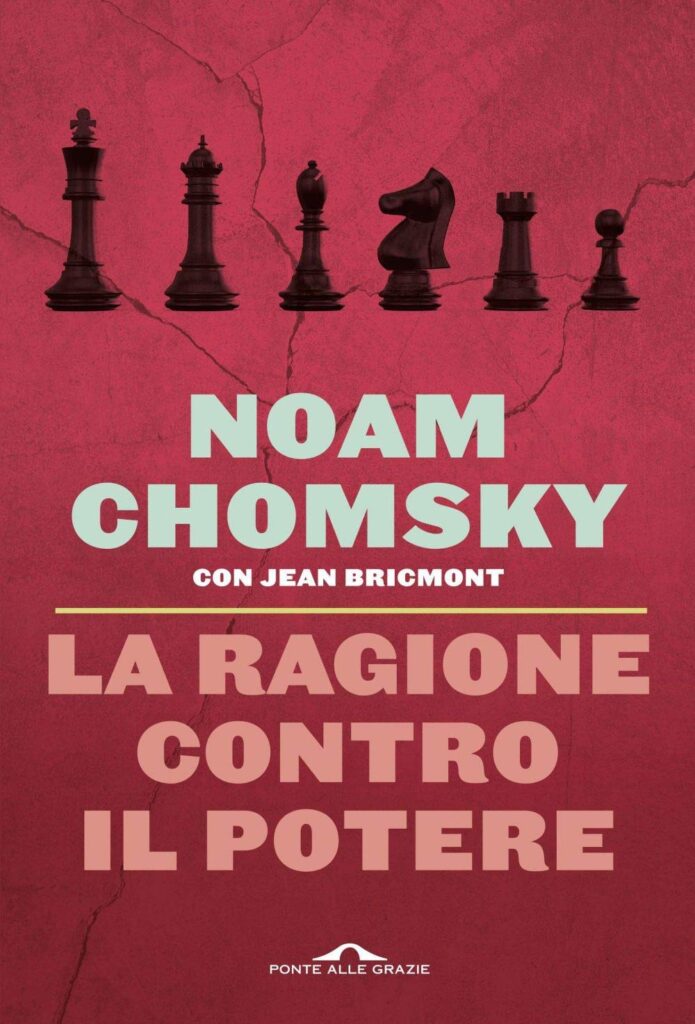
SINTESI DEL LIBRO:
BJEAN BRICMONT
Il punto di vista ottimistico e dominante sull’attuale crisi economica è che si
tratta di un fenomeno temporaneo e che riusciremo a tornare alla situazione
precedente. Per altri, questa crisi è il segno della fine di alcune cose
importanti. Ma di cosa? Della globalizzazione? Del neoliberismo? Del
capitalismo? Della società dei consumi? Dell’era tecnoscientifica?
Dell’Illuminismo? Qual è la sua opinione al riguardo?
NOAM CHOMSKY
In Occidente, per «crisi economica» si intende la crisi finanziaria, che è
indubbiamente molto grave. Il Sud del mondo, da parte sua, vive una crisi
molto diversa e ben più severa. In Bangladesh, sul quotidiano New Nation si
legge ad esempio:
È emblematico che ci si sia affrettati a sborsare migliaia di miliardi di dollari per
rattoppare i principali istituti finanziari del mondo, mentre per fronteggiare la crisi
alimentare è stato erogato solo uno dei 12,3 miliardi – una cifra tutto sommato
modesta – promessi a Roma nel giugno del 2008.
La speranza di sconfiggere la povertà estrema entro la fine del 2015 – uno dei punti
presenti negli Obiettivi di sviluppo del millennio fissati dall’ONU – appare ogni
giorno meno realistica, non per mancanza di risorse, bensì perché non c’è vero
interesse per il destino dei poveri del mondo. 1
E in effetti questo è da ricollegarsi alla crisi finanziaria: il Programma
alimentare mondiale (PAM) dell’ONU ha fatto sapere che dovrà ridurre gli
aiuti alimentari del 20-25% perché i contributi dei paesi donatori sono
diminuiti bruscamente a causa della situazione nei paesi ricchi, dove il
salvataggio delle banche è una priorità ben più importante che non aiutare
oltre un miliardo di persone minacciate dalla fame, una cifra che secondo il
PAM è aumentata di oltre cento milioni lo scorso anno. Quanta importanza
questo tipo di crisi abbia per l’Occidente si evince dalla copertura mediatica
sui suoi mezzi d’informazione: alle dichiarazioni del PAM il New York Times
ha dedicato quindici parole, a pagina dieci, nella sezione «Brevi dal mondo».
Per tornare alla sua domanda, rifacendoci all’idea di Romain Rolland e
Antonio Gramsci sulla necessità di conciliare il pessimismo della ragione con
l’ottimismo della volontà, potremmo pensare, in base al pessimismo della
ragione, che la crisi finanziaria sarà risolta in un modo o nell’altro e la
struttura istituzionale fondamentale rimarrà pressoché intatta. Probabilmente
è corretta la previsione del presidente del prestigioso studio legale Sullivan &
Cromwell: «Dopo aver ricevuto miliardi di dollari dei contribuenti, Wall
Street uscirà dalla crisi in uno stato molto simile a quello in cui si trovava
prima del crollo dei mercati». 2
Simon Johnson, ex capo economista dell’FMI, ne ha precisato le ragioni:
«Durante la crisi, il governo ha avuto cura di non contrastare gli interessi
degli istituti finanziari e di non mettere in discussione i fondamenti del
sistema che ci ha portato a questa situazione». 3 Johnson e altri affermano che
Obama è sotto scacco di Wall Street: nessuna sorpresa, alla luce dei
finanziamenti per la sua campagna elettorale e del fatto che la vittoria alle
elezioni è in gran parte riconducibile al sostegno ricevuto dal settore
finanziario, che lo ha preferito a McCain. Tuttavia, qualcosa sta cambiando.
Il modello della banca d’investimento è in parte naufragato. La mitologia
dominante dei «mercati efficienti» e delle «scelte razionali» è alla deriva, e
probabilmente sarà riconsiderata. Non bisogna dimenticare, però, che i ricchi
e i potenti non sono stati mai così sciocchi da confidare nel «capitalismo del
libero mercato» che invece propinano ai settori più poveri e deboli; in realtà
essi dipendono fortemente dal sostegno dello Stato, ad esempio dalla polizza
assicurativa statale legata al concetto del «troppo grande per fallire», che
incoraggia il rischio estremo e i profitti esorbitanti fino a quando non si arriva
al tracollo, e le finanze pubbliche sono obbligate a salvarli. Accade in
continuazione. Si prenda Citigroup, in procinto di ricevere enormi sussidi dai
contribuenti. Qualcosa di molto simile era già avvenuto agli inizi degli anni
Ottanta, quando l’FMI – praticamente una costola del Dipartimento del
Tesoro statunitense – fungeva da «gendarme della comunità del credito», per
citare l’espressione usata dalla sua direttrice esecutiva americana. Del resto
l’economia industriale avanzata ha sempre fatto affidamento sul settore
statale per la ricerca e lo sviluppo, le commesse militari, i sussidi, i
salvataggi, il protezionismo e i vari stratagemmi che la tengono al riparo dalle
forze di mercato.
L’ottimismo della volontà, d’altro canto, induce a pensare che una
metamorfosi delle istituzioni distruttive che dominano il sistema economico e
politico è possibile, magari creando i presupposti per un’economia sostenibile
associata a una globalizzazione che faccia gli interessi dei popoli, non degli
investitori, e utilizzando a tale scopo i progressi dell’«era tecnoscientifica».
Le possibilità ci sono. Certo, c’è molto lavoro da fare perché si tramutino in
opzioni concrete.
La globalizzazione consentirà al sistema di riformarsi da sé, facendo
emergere un modello neokeynesiano? Oppure i centri economici del potere
sono ormai talmente svincolati dal controllo democratico che è pensabile
soltanto un cambiamento più radicale, di tipo rivoluzionario?
Già adesso il modello neokeynesiano, nella forma di una domanda stimolata
dal governo, è un cardine del capitalismo di Stato, in risposta alla crisi
finanziaria. Da notare, però, come le ricette che i ricchi prescrivono a sé stessi
siano l’opposto di quelle imposte ai poveri.
La popolazione non ha quasi voce in capitolo nella scelta di questo tipo di
politiche. Potrebbe averne di più, ma non avverrà certo in modo spontaneo.
Non dimentichiamo, d’altro canto, che da qualche parte è accaduto
veramente. Il caso più eclatante è forse quello di uno dei paesi più poveri del
Sudamerica, la Bolivia, dove il popolo più oppresso – la maggioranza
indigena – è entrato nella sfera politica, dopo molti anni di lotte coraggiose e
non di rado determinanti, e ha eletto una figura proveniente dalle sue file, con
un programma che rispecchiava la volontà della maggioranza: il controllo
delle risorse naturali, i diritti culturali, la riforma della giustizia e molte altre
cose. Le elezioni boliviane del 2005, e il successivo referendum, sono agli
antipodi del carrozzone della comunicazione occidentale, di cui gli Stati Uniti
sono un fulgido esempio. A esultare per la vittoria di Obama, per esempio,
sono stati i dirigenti delle società di pubbliche relazioni, che l’hanno definita
il loro più grande successo dopo Reagan, e le hanno assegnato il premio
«campagna di marketing dell’anno», preferendola a quella della Apple. È
anche vero che il risultato boliviano è pieno di incognite: le élite storiche,
perlopiù bianche, sono nettamente contrarie a questa vittoria della
democrazia, e ovviamente possono contare sull’appoggio del governo
statunitense qualora volessero ristabilire il vecchio ordine.
Riesce difficile credere, in ogni caso, che i progressi compiuti dal popolo
boliviano siano superiori a quelli che potrebbero raggiungere i cittadini dei
paesi ricchi e potenti. Il cambiamento è davvero possibile, ma non senza un
impegno partecipato e di lungo periodo.
Che cosa ne pensa delle proteste – relativamente – deboli (rispetto agli anni
Trenta) che accompagnano la crisi attuale? Dopotutto, decine di milioni di
persone hanno perduto il lavoro o la casa, eppure non ci sono stati scioperi,
né contestazioni di rilievo o mutamenti politici sostanziali.
La crisi che attraversa oggi i paesi occidentali è certamente grave ma,
quantomeno finora, non è paragonabile agli anni Trenta; e in effetti, a
quell’epoca, le grandi manifestazioni di massa non ebbero luogo che qualche
anno più tardi. Il tracollo economico degli anni Trenta ci ha insegnato quali
contromisure adottare per arginare la crisi presente. In Europa lo stato sociale
ha un effetto anticiclico, un po’ come le politiche neokeynesiane, e in certa
misura agisce da ammortizzatore sociale per le vittime della crisi. Negli Stati
Uniti non è esattamente così, ma sicuramente sono presenti misure maggiori
rispetto alla prima fase della Grande depressione. Negli anni successivi fu
istituito il New Deal, per rispondere alle proteste di massa. Esso si è poi
ampliato, soprattutto negli anni Sessanta, ancora una volta grazie
all’attivismo politico. Nell’era neoliberista quelle conquiste sociali sono state
erose, anche se non completamente. Con il passare degli anni, pur ripetendosi
queste crisi associate al mercato, sono rimasti in vigore taluni meccanismi
che proteggono dai loro effetti più devastanti, oltre che il fondamento teorico
che li giustifica. Ne sono esempio le misure neokeynesiane per stimolare la
domanda.
Qual è il suo punto di vista sui recenti sviluppi in America latina, e in
particolare sulle proposte di Chávez per il socialismo del ventunesimo
secolo?
I passi avanti fatti dall’America latina negli ultimi dieci anni sono
impressionanti. E credo che la Bolivia ne costituisca l’esempio più lampante.
A tal proposito è degna di nota la reazione agli sforzi delle élite storiche
decise a contrastare la minaccia democratica boliviana, sforzi che nel
settembre del 2008 sono sfociati nella violenza, con l’assassinio di moltissimi
contadini. Dopo quell’episodio a Santiago del Cile è stato organizzato un
vertice dell’Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR), in cui i paesi
dell’America latina hanno adottato una dichiarazione congiunta, letta dalla
presidentessa cilena Michelle Bachelet, per esprimere fermo sostegno al
governo Morales. Dopo aver ringraziato per l’appoggio, il presidente
boliviano ha sottolineato che per la prima volta dalla conquista europea
l’America latina ha preso in mano il suo destino senza l’interferenza di una
potenza straniera. Nulla di tutto questo è stato riportato dalla stampa
statunitense.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
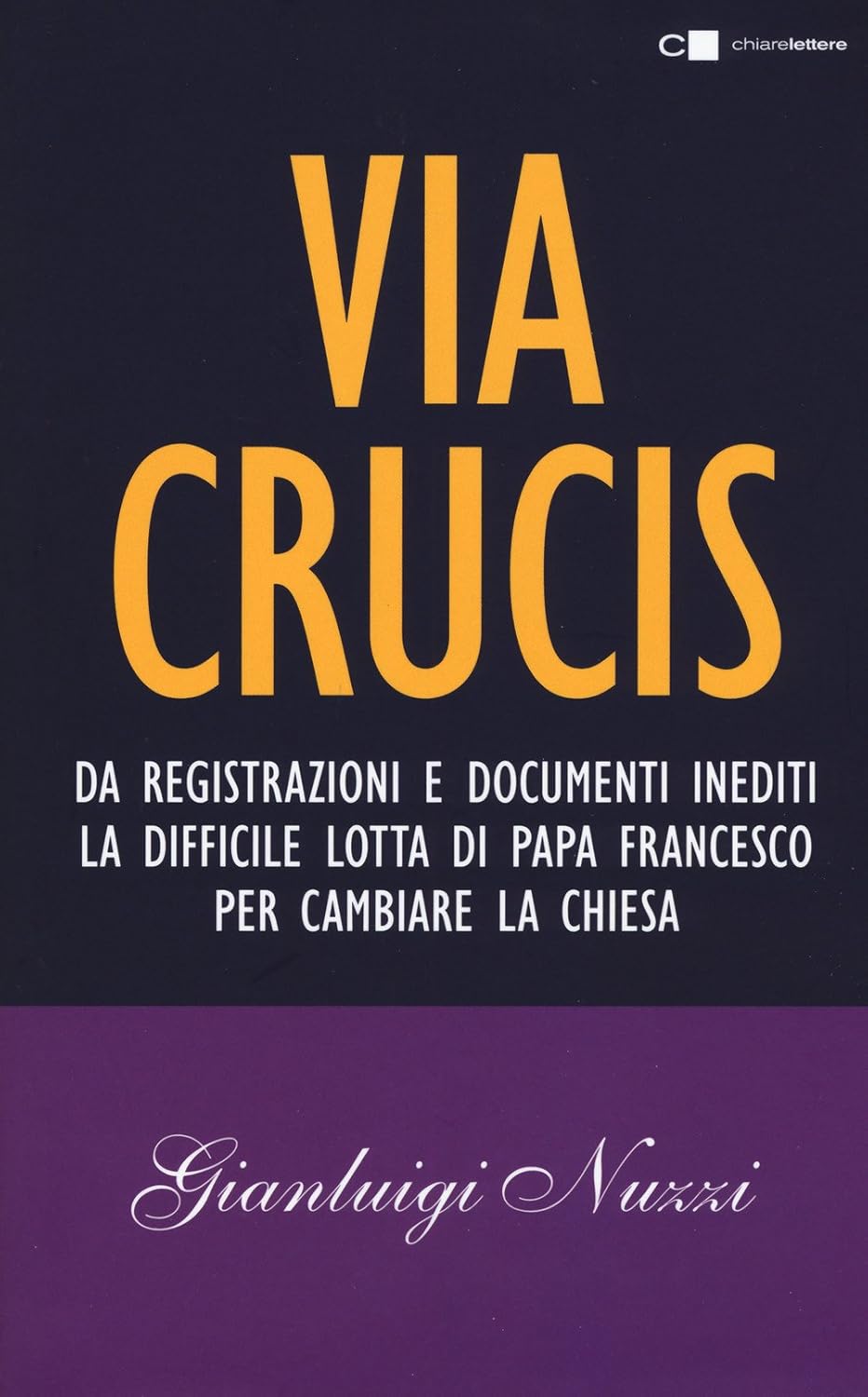






Commento all'articolo