Il Corano e la sua interpretazione – Massimo Campanini
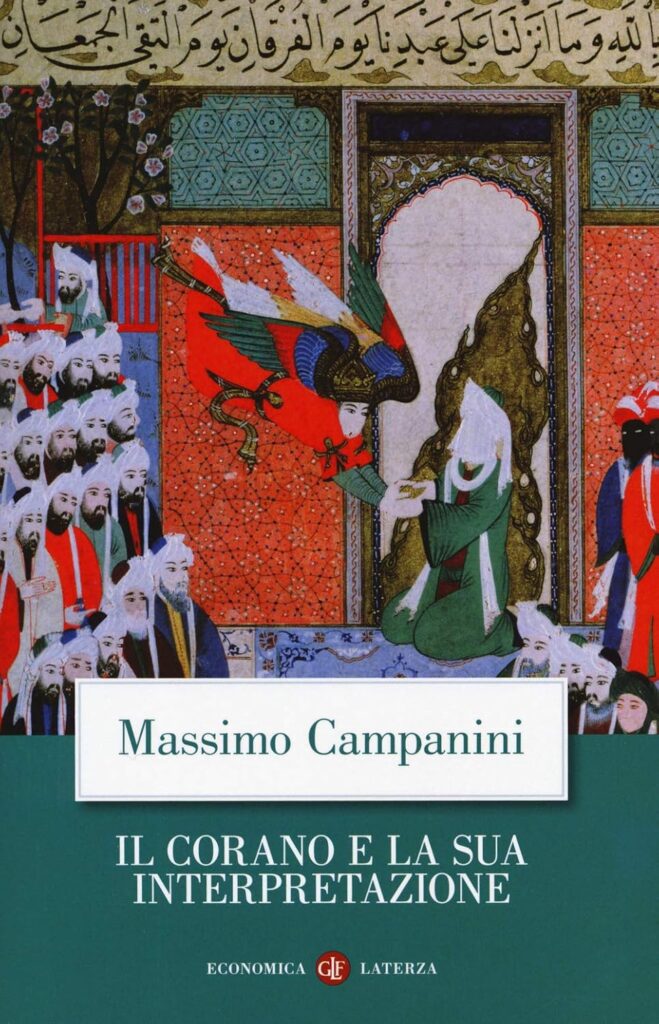
SINTESI DEL LIBRO:
Quando e come è stato composto e messo per iscritto il Corano?
Diciamo subito che parlare di «composizione» del Corano può dar luogo
a fraintendimenti. L’autore del Corano, per i musulmani, è Dio, che
certamente non si è seduto a tavolino a scriverlo. Per i musulmani è
assolutamente inaccettabile, una bestemmia gravissima, dire che l’autore
del Corano è stato il Profeta Muhammad. Ora, il Corano esiste
eternamente presso Dio. In quanto Logos di Dio, sua parola o Verbo, esso
può essere considerato consustanziale a Dio. All’interno della teologia
islamica, fin dai primi secoli (IX-X) si è aperto il dibattito sulla creazione
o meno del Corano: se il Corano, cioè, in quanto parola consustanziale a
Dio sia eterno oppure no. Per la maggioranza dei musulmani, cioè per
l’ortodossia che per l’Islam è un criterio meramente quantitativo, il
Corano è eterno, ma questa conclusione non è stata raggiunta senza
difficoltà. Sostenitori della tesi che il Corano sia creato furono i
mu‘taziliti (una scuola di pensatori influenzati dalla filosofia greca fiorita
in Iraq nel IX secolo dell’èra cristiana), i quali ritenevano che, se il
Corano fosse eterno, si ergerebbe accanto a Dio come una ipostasi, quasi
fosse un secondo Dio, e ciò ne moltiplicherebbe l’essenza facendo correre
il rischio del politeismo. La tesi della increazione del Libro sacro fu invece
sostenuta dagli ash‘ariti (fioriti nel X secolo dell’èra cristiana), una delle
correnti teologiche più autorevoli all’interno dell’Islam classico, per i quali
Dio è loquente per una parola diversa dalla sua essenza, che gli inerisce in
quanto attributo, anche se gli uomini «non sanno come». La posizione
ash‘arita ha trionfato alla fine, per cui può essere considerata «ortodossa»,
cioè in grado di riscuotere l’adesione della maggioranza della Comunità,
anche se la questione della eternità o meno del Corano non è stata una
pura disputa teologica. La dottrina mu‘tazilita, infatti, venne promossa dal
califfo ‘abbâside al-Ma’mûn (813-833) come teologia di stato, e in
particolare la dottrina del Corano creato fu scelta come discrimine per
giudicare ad un tempo della fedeltà al califfo e della ortodossia religiosa. Il
califfo intendeva supportare la sua autorità grazie alla professione del
Corano creato: se infatti il Corano è crea to, può venire modificato,
adattato o comunque piegato alle necessità politiche del momento,
consentendo al califfo una libertà di intervento che la intangibile sacertà
del testo increato non permetterebbe. La vittoria della tesi ash‘arita ha
invece consentito il trionfo della classe degli ‘ulamâ’, i teologi-giuristi
custodi della Legge. È possibile che, se avessero vinto i mu‘taziliti, l’Islam
avrebbe conosciuto una minore «clericalizzazione» della vita politica,
poiché l’influenza degli ‘ulamâ’ sullo stato sarebbe stata minore. Il
problema della creazione del Corano è questione strettamente teologica
oggi recuperata dal razionalismo neo-mu‘tazilita di esegeti come Abû
Zayd. Il Libro stesso non aiuta a dirimerlo, anche se versetti come 13,39 e
85,22, che sembrano affermare chiaramente che un archetipo celeste del
Libro esiste eternamente presso Dio, parrebbero sostenere la soluzione
ash‘arita (si tornerà ancora sull’argomento nel paragrafo IV.1).
In ogni caso, che il Corano sia eterno o meno, Dio ne è l’autore e
Muhammad il Profeta è stato semplicemente il suo recettore.
Muhammad non ha «composto» il Corano: si è limitato a riceverlo e a
comunicarlo ai suoi compagni e discepoli. Originariamente, dunque, la
rivelazione circolava in forma orale ed era memorizzata dai fedeli.
Muhammad la trasmetteva ai compagni più prossimi e questi
provvedevano a diffonderla nella comunità. Del resto, la cultura beduina
era essenzialmente orale e gli stessi certami poetici che si svolgevano alla
Mecca durante le fiere e i pellegrinaggi non prevedevano la stesura scritta
delle composizioni. La questione è importante perché coinvolge un altro
problema di assoluta rilevanza: Muhammad sapeva leggere e scrivere?
Sarebbe stato in grado di vergare su foglio le rivelazioni che riceveva?
L’opinione dei musulmani è che Muhammad fosse illetterato (così viene
interpretato l’attributo di ummî che il Corano riferisce due volte – 7,157 e
158 – al Profeta1), e ciò per la buona ragione che ne risulterebbe
confermato il miracolo straordinario della comunicazione e della
ricezione di un testo così puro e perfetto come quello coranico da parte di
un uomo analfabeta2. Ad ogni modo, anche se Muhammad in persona,
pur sapendo scrivere, non provvide a farlo, esistono fondati indizi che
frammenti del testo, singoli versetti, parti di capitoli o sûre e così via,
furono vergati su supporti di fortuna (cocci, pietre, ossa di animali, foglie
di palma) ancora vivo il Profeta. E ciò, ovviamente, senza che venisse
meno l’abitudine prevalente di conoscere a memoria il Corano e di
trasmetterlo per via orale.
Ora, nelle guerre immediatamente successive alla morte di Muhammad,
molti custodi del Corano (huffâz), molti di co loro, cioè, che lo sapevano a
memoria senza far ricorso a testi scritti, morirono. Ciò spinse il
prestigioso compagno ‘Omar, che sarebbe poi diventato il secondo califfo
(634-644), a persuadere il primo califfo, Abû Bakr (632-634), a
provvedere affinché la rivelazione non andasse perduta. Abû Bakr allora,
nonostante alcune incertezze iniziali dovute al timore di fare qualcosa che
neppure Muhammad aveva osato fare, incaricò un liberto di questi, Zayd
Ibn Thâbit, di raccogliere e recensire su «fogli» (suhuf) gli sparsi
frammenti su cui il Corano era conservato a pezzi, oltre a collazionare le
testimonianze orali dei compagni sopravvissuti.
L’iniziativa di Abû Bakr non condusse immediatamente a una redazione
definitiva e dunque a quella che noi chiameremmo una «composizione»
del Corano. Nelle varie città dell’impero arabo, che intanto si andava
costituendo, circolavano altre versioni di cui erano portatori prestigiosi
compagni e amici del Profeta. Tra esse emersero quelle di ‘Abd Allâh Ibn
‘Abbâs (m. 688), di Ubayy (in Siria) e soprattutto di Ibn Mas‘ûd (a Kufa;
m. 650), che godeva di particolare autorità. Queste versioni differivano in
questioni anche sostanziali: a parte le varianti di lettura, cambiavano il
numero delle sûre, il loro ordine e i loro titoli, addirittura il loro
contenuto. La gravità della situazione convinse il terzo califfo, ‘Othmân
(644-656), a istituire una commissione, di cui faceva parte ancora Zayd
Ibn Thâbit, che lavorò alacremente a preparare una, per così dire, editio
princeps. Il risultato fu però lungi dall’essere soddisfacente anche perché la
lingua araba del tempo non era ancora perfezionata; mancavano
vocalizzazione e segni diacritici e ciò poteva portare a confondere o
fraintendere molte parole. Tuttavia, la redazione othmaniana determinava
definitivamente l’ordine e la lunghezza dei capitoli che ancora oggi
leggiamo. Il califfo provvide poi a far redigere quattro (o, secondo un’altra
versione, sette) copie del testo concordato dalla commissione; a inviarle
nelle quattro principali città dell’impero: Mecca, Kufa, Bassora e
Damasco, e a ordinare la distruzione delle recensioni precedenti.
La tradizione maggioritaria afferma che l’iniziativa di ‘Othmân fu bene
accolta e che lo stesso ‘Alî, che di ‘Othmân era avversario per ragioni
politiche, la accettò. Tuttavia, altre fonti rivelano che non mancarono le
resistenze. Soprattutto Ibn Mas‘ûd si rifiutò di obbedire all’ingiunzione
del califfo e continuò a difendere la maggiore legittimità della propria
testimonianza. Perciò, almeno per qualche tempo, recensioni diverse del
testo coranico da quella stabilita da ‘Othmân sopravvissero e furono
conservate con pia osservanza. I partigiani di ‘Alî, quelli che in seguito
sarebbero diventati gli sciiti, sostennero presto che ‘Othmân e i suoi
collaboratori avevano soppresso dall’autentico testo coranico gli accenni
alla premi nenza del loro capo. ‘Alî e ‘Othmân, infatti, si disputavano il
califfato e ogni mezzo poteva essere lecito per confermare le pretese di
una parte politica sull’altra. Nel determinare questa situazione grande
importanza ebbe la difettosità della scrittura ancora approssimativa
dell’arabo. Basterà fare due esempi3. Il versetto 75,17 suona, nella Vulgata
di ‘Othmân, «a Noi [Dio] (‘alaynâ) spetta raccogliere [la rivelazione]»;
mentre, con una lieve variazione grafica, la versione sciita attribuita a Ibn
Mas‘ûd legge: «al nostro ‘Alî (‘aliyyunâ) spetta raccogliere [la
rivelazione]». Analogamente, il versetto 33,56 ufficialmente suona: «Dio e
gli angeli pregano sul (‘alâ) Profeta»; mentre la versione sciita intende: «Dio
e gli angeli uniscono ‘Alî al Profeta». Insomma, basta una correzione
ortografica per cambiare il senso della parola rivelata e, di conseguenza,
trasformare profondamente la dogmatica attribuendo ad ‘Alî un ruolo
pari o addirittura superiore a quello di Muhammad.
Nulla di realmente importante accadde sotto i primi Omayyadi, ma alla
f
ine del VII secolo il governatore dell’Iraq al-Hajjâj promosse quella
scriptio plena del testo coranico, con la vocalizzazione e i segni diacritici,
che doveva non solo porre fine alle dispute sul contenuto, ma anche
sistematizzare l’ortografia araba. Naturalmente, al-Hajjâj è stato accusato
dagli sciiti di essere uno dei responsabili di quella deformazione del testo
che avrebbe permesso ai sunniti di negare le legittime pretese di ‘Alî. Il
processo di costituzione del testo definitivo del Corano sembra essere
stato tuttavia più lungo, tormentato e complesso e, secondo Blachère,
ancora all’inizio dell’XI secolo non si poteva parlare di una scriptio plena
universalmente condivisa, mentre sarebbe proprio durante l’XI secolo che
si pervenne alla forma definitiva del Corano che possediamo oggi. Bell e
Watt, peraltro, ritengono che il processo di miglioramento della scrittura
fu completato verso la fine del IX secolo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





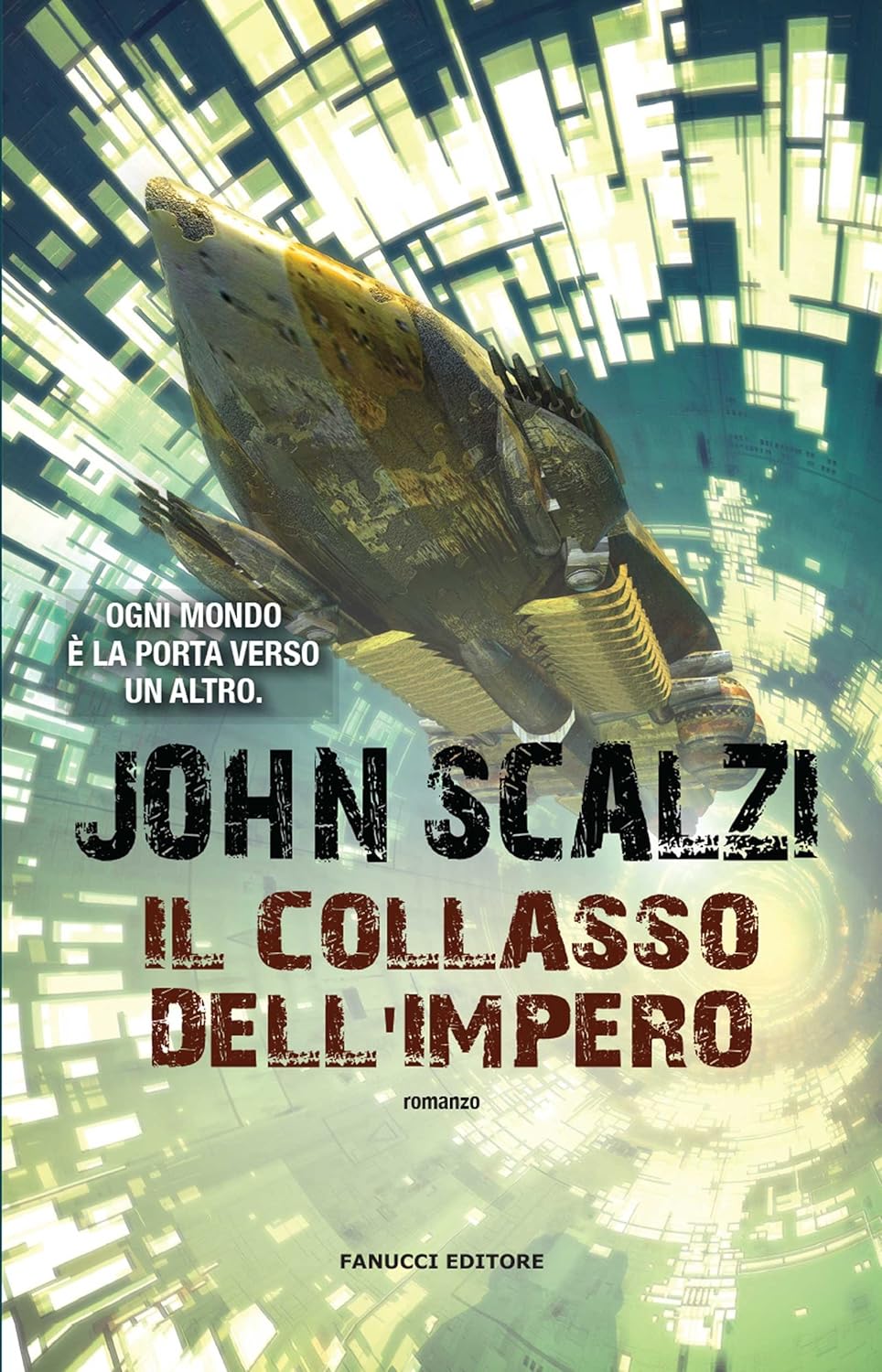
Commento all'articolo