La mia sera del Ventesimo secolo e altre piccole svolte – Kazuo Ishiguro
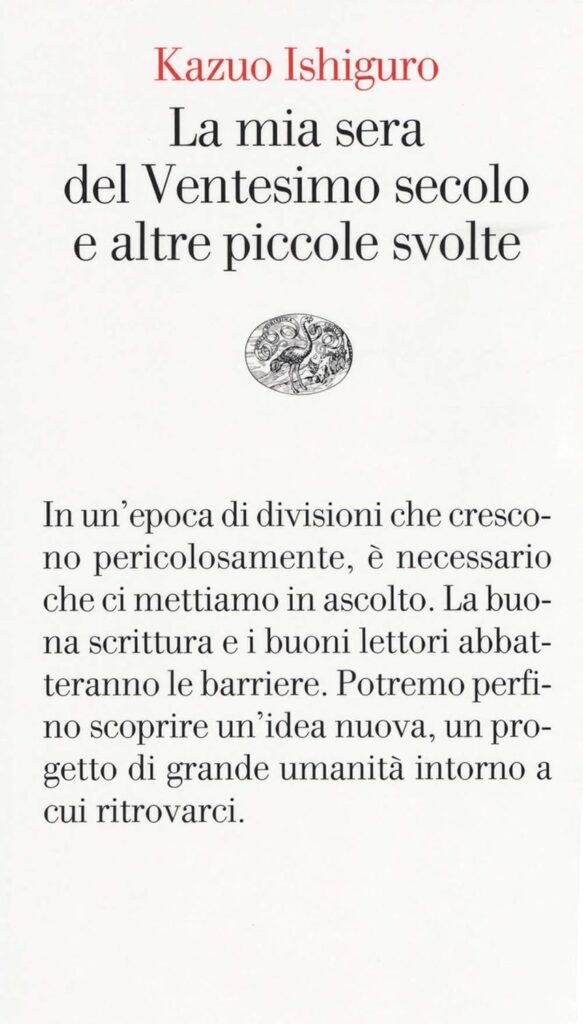
SINTESI DEL LIBRO:
Se qualcuno di voi mi avesse incontrato nell’autunno del 1979, è probabile
che avrebbe avuto qualche difficoltà a classificarmi socialmente e perfino in
base ai tratti somatici. Avevo al tempo ventiquattro anni. I miei lineamenti vi
sarebbero sembrati giapponesi ma, a differenza della maggior parte dei
giapponesi in circolazione in Gran Bretagna allora, io portavo capelli lunghi
sulle spalle e un paio di baffoni spioventi da gangster. L’unico accento
riconoscibile nella mia lingua era quello di un ragazzo cresciuto nel sud
dell’Inghilterra, appena venato, talvolta, dal vernacolo languido e già fuori
moda dell’epoca hippie. Se ci fossimo messi a conversare forse avremmo
discusso di Calcio Totale olandese o dell’ultimo album di Bob Dylan, o
magari del lavoro che avevo svolto con i senzatetto di Londra durante l’anno
appena trascorso. Se vi fosse capitato di nominare il Giappone, o di
rivolgermi qualche domanda sulla mia cultura giapponese, non escludo che
avreste colto un’ombra di insofferenza nella voce mentre dichiaravo la mia
ignoranza imputandola al fatto che da quando me ne ero andato, all’età di
cinque anni, non vi avevo mai piú messo piede – nemmeno per una vacanza.
Quell’autunno ero arrivato con zaino, chitarra e macchina da scrivere
portatile a Buxton, un tipico villaggio del Norfolk con un vecchio mulino ad
acqua e una distesa di terreni agricoli tutt’intorno. Mi trovavo lí perché ero
stato ammesso a un corso annuale postlaurea di Scrittura creativa presso
l’Università dell’East Anglia. La facoltà aveva sede nel capoluogo Norwich,
a una decina di miglia di distanza, ma, non disponendo di un’automobile,
l’unico modo che avevo per raggiungerla era affidarmi al servizio di autobus,
che prevedeva solo una corsa al mattino, una all’ora di pranzo e una serale.
Ben presto, comunque, mi resi conto che non era un problema: la frequenza
al corso non era richiesta piú di un paio di volte a settimana. Avevo preso in
affitto una stanza nella villetta di un uomo non ancora quarantenne che era
appena stato lasciato dalla moglie. La casa doveva essere per lui piena dei
fantasmi dei suoi sogni distrutti, o chissà, forse voleva solo evitare il
sottoscritto; sta di fatto che passavano giorni senza che lo vedessi nemmeno
di sfuggita. In altre parole, dopo la vita frenetica di Londra, mi ritrovavo a
gestire le dosi massicce di silenzio e solitudine che dovevano fare di me uno
scrittore.
In effetti la mia stanzetta ricordava la classica mansarda dell’artista. Il
soffitto aveva una pendenza claustrofobica, anche se, alzandomi in punta di
piedi ero in grado di scorgere, dall’unica finestra, il dispiegarsi a perdita
d’occhio di campi arati. C’era un piccolo tavolo, la cui superficie era quasi
completamente occupata dalla macchina da scrivere e da una lampada. Sul
pavimento, al posto del letto, un vasto rettangolo di gomma piuma che mi
faceva sudare nel sonno, perfino nelle gelide notti del Norfolk.
Fu in quella stanza che analizzai meticolosamente i due racconti scritti
durante l’estate, domandandomi se erano abbastanza buoni da poter finire tra
le mani dei miei nuovi compagni (sapevo che in classe saremmo stati in sei e
che ci saremmo incontrati ogni due settimane). A quel punto della mia vita
non avevo scritto quasi nient’altro di interessante in ambito narrativo,
essendomi garantito l’ammissione al corso grazie al copione di un dramma
radiofonico rifiutato dalla Bbc. A dirla tutta, avendo precedentemente puntato
con forza sull’idea di diventare una rockstar entro i vent’anni, la scoperta
delle mie ambizioni letterarie era cosa piuttosto recente. I due racconti che
andavo ora esaminando erano stati scritti in preda a una sorta di panico, dopo
aver ricevuto la notizia di essere stato ammesso al corso universitario. Uno
dei due era la storia macabra di un patto suicida, e l’altro parlava della
violenza nelle strade scozzesi, dove avevo lavorato per un certo periodo come
operatore sociale. Non erano granché. Ne cominciai un terzo, su un
adolescente che avvelena il suo gatto: anche questo ambientato in Gran
Bretagna e al giorno d’oggi. Poi, una sera, verso la terza o la quarta settimana
in quella stanzetta, mi ritrovai a scrivere con un’intensità e un’energia nuove
del Giappone: specificamente di Nagasaki, la mia città natale, negli ultimi
giorni della Seconda guerra mondiale.
Ci tengo a sottolineare che fu una sorpresa per me. Oggi come oggi, la
tendenza dominante è tale per cui un giovane aspirante scrittore di
provenienza culturale mista sarà spontaneamente portato a esplorare le
proprie «radici» nella scrittura. Ma allora le cose stavano assai diversamente.
Mancavano ancora anni all’esplosione del multiculturalismo letterario in
Gran Bretagna. Salman Rushdie era uno sconosciuto con un unico romanzo
ormai fuori catalogo al suo attivo. Se si domandava a qualcuno di nominare il
piú promettente romanziere britannico del momento, la risposta poteva essere
Margaret Drabble o, tra i piú maturi, Iris Murdoch, Kingsley Amis, William
Golding, Anthony Burgess, John Fowles. Stranieri come Gabriel García
Márquez, Milan Kundera o Borges erano autori per pochi, i cui nomi
risultavano sconosciuti anche a parecchi lettori forti.
La temperie letteraria dell’epoca fece sí che, una volta concluso il mio
primo racconto giapponese, malgrado la certezza di aver scoperto una
direzione nuova e importante, cominciai subito a chiedermi se quel cambio di
ambientazione non sarebbe stato giudicato come un ripiegamento su me
stesso; se non avrei fatto meglio a tornare quanto prima a tematiche piú
«normali». Fu soltanto dopo molte esitazioni che cominciai a far circolare lo
scritto e sono oggi gratissimo ai miei compagni di corso, ai miei docenti
Malcolm Bradbury e Angela Carter e al romanziere Paul Bailey – ospite per
quell’anno a Norwich – per l’incoraggiamento determinante che hanno
saputo infondere nelle loro risposte. Non avrei probabilmente piú scritto del
Giappone, se il loro giudizio fosse stato meno favorevole. Cosí, invece, tornai
nella mia stanza e mi tuffai nella scrittura. Per tutto l’inverno tra il ’79 e l’80
e buona parte della primavera successiva si può dire che non ebbi contatto
con nessuno a parte i miei cinque compagni di classe, il negoziante dal quale
mi rifornivo dei cereali per la colazione e dei rognoni di agnello che mi
garantivano la sopravvivenza, e la mia ragazza Lorna (oggi mia moglie) che
veniva a trovarmi a settimane alterne. Non era una vita equilibrata, ma in quei
quattro o cinque mesi riuscii a completare metà del mio primo romanzo, Un
pallido orizzonte di colline, ambientato anch’esso a Nagasaki negli anni della
ricostruzione dopo la catastrofe della bomba atomica. Ricordo di essermi
trastullato in quel periodo con l’idea di alcuni racconti non giapponesi, ma
solo per sentire il mio interesse scemare rapidamente.
Quei mesi furono decisivi per me; arrivo a dire che senza di essi
probabilmente non sarei diventato uno scrittore. Da allora mi è capitato
spesso di ripensarci e di chiedermi: che cosa mi aveva preso? Da dove
arrivava tutta quella strana energia? Ne ho concluso che proprio a quel punto
della vita mi ero impegnato con fermezza in un’opera di conservazione. Ma
per spiegarla, occorre che faccia un passo indietroSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :







Commento all'articolo