Credere disobbedire combattere- Marco Cappato

SINTESI DEL LIBRO:
L’agente di guardia della stazione di polizia di Stockport, vicino a
Manchester, mi guardò storto. Non tutte le confessioni fanno piacere, e lui
non era affatto contento di sentirsi annunciare «I have some hashish with
me». Un’altra rogna. «Where?» fu la risposta obbligata e meccanica,
accompagnata dalla tenue speranza di un bluff da parte di quel politico
italiano venuto fin lì chissà perché.
Le rogne erano cominciate una settimana prima, quando il mio collega
eurodeputato liberale Chris Davies si era fatto arrestare nello stesso posto e
con identica modalità. Chris aveva voluto così salutare la prima seduta di un
processo intentato dalla giustizia britannica contro gli organizzatori di un
cannabis club che riforniva alcuni cittadini della zona, in particolare persone
affette da patologie per le quali alla cannabis sono generalmente riconosciute
proprietà terapeutiche. Mi presentai alla prima udienza per Chris il 20
dicembre 2001 deciso a non interrompere quella sorta di staffetta ideale
lanciata proprio da Davies: a ogni udienza la sua disobbedienza civile e così
via verso il procedimento successivo. Mi feci dare un pezzo di fumo dai
fornitissimi amici del cannabis club e lo consegnai al poliziotto.
Qualche settimana dopo, il 28 gennaio, quando nella stessa Stockport si
presentò anche Marco Pannella, la polizia britannica capì che era meglio
darci un taglio e decise di interrompere la catena degli arresti, ignorando la
nuova consegna di hashish. Forse non sapevano di trovarsi di fronte alla
stessa persona che trent’anni prima si era fatta arrestare per liberare la prima
ondata di prigionieri del proibizionismo anni Settanta. O forse lo sapevano fin
troppo bene e avevano compreso che, fermando anche lui, di guai ne
sarebbero arrivati davvero troppi.
Tornando a quel 20 dicembre, fui trattenuto in cella fino al giorno seguente
per un interrogatorio immediato. Era la mia prima notte in prigione, in realtà
una celletta singola del posto di polizia, concepita non tanto per i criminali,
quanto per gli ubriaconi acciuffati in risse da pub: luce al neon fissa,
scomodità assoluta, urla belluine da chi sta penando a smaltire la sbornia in
altre celle.
Nei mesi successivi la questione si fece interessante anche sul piano
politico. Il mio obiettivo era che il Regno Unito affrontasse la proposta di
togliere la cannabis dalla tabella delle sostanze più pericolose in base alla
classificazione delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Fino ad allora ogni
tentativo era stato respinto.
Tornai un paio di volte a Manchester per le udienze del processo, che si
concluse il 21 marzo 2003 con una doppia condanna pecuniaria: una multa di
100 sterline e il rimborso dei costi processuali, 1335 sterline. Pagai le spese,
ma rifiutai simbolicamente di pagare le 100 sterline. Appena lo comunicai al
giudice nell’aula del tribunale, fui immediatamente condannato a una
settimana di carcere.
Arrivarono due poliziotti e mi caricarono sul cellulare diretto a
Strangeways, una delle più antiche prigioni del Regno, dall’architettura con
pianta a stella sul vecchio modello panopticon, stile San Vittore o Rebibbia.
Visita medica immediata per me e gli altri nuovi arrivi, cessione degli effetti
personali (incluso l’orecchino con brillantino che mi aveva regalato mia zia
Donatella, e che non mi ridiedero più) e poi lunga traversata del carcere fino
al nostro reparto. Non so se fosse voluto, sta di fatto che il giro turistico
avvenne in orario di celle aperte, con i detenuti in socialità che accolsero noi
matricole a suon di fischi e schiamazzi.
Poi la cella, finalmente… si fa per dire. A memoria direi quattro metri per
due, ma posso sbagliare. Certamente molto piccola, con letto a castello. Il
mio compagno di cella era un ex pugile di colore, condannato a due anni e
mezzo per rapina a mano armata. Un tipo inizialmente davvero troppo
burbero, quasi spaventato (lui di me? possibile?), immerso nella lettura di un
librone dal titolo The Perfect Murderer (L’assassino perfetto). Sembrava uno
scherzo. Scoprii che sapeva parlare quando mi chiese a bruciapelo «Are you
gay?». Non c’era curiosità, ma solo timore con una punta di ribrezzo. Lo
rassicurai immediatamente con assertività eccessiva e maldestra, ma era
proprio ciò che aveva bisogno di sentirsi dire. Da quel momento, i tre giorni
di permanenza a Strangeways – perché la pena si dimezza automaticamente
per buona condotta, anche quando le condanne sono minime – andarono in
discesa.
Nonostante il mio arresto avesse coinciso con le prime giornate della
guerra in Iraq – vanificando così ogni speranza di attenzione da parte dei
media italiani e internazionali – il giornale locale mi dedicò un paginone,
1
suscitando ammirazione e interesse da parte dei compagni di braccio, incluso
il cinese della cella a fianco, arrestato per aver decapitato un connazionale
con la spada (o almeno così voleva la leggenda carceraria).
Il meno impressionato e più critico era proprio il mio compagno di cella, al
quale non andava troppo giù l’idea che quella detenzione, che per lui
significava una lunga separazione dalla famiglia e la perdita del lavoro, per
me fosse una scelta e uno strumento di lotta politica.
Né contribuiva alla serenità della convivenza la televisione fissa su quella
che sembrava la liberazione lampo dell’Iraq, e che l’ex pugile già considerava
(con una certa preveggenza, bisogna riconoscerglielo) una macchinazione
yankee. Il mio racconto su come, al Parlamento europeo, avessimo rilanciato
la proposta pannelliana di esilio per Saddam Hussein e di amministrazione
Onu come alternativa alla guerra gli suonava oltremodo sofisticata. «Fucking
american bastards» era il suo giudizio inappellabile. Non insistetti con i pregi
del modello anglosassone (federalismo, presidenzialismo, collegi
uninominali, turno unico e primarie) o dell’atlantismo, perché ebbi la
sensazione che non sarebbero stati apprezzati.
Alla fine dei tre giorni non ci lasciammo male. Aveva smesso di
rimproverarmi la brevità della mia detenzione e quando l’agente lesse
l’elenco dei prigionieri che tornavano in libertà fu lui ad avvisarmi che con
quel «Cheppeto» si riferivano proprio a me: potevo uscire.
Chi ha fatto il carcere per davvero sorriderà di quei miei tre giorni di
emozione, fierezza e paura, o dell’effetto strano di poter di nuovo camminare
al sole ed entrare in un pub dopo settantadue ore di immobilità, branda, brodo
di caffè, patate e fagioli. Cosa devono essere tre mesi, tre anni, trenta?
La coincidenza temporale con la «liberazione» di Baghdad e la diffidenza
dell’ex pugile mi sono serviti a evitare di raccontare a me stesso di aver
compiuto chissà quale grande impresa. La declassificazione della cannabis da
«B» a «C» arrivò nel Regno Unito per proprio conto, dal 2004 al 2009.
Dopo anni di militanza per la legalizzazione, da ex segretario del
Coordinamento radicale antiproibizionista e promotore dei Parlamentari per
l’azione antiproibizionista, avevo comunque la sensazione di aver finalmente
fatto qualcosa in grado di evocare la realtà vissuta da decine di milioni di
persone punite nel mondo a causa di quella folle guerra che viene spacciata
sotto il nome di «guerra contro le droghe»SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
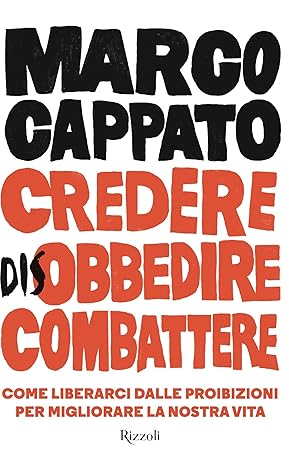



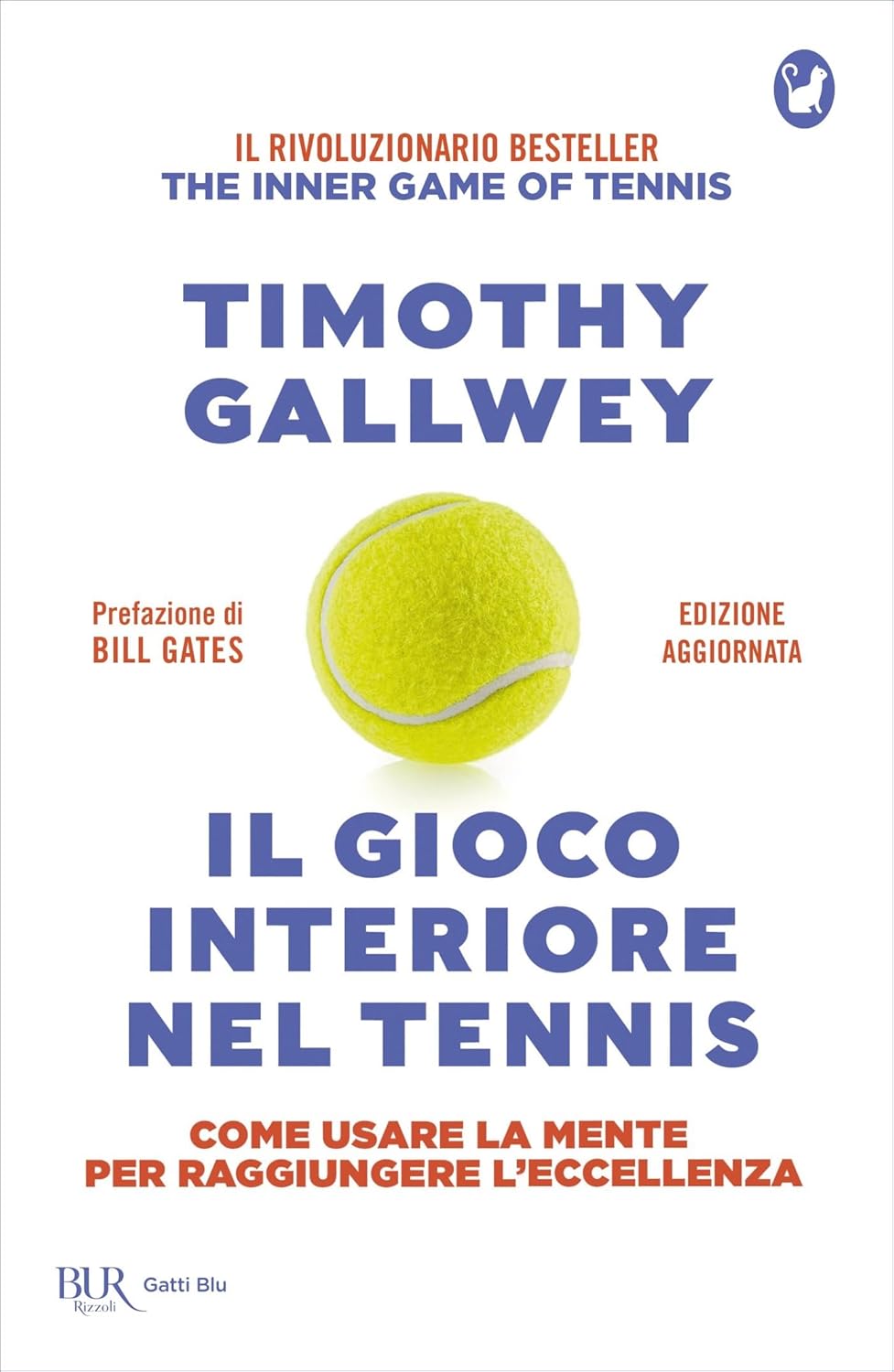
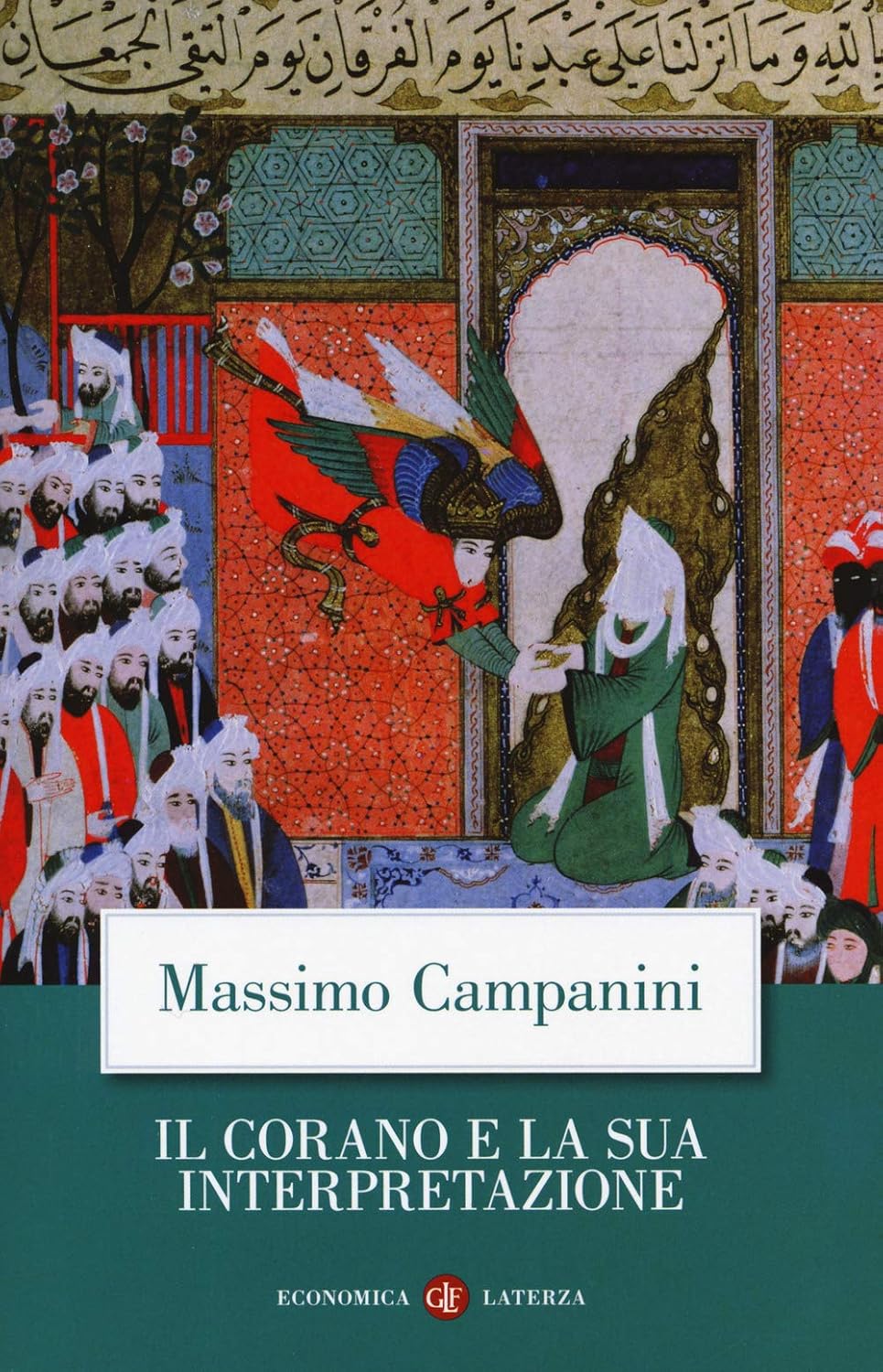

Commento all'articolo