In Patagonia – Bruce Chatwin
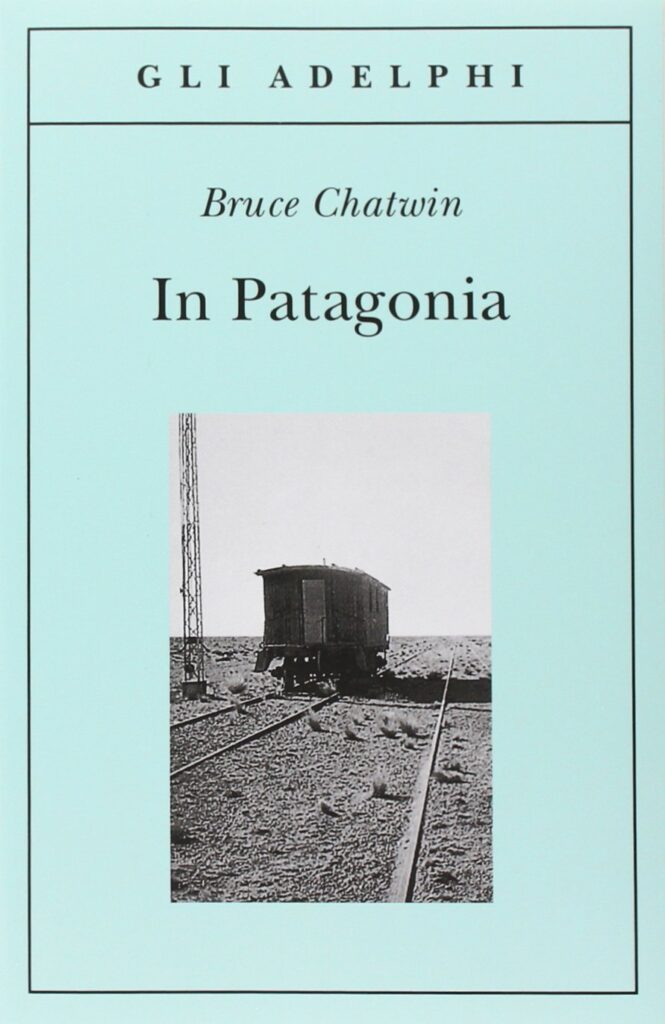
SINTESI DEL LIBRO:
Nel testo non sono citati l’ultimo romanzo simbolico di Jules
Verne, Le phare à la fin du monde, e Last and First Men di W. Olaf
Stapledon, London, 1930. In questa memorabile opera di fantasia, la
specie umana, ormai completamente americanizzata, muore per
epidemie di cannibalismo e per malattie polmonari e nervose. A sud
di Bahia Blanca sopravvivono tuttavia alcuni esseri umani e così nel
Lontano Sud nasce una nuova civiltà, sotto l’influenza di un
adolescente di prodigiosa forza sessuale, conosciuto come ‘Il
Ragazzo che Rifiutò di Crescere’. La civiltà patagonica colonizza il
resto del mondo ma, non essendo meno stupida della precedente, si
autodistrugge con il cataclisma atomico.
Capitano Charles Amherst Milward.
Non avrei potuto scrivere questo libro senza l’aiuto della figlia di
Charley Milward, Monica Barnett, di Lima, che mi ha permesso di
consultare le carte del padre e le sue storie di mare da me, in parte,
qui utilizzate. Un gesto, il suo, particolarmente generoso, visto che
anche lei sta scrivendo una biografia di Milward nella quale le stesse
storie appariranno nella loro interezza.
Bruce Chatwin.
In Patagonia.
Il n’y a plus que la Patagonie, la Patagonie, qui convienne à mon
immense tristesse.
BLAISE CENDRARS, Prose du Transsibérien.
Nella stanza da pranzo della nonna c’era un armadietto chiuso
da uno sportello a vetri, e dentro l’armadietto un pezzo di pelle. Il
pezzo era piccolo, ma spesso e coriaceo, con ciuffi di ispidi peli
rossicci. Uno spillo arrugginito lo fissava a un cartoncino. Sul
cartoncino c’era scritto qualcosa con inchiostro nero sbiadito, ma io
ero troppo piccolo, allora, per leggere.
“Cos’è questo?”.
“Un pezzo di brontosauro”.
La mamma conosceva i nomi di due animali preistorici: il
brontosauro e il mammut. Sapeva che questo non era un mammut. I
mammut venivano dalla Siberia.
Il brontosauro, come poi ho imparato, era annegato nel Diluvio
perché Noè lo aveva giudicato troppo grosso per essere imbarcato
sull’Arca. Me lo figuravo irsuto, con movimenti pesanti e rumorosi,
artigli, zanne e una maligna luce verde negli occhi. A volte irrom-
peva rovinosamente attraverso il muro della mia camera,
svegliandomi di soprassalto.
Questo particolare brontosauro era vissuto in Patagonia, regione
del Sud America all’estremo limite del mondo. Migliaia di anni prima
era caduto in un ghiacciaio, era disceso lungo il fianco di una
montagna in una prigione di ghiaccio azzurro ed era arrivato in fondo
in perfette condizioni. Qui lo trovò Charley Milward il Marinaio,
cugino della nonna.
Charley Milward era capitano di un mercantile colato a picco
all’entrata dello Stretto di Magellano.
Scampato al naufragio si stabilì nelle vicinanze, a Punta Arenas,
dove divenne direttore di un cantiere di riparazioni navali. Charley
Milward me lo immaginavo come un dio fra gli uomini. alto, taciturno
e forte, con neri favoriti e fieri occhi azzurri. Portava il berretto da
marinaio inclinato su un lato e l’orlo degli stivali piegato all’ingiù.
Appena vide il brontosauro spuntare dal ghiaccio capì subito
cosa bisognava fare: lo tagliò a pezzi, salò i pezzi e li mise in barili
che spedì via mare al Natural History Museum di Londra. Nella mia
immaginazione vedevo sangue e ghiaccio, carne e sale, squadre di
indios al lavoro e file di barili lungo la spiaggia: un lavoro gigantesco
e del tutto inutile. Infatti, durante il viaggio attraverso i tropici il
brontosauro si decompose e a Londra arrivò soltanto un ammasso di
roba putrefatta.
Ecco perché al museo si possono vedere le ossa del
brontosauro, ma non la pelle.
Per fortuna, però, il cugino Charley aveva mandato quel pezzetto
di pelle alla nonna.
La nonna viveva in una casa di mattoni protetta da una siepe di
alloro dalle foglie picchiettate di giallo, con alti camini, frontoni
appuntiti e un giardino pieno di rose rossosangue. Dentro si sentiva
odor di chiesa.
Non ricordo molto della mia nonna tranne la sua grande mole.
Solevo arrampicarmi sul suo gran seno oppure osservarla di
nascosto per vedere se riusciva ad alzarsi dalla sedia. Sopra di lei
era appesa una serie di ritratti, grasse e burrose facce di ricchi
olandesi anni-date in bianchi collari. Sulla mensola del camino
c’erano due nanerottoli giapponesi, con occhi d’avorio rossi e bianchi
sporgenti dalla testa come quelli delle lumache. Giocavo con questi
o con una scimmietta tutta snodata, un giocattolo tedesco, senza
tuttavia smettere di tormentare la nonna chiedendole in continuazione di darmi il pezzo di brontosauro.
Mai in vita mia ho tanto desiderato una cosa quanto quel pezzo
di pelle. La nonna diceva che un giorno, forse, l’avrei avuto. E
quando morì io dissi: “Ora lo posso avere, quel pezzo di
brontosauro”. Ma la mamma disse: “Oh, quella roba Ho paura che
l’abbiamo buttata via”.
A scuola risero della storia del brontosauro. Il professore di
scienze disse che mi ero confuso col mammut siberiano. Ai suoi
allievi raccontò di scienziati russi che avevano pranzato con
mammut conjelato e mi disse di non raccontare frottole. Oltre tutto,
aggiunse, i brontosauri erano rettili. Non avevano peli, ma una
corazza di pelle squamosa. E ci mostrò una ricostru-zione
dell’animale eseguita da un disegnatore così diverso da come me lo
ero immaginato color grigio verde, con la testa piccola e una
gigantesca serie di gibbosità lungo le vertebre, nell’atto di mangiare
placidamente erbaccia in un lago. Mi vergognai del mio
peloso brontosauro, ma sapevo che non era un mammut.
Ci vollero parecchi anni prima che la verità saltasse fuori.
L’animale di Charley Milward non era un brontosauro, ma un
milodonte o bradipo gigante. Charley non aveva mai trovato un
esemplare intero e neppure un intero scheletro, ma soltanto un po’ di
pelle e qualche osso, conservati dal freddo, dal secco e dal sale, in
una caverna sul Last Hope Sound, nella Patagonia cilena. Aveva
spedito la sua raccolta in Inghilterra, vendendola al British Museum.
Questa versione della storia era meno romantica, ma aveva il pregio
di essere vera.
Il mio interesse per la Patagonia sopravvisse alla perdita della
pelle, perché la guerra fredda fece nascere in me la passione per la
geografia. Verso la fine degli Anni Quaranta il Cannibale del
Cremlino distese un’ombra sulle nostre vite; poteva succedere di
scambiare i suoi baffi per denti. Ascoltavamo conferenze sui suoi
piani di guerra. Parlando di difesa civile l’istruttore tracciava dei
cerchi intorno alle città d’Europa per mostrarci le zone di distruzione
totale e quelle di distruzione parziale. Le zone erano una accanto
all’altra, senza nessuno spazio fra di loro. L’istruttore portava
pantaloni corti color cachi; le sue ginocchia erano bianche e ossute.
Chiaro che non c’era nessuna speranza; la guerra stava per arrivare
e noi non potevamo farci niente.
In seguito leggemmo della bomba al cobalto, che era peggiore
della bomba all’idrogeno e poteva spia-nare il nostro pianeta con
una reazione a catena senza fine.
Sapevo come era il color cobalto perché l’avevo visto nella
scatola di colori della mia prozia, vissuta a Capri al tempo di Maksim
Gorkij dipingendo nudi di giovani capresi. In seguito la sua arte si era
fatta esclu-sivamente religiosa. Dipinse molti quadri di san
Sebastiano, sempre su sfondo blu cobalto, sempre lo stesso bel
giovane, saldo sulle gambe malgrado le frecce che lo trapassavano
da parte a parte.
Così immaginavo la bomba al cobalto come un den-so cumulo di
nuvole blu, sprigionanti lingue di fuoco ai margini. E vedevo me
stesso, solo su un verde promontorio, scrutare all’orizzonte
l’avanzata delle nuvole.
Eppure speravamo di sopravvivere al flagello. Fu istituito un
comitato di emigrazione e vennero fatti dei piani per andare a
stabilirci in qualche remoto angolo della terra. Studiammo
attentamente gli atlan-ti, individuando la direzione dei venti
predominanti e i luoghi di probabile caduta di piogge radioattive.
La guerra sarebbe scoppiata nell’emisfero nord, per-CIO la
nostra attenzione si rivolse al Sud. Scartate le isole del Pacifico,
perché le isole sono trappole, scar-tate l’Australia e la Nuova
Zelanda, come posto più sicuro della Terra venne scelta la
Patagonia. Immaginavo una bassa casa di legno, col tetto di
assicelle, incatramata per resistere agli uragani, con dentro ciocchi
fiammeggianti e, allineati sulle pareti, i migliori libri: un posto dove
vivere mentre il resto del mondo saltava per aria.
Poi Stalin morì e noi cantammo nella cappella inni di gloria a Dio,
ma io continuai a tenere in riserva la Patagonia.
La storia di Buenos Aires sta scritta nel suo elenco telefonico.
Pompey Romanov, Emilio Rommel, Cre-spina D.Z. de Rose,
Ladislao Radziwil ed Elizabeta Marta Callman de Rothschild ‐ cinque
nomi scelti a caso sotto la R ‐ raccontavano una storia di esilio,
delusioni e ansie nascosta dietro una cortina di merletti.
Ci passai una settimana con uno splendido tempo estivo. I
negozi erano decorati per il Natale. Era stato appena inaugurato il
mausoleo di Perón a Olivos; Eva era in perfetta forma dopo la sua
ispezione alle cassette di sicurezza nelle banche d’Europa. Alcuni
cattolici avevano fatto celebrare una messa in suffragio dell’anima di
Hitler e stavano aspettando un golpe.
Di giorno la città era avvolta da un’argentea nube d’aria
inquinata. Di sera ragazzi e ragazze camminavano lungo il fiume.
Rigidi, lustri di brillantina e con la testa vuota, camminavano a
braccetto sotto gli alberi, scoppiando in gelide risate, separati dal
fiume rosso da una balaustra di granito rosso.
I ricchi chiudevano i loro appartamenti per l’estate.
Bianchi panni venivano stesi sui mobili dorati per proteggerli dalla
polvere e montagne di valigie di pelle si ammucchiavano nelle
anticamere. I ricchi usa-vano passare nelle loro estancias tutta
l’estate. I più ricchi andavano a Punta del Este, in Uruguay, dove il
pericolo di essere rapiti era minore. Alcuni di loro, perlomeno i più
sportivi, dicevano che l’estate era una stagione morta per i rapimenti.
Anche i guerriglieri affittavano case per le vacanze o andavano in
Svizzera a sciare.
Un giorno stavamo mangiando seduti sotto il ritratto di un gaucho
del generale Rosas dipinto da Raymond Monvoisin, un seguace di
Delacroix. Il
gaucho era avvolto in un poncho rosso‐sangue, specie di uomo‐
odalisca, gattesco e passivamente erotico.
“Ci vuole proprio un francese” pensai “per mettere a nudo l’anima
di un gaucho”.
Alla mia destra era seduta una scrittrice. Disse che l’unico
argomento degno di conversazione era la solitudine. Raccontò la
storia di un celebre violinista rimasto bloccato una notte in un motel
del Mid‐West durante una tournée. La storia era imperniata sul letto,
il violino e la gamba di legno del violinista.
Alcuni anni prima aveva conosciuto Ernesto Guevara, allora un
giovane trasandato che si dava da fare per crearsi un posto nella
società.
“Era molto macho” disse “come quasi tutti i ragazzi argentini, ma
non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a tanto”.
La città continuava a ricordarmi la Russia ‐ le auto della polizia
segreta irte di antenne; donne con fianchi massicci che leccavano
gelati in parchi polverosi; le stesse statue gonfiate dalla retorica,
l’architettura da torta nuziale, le stesse strade non proprio diritte, che
danno l’illusione dello spazio infinito e non portano in nessun posto.
La Russia zarista più che quella sovietica. Bazarov potrebbe
essere un personaggio argentino, Il giardino dei ciliegi è una
situazione argentina. La Russia degli avidi kulaki, dei burocrati
corrotti, dei generi colo-niali importati e dei proprietari terrieri con il
pallino dell’Europa.
Dissi tutto questo a un amico.
“Lo dicono tanti” rispose. “L’anno scorso una vecchia emigrata
dalla Russia Bianca venne da noi in campagna. Eccitatissima,
chiese di vedere tutte le stanze. Quando arrivammo su nel solaio
esclamò:
“AIo Lo sapevol L’odore della mia infanzial”SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
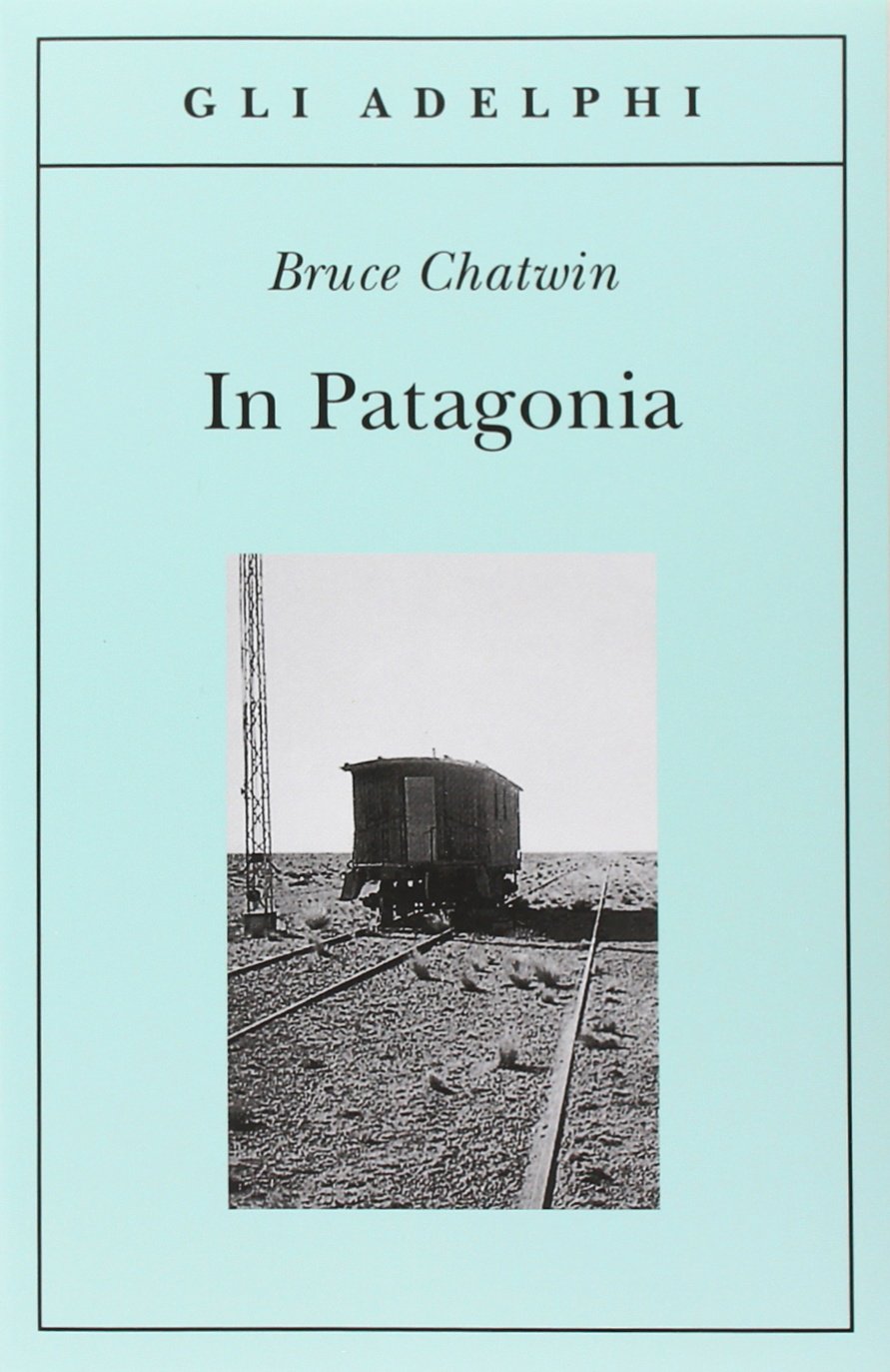





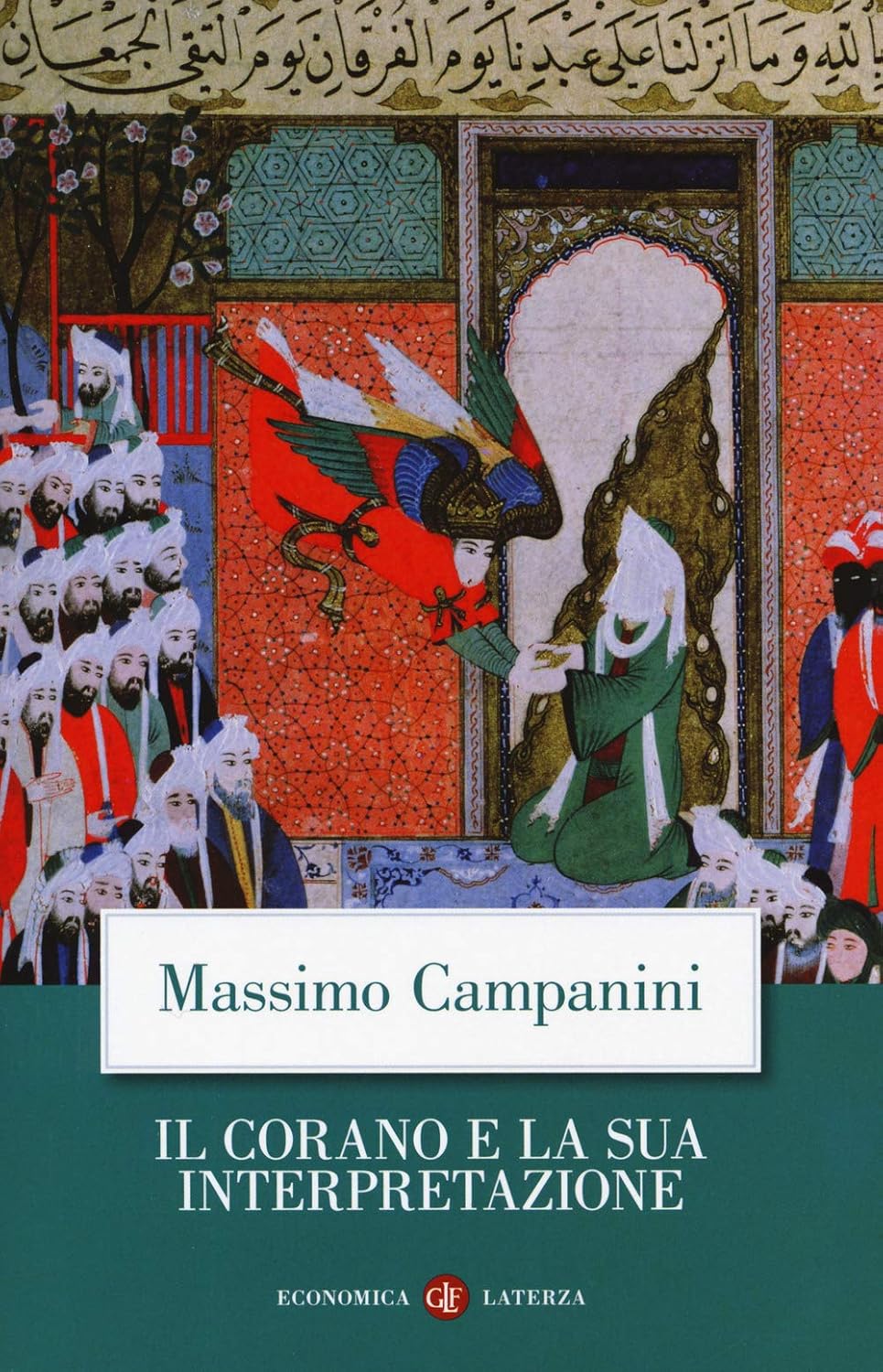
Commento all'articolo