Il dio alieno della Bibbia. Dalla traduzione letterale degli antichi codici ebraici – Mauro Biglino
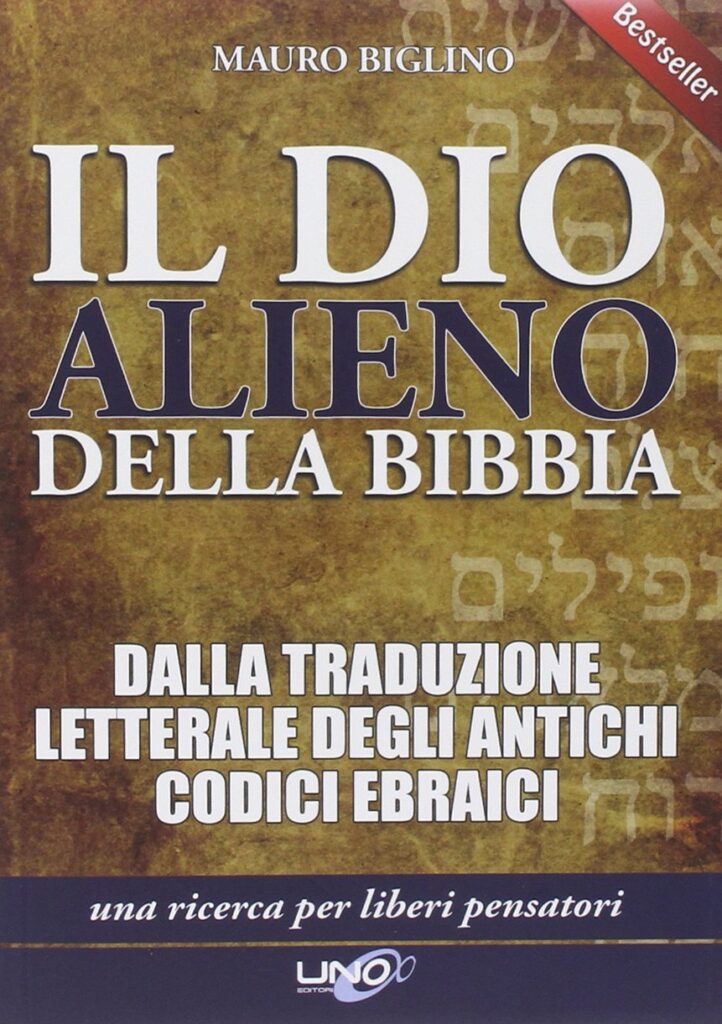
SINTESI DEL LIBRO:
Per chi ha letto e per chi non ha letto…
… il lavoro precedente presentato in calce al presente libro, può essere utile
avere una sintesi dei concetti, delle ipotesi, delle analisi che sono alla base di
quanto si dirà in seguito. Chi conosce il libro in questione richiamerà
facilmente alla memoria i temi affrontati e potrà altrettanto facilmente seguire
la progressione del discorso.
Chi non lo conosce troverà qui una sorta di riassunto pensato per un duplice
scopo: consentire un rapido ingresso in “medias res” e comprendere il
pensiero dell’autore, base tacita di tutte le ipotesi e riflessioni qui
rappresentate e sempre derivanti dal lavoro di traduzione letterale dell’ebraico
masoretico contenuto nel Codice di Leningrado.
3
Un libro di storia?
La Bibbia è stata oggetto delle più diverse chiavi di lettura, per lo più
comprensibili ma talvolta anche eccessivamente fantasiose; ne sono nate così
le interpretazioni teologiche, allegoriche, metaforiche, teosofiche,
antroposofiche, esoterico-iniziatiche, psicanalitiche…
Ogni commentatore, sia esso persona singola oppure organizzazione-chiesa,
ha spesso fatto in modo di trovare nei testi delle conferme alle dottrine o idee
nelle quali crede e sulle quali sono state talvolta anche costruite intere
strutture di potere. Pensiamo alle lotte combattute nel corso dei secoli – a
partire dai primi decenni dell’epoca cristiana – tra i vari gruppi che si
contendevano, e si contendono ancora, il controllo delle coscienze e la
gestione della “verità” dottrinale. Pensiamo alle numerose “teologie”
elaborate, spesso anche in modo fortemente conflittuale, all’interno delle tre
religioni che hanno nell’Antico Testamento la loro radice comune. Nello
sviluppo delle varie dottrine il testo viene spesso piegato alle esigenze degli
interpreti e i suoi significati sono quindi letti alla luce di “verità” la cui
origine, a volte, appare essere addirittura esterna ai testi stessi.
Spesso però la realtà sembra superare ogni possibile volontà interpretativa; a
volte finisce per imporsi a dispetto di chi la vuole ricondurre nei binari
ritenuti funzionali alle convinzioni che si intendono veicolare.
Già Rashi de Troyes – uno dei massimi esegeti ebrei (X-XI sec. d.C.) – aveva
affrontato questo problema non secondario e che per noi è addirittura
determinante agli effetti delle ipotesi analizzate in questi lavori. Egli affermò
che alle parole della Toràh si possono attribuire anche 70 significati diversi,
uno per ciascuna delle 70 lingue nelle quali venne suddivisa la lingua umana
originaria al tempo della costruzione della Torre di Babele, ma – dice appunto
il commentatore – c’è un significato che queste parole “non possono non
avere”: quello “letterale”.
Proprio di questo si tratta: provare a pensare che gli autori biblici ci abbiano
voluto dire esattamente ciò che ci hanno detto, senza dietrologia, senza
misteri da svelare attraverso cammini difficili e oscuri.
C’è un acronimo che racchiude efficacemente i quattro metodi generali che si
possono adottare nello studio della Toràh: [pardès], termine che indica il
“frutteto”.
L’acronimo è composto dalle iniziali di [peshàt], che contiene il semplice
significato letterale e la sua spiegazione; [rèmez], che significa indizio
ricavabile da acronimi o valori numerici; [derùsh], cioè l’interpretazione
omiletica; e infine [sod], l’insieme degli ipotetici segreti cui accede la
kabbalah. Qui ci si attiene al primo dei quattro metodi, nella convinzione
della validità di quanto affermato da Rashi in merito alla presenza certa del
significato letterale.
Nel fare questa scelta rispettiamo soprattutto le intenzioni dello stesso Elohìm
che affermava chiaramente di parlare con Mosè (Nm 12,8):
Proviamo allora a fare un esercizio semplice: consideriamo l’Antico
Testamento come un libro di storia, un testo in cui vari autori di un popolo
hanno voluto raccontare la loro saga. Avendo presenti le precisazioni
riportate nell’introduzione circa la “chirurgia filologica”, procediamo
attribuendo all’insieme dei libri anticotestamentari le caratteristiche di ogni
lavoro storiografico: dobbiamo quindi considerare che essi conterranno
certamente delle verità, ma anche delle falsità, degli errori, delle dimenticanze
accidentali o dei nascondimenti voluti; certi eventi saranno enfatizzati e altri
sottaciuti; i fatti della storia potranno essere interpretati in funzione degli
obiettivi e dei messaggi che l’autore intende veicolare… Insomma, un
normale libro di storia non sostanzialmente diverso da quelli che conosciamo
anche oggi.
A questo proposito, dopo la pubblicazione del lavoro precedente, alcuni
hanno chiesto:
• Ma com’è possibile ricavare simili tesi partendo da un testo così
incerto, scritto in una lingua la cui polisemia pone continui
problemi interpretativi?
Concordiamo con il dubbio di fondo contenuto nella domanda e la
rivolgiamo ai teologi che da 2000 anni su questi “dubbi” hanno costruito
“certezze” attribuendo loro carattere “assoluto” e capace di condizionare e
determinare le sorti della vita eterna di alcuni miliardi di uomini.
Non abbiamo questa pretesa e, consapevoli di percorrere una via irta di
ostacoli, procediamo con la nostra scelta metodologica.
Per entrare nel merito del tema qui posto, va ricordato che una delle
caratteristiche ineliminabili in ogni testo e in ogni tempo è la seguente: gli
autori scrivono utilizzando le categorie culturali, concettuali e linguistiche di
cui dispongono.
Ogni autore è infatti figlio del suo tempo e impiega gli strumenti di
comunicazione che quello specifico tempo gli mette a disposizione. Potrà
farlo con maggiore o minore maestria ma, ad esempio, non potrà usare
termini che ancora non esistono per descrivere realtà nuove e strabilianti.
Sappiamo bene che ci sono varie correnti che tendono a considerare come
mitici gran parte dei racconti biblici; alcuni studiosi negano la stessa esistenza
della figura di Mosè e la veridicità di quanto la Bibbia gli attribuisce.
Ma che la Bibbia sia innanzitutto un libro di storia è ormai ampiamente
documentato dagli studi storici, da evidenze documentali appartenenti ad altri
popoli e dall’archeologia. Molte parti dell’Antico Testamento che erano
considerate mitiche o leggendarie stanno trovando conferme: l’Esodo in
primis, legato alla vicenda delle piaghe d’Egitto e all’attraversamento
“miracoloso” del mare, è esemplare da questo punto di vista.
Ma ci sono altri esempi eclatanti: quanti erano coloro che ritenevano
leggendaria l’esistenza di Ninive, citata solo nella Bibbia, fino a quando gli
scavi non l’hanno portata alla luce?
O quanti erano coloro che negavano l’esistenza del popolo definito Chittim
nella Bibbia, fino a quando non venne scoperta la prima città hittita di
Hattusa in Turchia?
Insomma, il semplice buon senso vuole che per definire o declassare come
leggendari, mitici, allegorici, ecc. i racconti biblici, sia necessario usare
prudenza, perché prima o poi una qualche scoperta potrebbe rivelare che ciò
che si credeva frutto di fantasia corrisponde invece a realtà.
Così come è avvenuto per alcuni racconti contenuti in libri biblici che sono
stati poi corroborati dal ritrovamento di stele e iscrizioni appartenenti ad altri
popoli: il Secondo Libro dei Re (18,13) accenna all’assedio vittorioso che
Sennacherib pose alle città di Giuda nel 701 a.C. e una stele rinvenuta a
Korsabad evidenzia sui suoi rilievi l’assalto alla città giudea di Lachish da cui
Sennacherib invia il suo comandante a Gerusalemme con la richiesta di resa
(2Re 18,19 e segg.). O ancora la scoperta del sito assiro che la Bibbia
conosceva come Resen, la “grande città” (Gen 10,12), che risultava essere un
centro di allevamento di cavalli e il termine ebraico resen indica proprio
“briglia, morso per cavalli”.
L’interpretazione biblica come libro di storia sta seguendo un percorso lungo
il quale si sta avviando anche l’interpretazione dei Veda che, da tradizionali
contenitori di allegorie e miti, stanno divenendo ormai per gli studiosi dei
veri e propri testi storico-cronachistici contenenti il ricordo di vicende di cui
si vanno trovando le testimonianze e conferme archeologiche.
4
La formazione della Bibbia
La nascita di un “libro di storia” come la Bibbia non è stata il prodotto di
un evento rapido e singolare, l’esito di un’ispirazione univoca, bensì il
frutto di una lunga evoluzione protrattasi nei secoli.
Alla base dei primi cinque libri – Pentateuco per i Cristiani, Toràh per gli
Ebrei – ci sono ad esempio varie tradizioni o fonti:
• jahwista, la cui composizione risale al X secolo a.C.;
• elohista, redatta intorno ai secoli IX e VIII a.C.;
• deuteronimista, composta nella seconda metà del VII secolo e
rielaborata alla fine del secolo seguente;
• sacerdotale, composta tra il 550 e il 500 a.C.
Per inciso diciamo che la versione sumera dell’Epica della Creazione – da
cui la Bibbia ha tratto non pochi spunti – è stata scritta probabilmente
intorno al 3000 a.C.
Circolavano in origine racconti su argomenti specifici come le vite dei
patriarchi, le storie di schiavitù e liberazione, il nomadismo nel deserto…; i
primi documenti scritti furono redatti forse tra il XII e l’XI secolo a.C.
La redazione biblica primitiva usava la cosiddetta “scrittura continua” che
prevedeva le sole consonanti scritte senza spaziatura tra le singole parole.
L’inserimento dei segni vocalici avvenne dopo un lungo periodo di
gestazione e un altrettanto lungo lavoro effettuato dai masoreti
5 di varie
scuole: un impegno che è terminato sostanzialmente solo nel X secolo dopo
Cristo.
La divisione in capitoli fu introdotta intorno al XIII secolo d.C. e solo a
partire dal 1528 si iniziò a numerare i versetti.
Dunque si tratta di un’opera che ha conosciuto tempi lunghissimi nel corso
dei quali è stata narrata, tramandata oralmente in parti separate, scritta,
vista, rivista, smarrita, ritrovata, riscritta, riletta e poi, in un qualche modo,
resa “intoccabile” con l’apposizione dei segni vocalici che ne hanno fissato
in via definitiva i significati.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
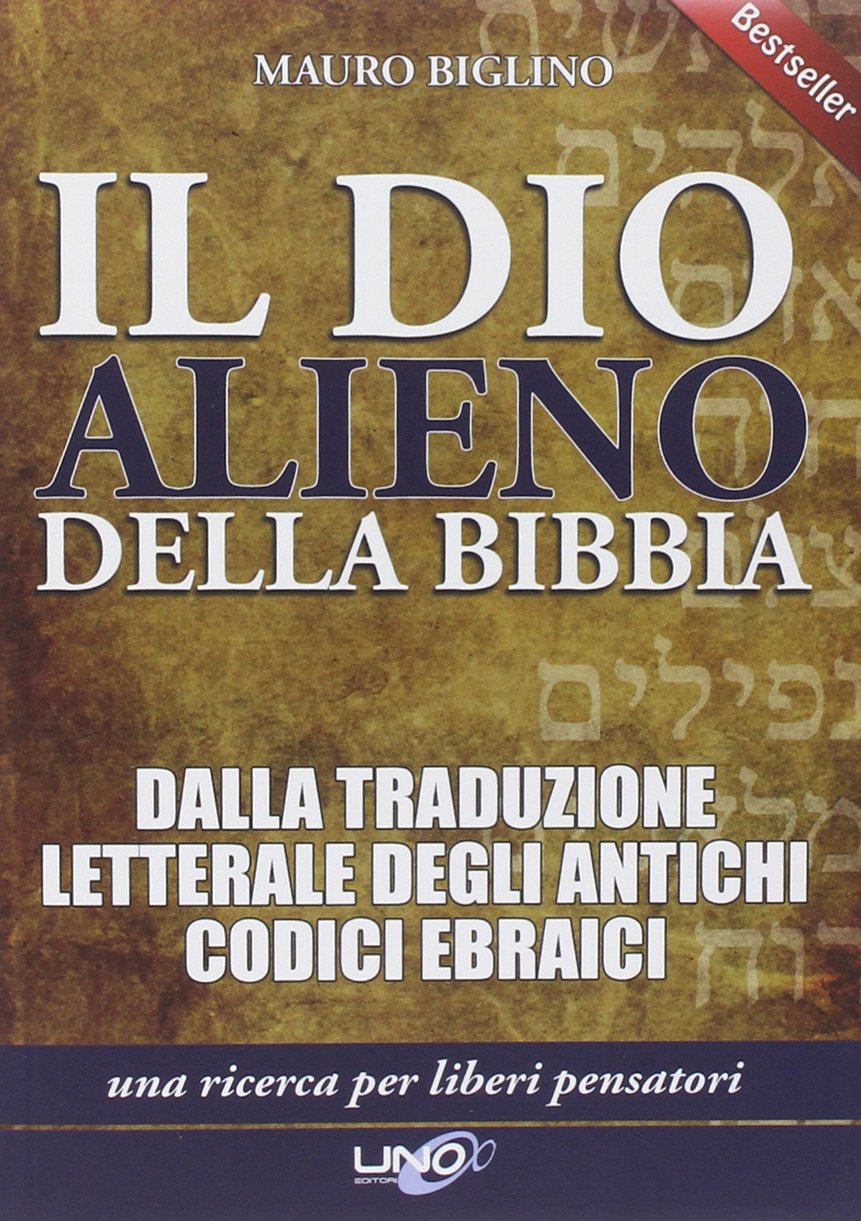






Commento all'articolo