I misteri della sinistra: dall’ideale illuminista al trionfo del capitalismo assoluto – Jean-Claude Michéa
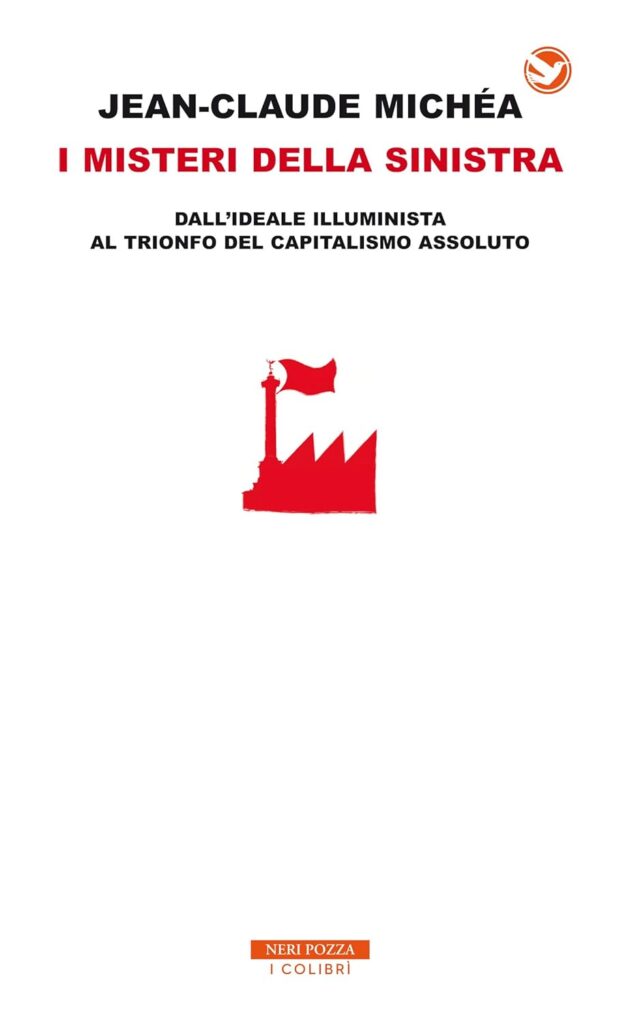
SINTESI DEL LIBRO:
Con ogni evidenza, io e Florian Gulli condividiamo un certo numero di
analisi correnti sulla natura del liberalismo realmente vigente e della sua
logica disumanizzante, non ugualitaria e predatrice sul piano ecologico.
Tuavia (ed è forse la principale differenza tra noi due) è chiaro che il mio
interlocutore non approverebbe il giudizio formulato da Cornelius
Castoriadis – già un quarto di secolo fa – secondo il quale «da molto
tempo il divario destra-sinistra, in Francia come altrove, non corrisponde
più né ai grandi problemi del nostro tempo né a delle scelte politiche
radicalmente opposte le une rispeo alle altre»1. Ora, posto che la
possibilità di riunire il popolo aorno a un programma di uscita dal
capitalismo dipende, in gran parte, dall’esperienza preliminare di un nuovo
linguaggio comune che possa essere compreso – e acceato – tanto dai
lavoratori stipendiati quanto da quelli autonomi, dai dipendenti statali
come da quelli del seore privato, e dai lavoratori autoctoni come da quelli
immigrati (in altre parole, un linguaggio che permea di «risolvere
dialeicamente» – a differenza di un’alleanza puramente eleorale – le
diverse contraddizioni in seno al popolo), la questione del «significante
principale» aorno al quale una tale alleanza potrebbe stringersi riveste
effeivamente un’importanza decisiva. Cercherò dunque di esporre per
quali ragioni sono giunto a pensare che il nome di sinistra non sia oggi
davvero più in grado di svolgere in maniera efficace questa funzione.
Portando avanti questa tesi, va da sé che neppure per un istante potrebbe
passarmi per la testa l’idea di negare che un tale significante politico abbia
potuto funzionare a lungo come un totem unificatore finché si traava di
far cadere, uno dopo l’altro – come accadeva in genere nel corso del
periodo storico che va dalla Restaurazione alla Liberazione –, gli ultimi
bastioni della «Reazione» (con tale parola, oggi usata spesso a vanvera, io
intendo quelle forze sociali e politiche precapitaliste – zoccolo duro della
destra «balzachiana» e controrivoluzionaria del XIX secolo – che
pensavano ancora di poter conservare, o persino restaurare, le basi
tradizionali dell’Ancien Régime, a cominciare dal potere tutelare che la
Chiesa caolica ha esercitato a lungo sulla società francese e, in
particolare, sul mondo rurale). Ma ho l’impressione, invece, che tale
significante diventi molto presto ambiguo – e forse anche inutilmente
divisorio – a partire dal momento in cui si traa, come appunto adesso, di
mobilitare l’immensa maggioranza delle classi del popolo (senza la
partecipazione aiva – o almeno senza la neutralità benevola – di
quell’immensa maggioranza, ogni tentativo di uscire dal capitalismo e dal
suo condizionamento struurale alla «crescita» sarebbe in effei destinato
irrimediabilmente a conoscere un epilogo «alla cilena») non più contro
fantasmatiche forze del passato (la famiglia patriarcale, le «case di
correzione», il dirio di primogenitura o l’«alleanza del trono e
dell’altare») ma proprio contro una società capitalista ormai pienamente
moderna (ciò che prima del Maggio ’68 era ancora lontano dal compiersi) i
cui poteri di seduzione e manipolazione sono cresciuti in modo smisurato
(in particolare nei confronti dei giovani). Una società divisa in classi
profondamente inedita perché, a differenza di tue le civiltà che l’hanno
preceduta nella storia, trova il vero fondamento del proprio sviluppo nella
mobilità continua (o «flessibilità») delle persone che essa contribuisce a
sradicare [A] e in una rivoluzione culturale permanente (della quale
l’universo della moda rappresenta il paradigma privilegiato) che la porta
in modo inesorabile – nel nome del «progresso» e della «modernità» – a
«profanare tuo quello che era sacro» e ad annegare così l’eredità morale
e spirituale dei popoli «nelle gelide acque del calcolo egoista» (Marx).
Non starò qui a dilungarmi sulla tesi che ho sviluppato nel Complesso
d’Orfeo (Edizioni per la Decrescita Felice) e che del resto Florian Gulli ha
riassunto perfeamente. Mi limiterò soltanto a ricordare – ma questo
semplice ao dovrebbe bastare a risvegliare il nostro senso critico – che né
Marx né Engels (comunque non più delle altre grandi figure fondatrici del
movimento socialista e anarchico) hanno mai pensato una sola volta di
definirsi «uomini di sinistra» [B]. Ai loro occhi – e quando gli capitava di
usare quel vocabolario proveniente dal «gergo parlamentare» (come
osserva Tocqueville nei suoi Ricordi del 1850) –, la «destra» designava
l’insieme dei partiti ritenuti rappresentativi degli interessi (a volte
contraddiori) dell’antica aristocrazia terriera e della gerarchia caolica.
Mentre la «sinistra», anch’essa molto divisa, costituiva il punto di
adesione politica delle diverse porzioni della «classe media» (secondo
l’espressione allora in uso), dalla grande borghesia industriale e liberale –
generalmente vicina alle «libertà necessarie» di Adolphe iers – fino alla
«piccola borghesia» repubblicana e «radicale» («la boega e l’officina»)
ancora molto segnata, all’epoca, dalla tradizione giacobina (si noti che,
nella pratica, tale schema chiedeva sempre di essere ammorbidito, come
peraltro testimonia l’importanza del «centro» in tue le combinazioni
parlamentari del XIX secolo). anto al movimento operaio socialista –
nella misura in cui aveva bisogno di contestare al tempo stesso la
dominazione «feudale» e quella del capitale (dunque tanto la vecchia
destra monarchica e clericale di un Joseph de Maistre e di un Louis de
Bonald quanto la giovane sinistra liberale e repubblicana di un Benjamin
Constant, di un Frédéric Bastiat o di un John Stuart Mill) –, si faceva un
punto d’onore nel mantenere in ogni circostanza la sua preziosa
indipendenza politica e organizzativa (posizione intransigente che resterà,
fino alla Prima guerra mondiale, quella dei sindacalisti rivoluzionari).
Del resto non è forse inutile ricordare qui al leore che simpatizza per
la sinistra contemporanea (troppo spesso condizionato da un secolo di
storiografia «repubblicana» e di retorica eleorale «progressista») che le
due repressioni di classe più feroci, e dunque più pesanti sul piano delle
viime, che si sono abbaute nel XIX secolo sul movimento operaio
francese (con il plauso – non è neppure il caso di dirlo – della destra
monarchica e clericale) sono state ogni volta decise da un governo liberale
o repubblicano (dunque di «sinistra», nel senso streo della parola).
Innanzituo quella ordinata da Louis-Eugène Cavaignac, all’epoca delle
giornate di giugno del 1848 (Cavaignac sarà del resto il principale
candidato di sinistra alle elezioni presidenziali di dicembre – il che spiega
in parte il voto reaivo di molti operai parigini per Luigi Napoleone
Bonaparte). E poi quella, ancora più spietata, direa da Adolphe iers
contro la Comune di Parigi nel maggio del 1871 [C]. Si capisce quindi che
la maggior parte degli anarchici e dei socialisti dell’epoca avrebbe trovato
particolarmente assurdo e indecente chiedere agli operai che erano appena
sfuggiti a quei massacri (o che si trovavano ancora deportati in Nuova
Caledonia o esiliati in Inghilterra) di riconciliarsi al più presto – col
pretesto di una più che vaga «unione della sinistra e di tue le forze
progressiste» – con alcuni dei loro più odiosi carnefici (come per esempio
quel sinistro Gaston de Galliffet – il «macellaio della Comune» – che nel
1899 occuperà ancora un posto decisivo nel governo di «difesa
repubblicana» di Waldeck-Rousseau). È dunque solo nel quadro preciso
dell’affaire Dreyfus (del resto le organizzazioni socialiste avevano aeso
quaro anni prima d’impegnarsi in quella che Guesde e Jaurès avevano in
un primo tempo definito una «guerra civile borghese»), e solo di fronte
alla minaccia imminente di un colpo di Stato della destra monarchica e
clericale, che le organizzazioni socialiste rappresentate in Parlamento
(tranne, di conseguenza, i sindacalisti rivoluzionari) acceeranno
finalmente di negoziare un compromesso deo di «difesa repubblicana»
con i loro vecchi avversari della sinistra parlamentare. el compromesso
– vissuto all’inizio come puramente provvisorio – non è soltanto ciò che
costituisce il vero ao di nascita della sinistra moderna; esso è anche, per
forza di cose, uno dei punti di maggiore accelerazione di quel lungo
processo storico che avrebbe pian piano condoo alla dissoluzione della
specificità originaria del socialismo operaio e popolare in quello che si
sarebbe ormai chiamato il «campo del Progresso». Processo di
dissoluzione che – in ragione dell’egemonia intelleuale allora esercitata
dal Partito radicale – sarà d’altronde posto in frea soo il segno
privilegiato del «movimento illuminista» e della loa contro il
«clericalismo» e la «Reazione» (il che spiega, in parte, le ricorrenti
difficoltà che da lì in poi saranno quelle della nuova «sinistra socialista»
nel pensare il capitalismo in maniera diversa rispeo a un sistema
fondamentalmente «conservatore», «reazionario» e volto al passato).
Senza l’esistenza di quel pao d’integrazione progressiva del movimento
operaio socialista nella sinistra borghese e repubblicana di Émile Combes,
di Joseph Caillaux o di Georges Clemenceau – integrazione della quale
Jean Jaurès avrebbe prodoo una brillante legiimazione filosofica –,
evidentemente sarebbe impossibile capire il significato particolare che la
parola «sinistra» avrebbe poi avuto nel corso di tuo il XX secolo [D].SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
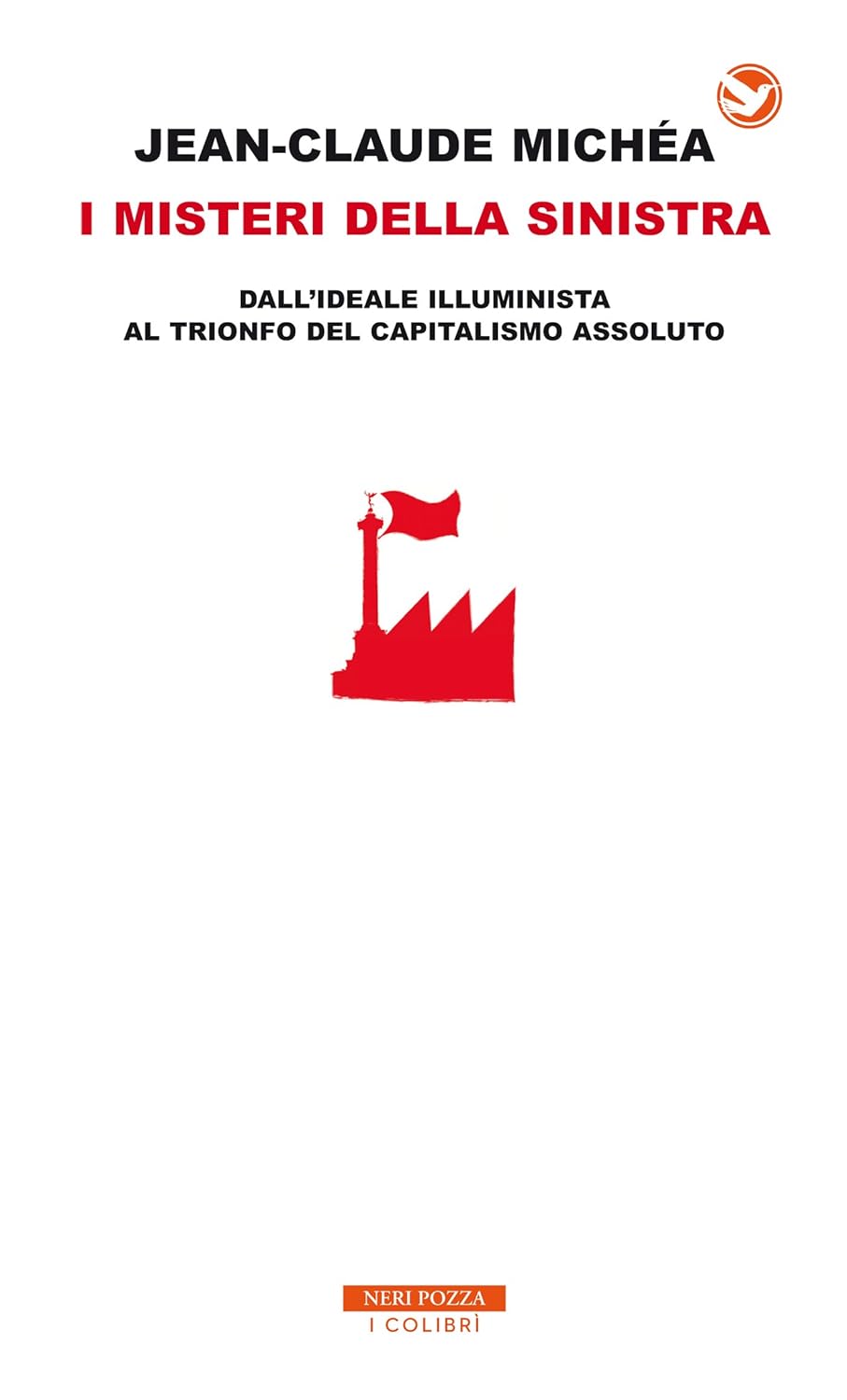






Commento all'articolo