Come funzionano i servizi segreti – Aldo Giannuli

SINTESI DEL LIBRO:
1. Il mito della spia
Una donna incantevole seduce un altissimo ufficiale che, obnubilato dalla
seduzione, finirà per rivelarle qualche segreto militare.
Un vecchio gentiluomo in pensione lascia il giardinaggio per dedicarsi alla
creazione di una organizzazione di persone addestrate per le più spericolate
azioni dietro le linee.
Un uomo atletico e affascinante affronta e sgomina, a colpi di karate, sei o
sette agenti avversari e porta in salvo dei documenti trafugati, scappando su
una potente vettura munita di mille trucchi.
Sono alcune delle più consolidate immagini della spia diffuse da decenni di
letteratura e cinema in tema (la spy story, appunto). Matha Hari, William
Stephenson,1 ma soprattutto James Bond, l’agente segreto per eccellenza;
dopo di lui 007 diventerà il sinonimo più utilizzato per dire spia o agente di
un servizio segreto, anche in riferimento a personaggi lontanissimi dal
raffinato e aitante protagonista dei romanzi di Ian Fleming, ispirato alla figura
di Porfirio Rubirosa.
Il celeberrimo playboy aveva sposato Flor de Oro Trujillo, figlia del
sanguinario dittatore di Santo Domingo, e, a soli ventisette anni, divenne
ambasciatore a Berlino. Eminenza grigia del regime trujillista, ne diresse i
servizi di polizia e per questo fu sospettato di aver ordinato l’uccisione di
diversi oppositori. Fu anche ambasciatore a Cuba durante la dittatura di
Fulgencio Batista. Dopo la rivoluzione, tentò di trovare qualche
accomodamento con il governo castrista, ma con poco successo. Svolse molte
operazioni di intelligence, ma tutto questo fu soverchiato dalla sua immagine
mondana: ebbe donne bellissime, sposandone alcune, come l’attrice francese
Odile Rodin, e fu il protagonista indiscusso del jet set e idolo della stampa.
Morì da par suo nel 1965, schiantandosi, completamente ubriaco, contro un
albero del bois de Boulogne a Parigi.
Ma Rubirosa fu solo un’eccezione: in fondo, non è molto facile trovare una
persona che ha pranzato con Goebbels e con Guevara, con Kennedy e con
Laval, con Péron e con Agnelli. Ugualmente, il suo fantasma di celluloide
divenne l’archetipo della categoria, coronando il processo di costruzione del
«mito della spia».
Spia non è più solo il sinonimo di persona sleale e abietta, come era sino a
un passato non troppo lontano: il delatore Michonneau di Balzac è anche più
spregevole dell’ex galeotto Vautrin; il signor Verloc di Conrad – l’«agente
segreto» – è un personaggio ignobile, come lo è anche il Serge Pluvinage
della Cospirazione di Nizan.
Dopo la Prima guerra mondiale, l’agente segreto inizia a mano a mano ad
acquisire un alone romantico, eroico, eccezionale. Anche quando non gioca
dalla parte dei «buoni», la spia è sempre presentata come una persona
straordinaria. E pour cause: chi non ricorda Sean Connery nei panni di James
Bond, Greta Garbo in quelli di Matha Hari e David Niven in quelli di
William Stephenson? Mentre un film su Monsieur Travet difficilmente
avrebbe lo stesso successo.
La svolta avviene intorno agli anni Trenta, grazie a due grandi registi: Fritz
Lang e Alfred Hitchcock. Il primo, con il cortometraggio muto Lo spione
(1928), illustra la figura del perfido Haghi, capo di una organizzazione
spionistica antinazionale combattuta dall’agente 324. Quest’ultimo riesce
infine a sconfiggere Haghi debellandone l’organizzazione. Dunque, la spia
non è solo la figura negativa (Haghi) ma anche quella positiva (l’agente 324)
che affronta la prima sul suo stesso terreno. Successivamente, Lang realizzerà
Prigioniero del terrore (1944), tratto dal romanzo Quinta colonna di Graham
Greene, che ripropone lo stesso schema. Il film è tutto giocato sulla suspence
che da questo momento in poi caratterizzerà il genere.
Hitchcock, invece, sceglierà la nota più tranquillizzante dello humour – pur
con la necessaria nota thriller – a iniziare con Il club dei 39 (1935) e L’agente
segreto (1936). Anche in questi film, il messaggio che arriva allo spettatore è
che per sconfiggere le spie occorre affrontarle sullo stesso piano e, dunque, ci
sono spie «cattive» ma anche spie «buone».
Entrambi questi registi rendono la figura della spia una presenza familiare
allo spettatore. Un pezzo del paesaggio novecentesco.
Dopo verranno altri film che proporranno una realtà ben più complessa e
un’immagine decisamente meno «eroica» della spia. Tanto per fare qualche
esempio: L’amerikano di Costa-Gavras, Ipcress di Sidney J. Furie, I tre
giorni del Condor di Alan Pakula o, più recentemente, Syriana di Stephen
Gaghan. Anzi, nella maggior parte di questi casi, si tratta di personaggi
tormentati, contraddittori, non esenti da paure e debolezze. Oppure torna
l’immagine torbida della spia in Triple agent di Eric Rohmer o in Il
colonnello Redl di István Szabó. Ma, pur sempre, questi personaggi godono
della luce riflessa delle intricatissime storie che vivono: sinistri bagliori che
ne ingigantiscono la figura umana, come in un gioco di ombre cinesi.
Tutto questo ha sedimentato un immaginario fatto di uomini eccezionali o
resi tali dalle storie fuori dal comune che vivono. Ma quanto c’è di vero in
questa immagine? Certo, Matha Hari è esistita storicamente, e sia Philip M.
Santore («l’amerikano») sia William Stephenson e James Bond sono stati
ispirati da personaggi reali. Inoltre, nella storia dell’intelligence non mancano
imprese spettacolari; ma si tratta, appunto, di casi straordinari. In realtà, la
maggioranza degli uomini dei servizi segreti conduce una vita assai meno
avventurosa, anche se non si tratta propriamente di Monsieur Travet.
Come vedremo, l’intelligence è un lavoro fatto di molta routine, di tante
conversazioni e di una grande quantità di ore a tavolino. E, anche se non
mancano, le «azioni speciali» non sono il cuore del sistema. A volte le
operazioni dei servizi assumono forme molto diverse da quelle che l’opinione
pubblica immagina. Magari si tratta di operazioni culturalSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
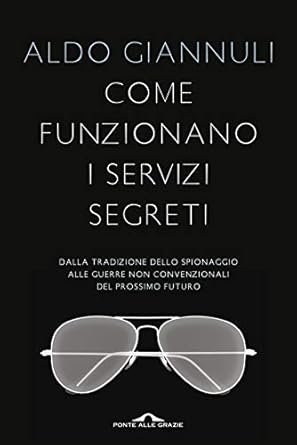





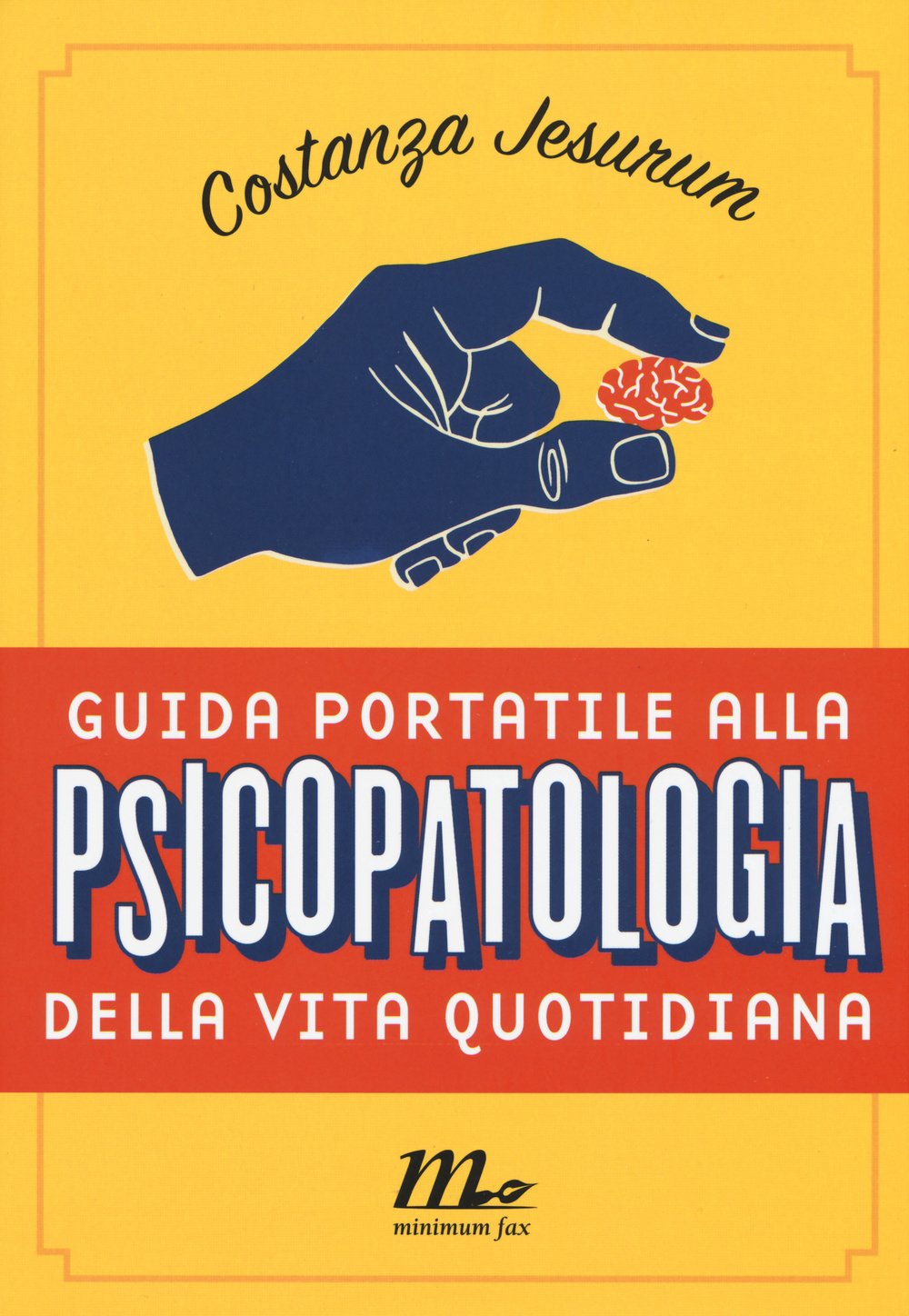
Commento all'articolo