I magnifici 7 capolavori della letteratura irlandese – Autori Vari
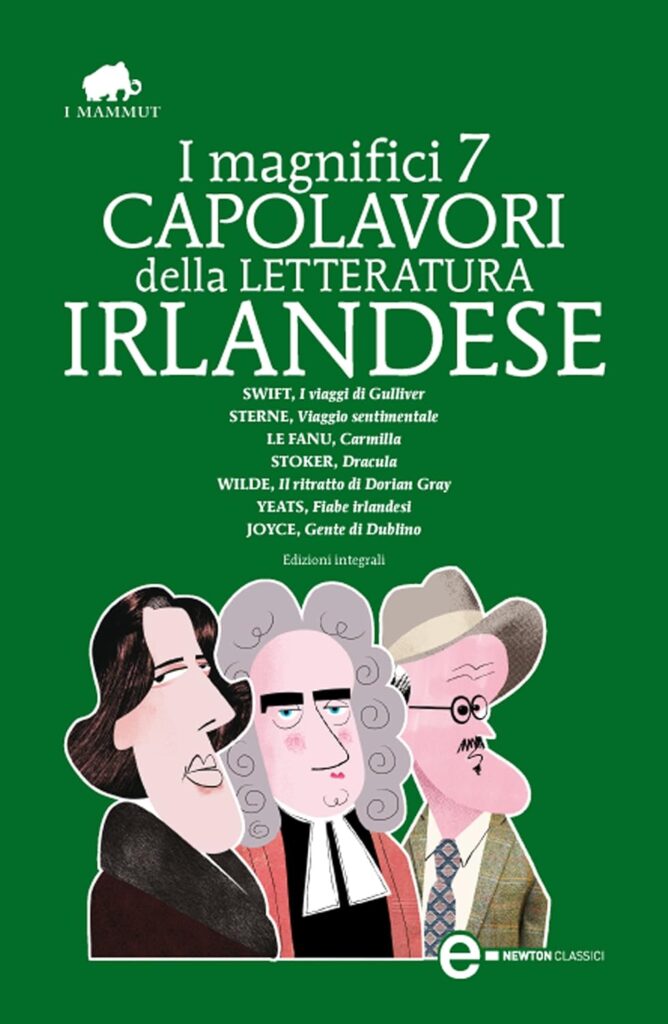
SINTESI DEL LIBRO:
I Introduzione
Perché fa ancora piacere rileggere I viaggi di Gulliver, a due
secoli di distanza dalla sua pubblicazione? Perché non ci annoiano,
nonostante le novità sofisticate raggiunte dall’intrattenimento di
questi nostri anni, i naufragi di un immaginario capitano in paesi
pieni di insidie e pericoli? Perché appassiona ancora sia i ragazzi
che gli adulti questo libro scritto da un prete anglicano per incuriosire
il lettore inglese del lontano Settecento?
Il segreto, forse, sta nell’abilità di un autore che voleva
soprattutto proporre un testo di satira, ma inserendolo in vicende
emozionanti ed esplicitamente fantastiche. Il perfetto equilibrio tra
l’intento polemico e la trama avvincente ha permesso a I viaggi di
Gulliver di mantenere la sua leggibilità fino ad oggi. Certo, le
avventure mirabolanti e divertenti del capitano Lemuel Gulliver sono
state il pretesto per mettere in ombra, con il passare dei decenni e
dei secoli, proprio gli intenti satirici e polemici dell’autore. Jonathan
Swift, così, è stato ritenuto soltanto uno scrittore per l’infanzia,
oscurandone la carica sovversiva e destabilizzante, che già ai suoi
tempi aveva fatto scandalo. Ma oggi è possibile riavvicinarsi a Swift
e ai suoi Viaggi di Gulliver valorizzandone tutti gli aspetti, tutta la
complessità.
Quattro paesi soprattutto, tra i tanti esplorati da Gulliver, restano
impressi profondamente nella memoria: Lilliput, popolato di nani,
dalle piccole vite piene di piccolezze; Brobdingnag, popolato di
giganti che si credono superiori solo in ragione delle loro dimensioni;
Laputa, l’isola volante abitata da filosofi e scienziati le cui teorie
assurde volano nelle nuvole come l’isola che li ospita;
Huyhnhnmlandia, dal nome simile a un nitrito, dove i cavalli
comandano e gli umani obbediscono. E a questi potremmo
aggiungere Glubbdubdrib, dove i maghi materializzano il passato per
mostrare a Gulliver il vero volto della storia umana.
Swift crea dei veri e propri universi alternativi al nostro. Ma c’è un
metodo ben preciso in tutte le sue descrizioni di territori e isole
fantastiche: l’operazione era quella di ribaltare o estremizzare il
mondo in cui vivevano gli europei della sua epoca. In questo modo
trasforma i viaggi incredibili di Gulliver in una critica spietata del
sistema di vita dell’Inghilterra del Settecento, con una capacità
satirica che rimarrà molto «inglese» anche negli anni a venire.
Preoccupato da una società in rapida mutazione, fondata sempre
più sul commercio, sulla finanza e sulla priorità del mercato, Swift
dirige la sua critica contro le guerre, contro le inconcludenze dei
parlamenti, contro i fanatismi delle religioni (anche della religione
che lo scrittore professava e officiava). Swift sceglie lo sguardo
esterno dell’intellettuale, che può beffarsi anche del sacro e
dell’opposto trionfo della ragione: l’Illuminismo stava per affermarsi,
e Swift aveva bisogno di demolire tutte le costruzioni troppo
«preveggenti» della ragione, anche le utopie costruite a tavolino
dalla mente degli uomini. I suoi universi visionari sono uno specchio
deformante che riflette il nostro mondo, e quindi più simili alle
cosiddette distopie o antiutopie che alle vere e proprie utopie.
Certo, i territori in cui viaggia Gulliver sono letteralmente delle
utopie, cioè sono società che non esistono, che non sono in nessun
luogo (la parola utopia, va ricordato, significa proprio questo). Ma
non c’è nessun progetto nella satira di Swift. Le società utopiche da
lui descritte sono volutamente impossibili da realizzare, si basano su
deformazioni esagerate della realtà e non su indicazioni di possibili
organizzazioni sociali. Tra tutti i mondi visitati da Gulliver; quello dei
cavalli filosofi di Huyhnhnmlandia sembra il più giusto, quello a cui
vanno le simpatie dell’autore. Ma si fonda sulla schiavitù degli esseri
umani da parte degli equini, per quanto «saggi» essi si dimostrino, e
quindi riproduce le dinamiche di sopraffazione e violenza che proprio
Swift ripetutamente contesta.
Il Gulliver che, tornato in patria, ha nostalgia dei cavalli sapienti
sembrerebbe lanciare un segnale contraddittorio: vede la possibilità
di una società migliore in quanto saggia, ma è una società equina e
non umana, quindi riemerge un approccio pessimista che
apparentemente non crede nell’uomo e nella sua possibilità di
riscatto. Eppure smentiscono questo radicale pessimismo di Swift
sia la sua critica delle società e delle mentalità di allora, sia
l’impegno che ebbe nelle vicende politiche del suo tempo, senza
rimanere rinchiuso nella torre d’avorio dell’intellettuale scettico.
La vita di Swift del resto potrebbe spiegare quell’apparente
pessimismo disperato che emerge nei Viaggi di Gulliver. Era nato a
Dublino, ma venne allevato da uno zio che gli fece passare una
giovinezza spesso oscurata dall’umiliazione e dalla povertà. Poi
lasciò l’Irlanda per diventare segretario tuttofare di William Temple,
famoso uomo di corte, in una condizione di subalternità che lo feriva.
Emancipatosi da Temple, lo scrittore irlandese fece delle serie
«scelte di campo», schierandosi con il partito dei whigs, tuttavia
quando questi si dimostrarono guerrafondai passò a scrivere per
l’Examiner, il giornale dei rivali tories. Ma era inviso alla regina, e
appena i tories furono in declino preferì ritirarsi in Irlanda, per
diventare decano della chiesa dublinese di St. Patrick. La sua vita
amorosa, poi, è stata segnata dalla passione per due giovanissime,
entrambe di nome Esther; entrambe destinate al dolore e alla morte.
Infine, ebbe una vecchiaia funestata dalla perdita della ragione. Lui
che aveva sognato paesi irreali, che con il pensiero aveva creato
popolazioni fantastiche e favolose, finì la sua vita tormentato dalla
demenza. Lui, che denunciò l’irragionevolezza dell’epoca della
ragione, con una lungimiranza ridiventata totalmente attuale oggi, in
questa fine di millennio segnata dalla «crisi» della ragione stessa.
Jonathan Swift non era uno scrittore rassicurante o
tranquillizzante. Anzi, utilizzava spesso delle formule che
diventeranno tipiche della narrativa più inquietante negli anni a
venire. Il suo paese di giganti, ad esempio, è pauroso: non a caso il
romanzo capostipite della letteratura gotica, Il castello d’Otranto, si
basava proprio su uno spettro gigante, di cui incuteva terrore
l’enorme elmo. E macabro è il paese degli immortali, anch’esso
anticipatore di tanti racconti del terrore.
Ricorrente è poi il rapporto tra umano e bestiale, che ritroveremo
nelle storie spaventose di tanti scrittori ottocenteschi, fino all’Isola del
dottor Moreau di Herbert George Wells. Chi sono gli animali e chi
sono gli umani? È la prima domanda che ci si pone di fronte al
mondo alla rovescia di Huyhnhnmlandia dove i cavalli comandano e
gli uomini obbediscono: è esattamente analogo a quel pianeta
bizzarro in cui le scimmie sono al potere e gli umani sono ridotti in
schiavitù, narrato da Pierre Boulle e portato sullo schermo da una
fortunata serie di pellicole iniziata nel 1968 con Il pianeta delle
scimmie. Del resto i paesi immaginari visitati da Gulliver sono mondi
alieni come quelli della fantascienza che verrà un paio di secoli dopo
Swift, descritti in tutto il loro funzionamento sociale, al modo della
saga di Dune di Frank Herbert.
E questa capacità anticipatrice dei Viaggi di Gulliver è segnalata
anche da uno studioso di fantascienza come Darko Suvin, che
avvicina tra l’altro il nome di Jonathan Swift a quello di Franz Kafka.
Descrivendo la narrativa dei fratelli Arkadi e Boris Strugatski (gli
autori di Stalker, il romanzo che ispirò un celebre film di Andrei
Tarkovski), ecco cosa conclude Darko Suvin: «I predatori bestiali in
cui si tramutano esseri umani senza etica cognitiva, gli strani paesi e
i mostri che diventano sempre più orribili mentre gli autori e i lettori
scoprono che de nobis fabula narratur (la favola parla di noi): tutti
questi aspetti dimostrano che la loro vera fonte è nel più grande
paradigma della fantascienza, I viaggi di Gulliver»
1
.
Ma sarebbe riduttivo fermarsi alla constatazione di uno Swift
precursore della fantascienza. La sua grandezza va oltre.
Swift ha operato, ad esempio, una particolare elaborazione sul
linguaggio. Innanzitutto dobbiamo a lui una parola ormai entrata
nell’uso comune, sia nella nostra lingua sia in altre lingue europee:
lillipuziano. Poi ha inventato strani e suggestivi termini come
splacknuck, l’insetto secondo la lingua dei giganti di Brobdingnag
che guardano con sospetto il piccolissimo Gulliver. Ma non
dimentichiamoci dell’Accademia di Lagado che – apprende il
capitano Gulliver – ha addirittura il progetto di abolire del tutto le
parole.
Swift non rifugge dalle descrizioni di scene ripugnanti, oltre che
da un gusto per le cose «sporche» (feci, urine, cattivi odori...). E del
resto la sua abilità di «racconta-storie» lo porta a lavorare (come
tanti scrittori a noi contemporanei) sul tema del corpo. Le sue
invenzioni fantastiche ci narrano di corpi dalle misure spropositate o
viceversa ridotte, impressionandoci con gli orrori del gigantismo e
del suo contrario, il rimpicciolimento.
I corpi giganti descritti da Swift fanno orrore, come fa orrore la
diversità. In fondo, ci parla di mondi che guardano i mondi diversi da
sé con sufficienza o con aperta ostilità. E i bambini hanno sempre
apprezzato I viaggi di Gulliver perché li rappresenta in quanto
diversi, come faceva Lewis Carroll con la sua Alice nel paese delle
meraviglie: sproporzionati rispetto agli adulti, immersi in un mondo
che non è a misura di bambino, giudicati e valutati come Gulliver è
giudicato e valutato dai giganti.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
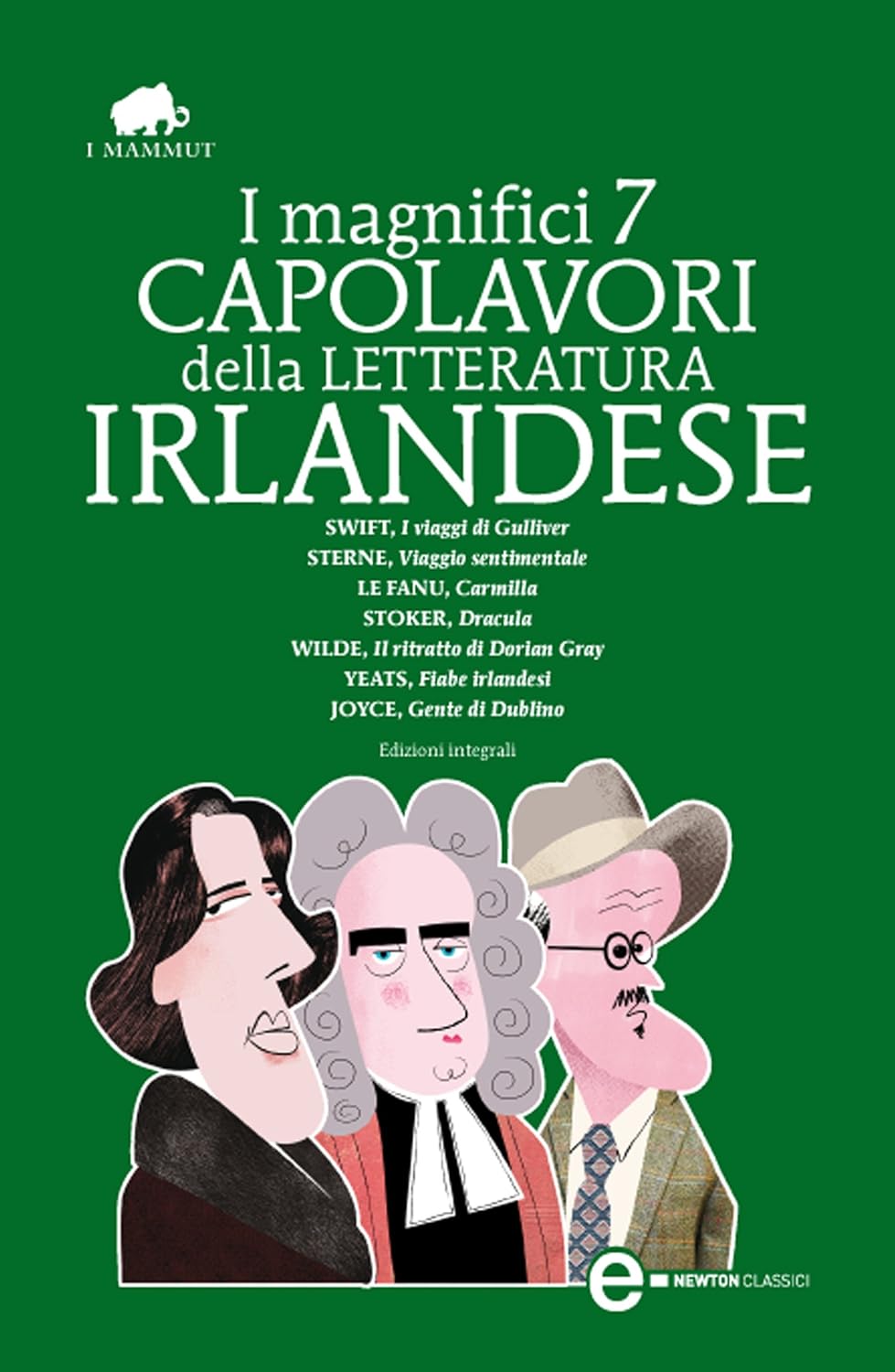





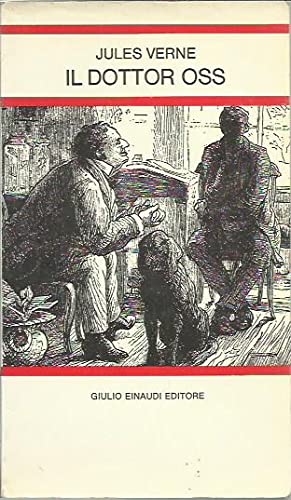
Commento all'articolo