Il dottor Oss – Jules Verne
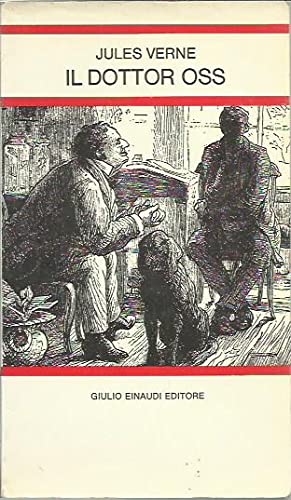
SINTESI DEL LIBRO:
Quiquendone è dunque una città scomparsa? No. Una città di là da
venire? Tanto meno. Essa esiste a dispetto dei geografi, e ciò da
otto o novecento anni. Annovera ormai duemilanovecentonovantatré
anime, ammettendo un'anima per ogni abitante. È posta a tredici
chilometri e mezzo a nord-ovest d'Audenarde, e a quindici chilometri
e un quarto a sud-est di Bruges, in piena Fiandra. Il Vaar, piccolo
affluente della Schelda, passa sotto i suoi tre ponti, ancora coperti
da una antica tettoia del Medioevo, come a Tournay. Vi si ammira un
vecchio castello, la cui prima pietra fu posta, nel 1197, dal conte
Baldovino,
1 futuro imperatore di Costantinopoli, e un municipio con
finestrelle goticheggianti sormontato da una corona di merli, e
dominato da un campanile a torricelle, che si innalza per
trecentocinquantasette piedi dal suolo. Vi si ode, ad ogni ora, uno
scampanio di cinque ottave, vero cembalo aereo, la cui rinomanza
supera quella delle celebri campane di Bruges.
I forestieri, se mai ne capitano a Quiquendone, non lasciano questa
curiosa città senza aver visitato la sala degli Stathouders,
2adorna
del ritratto in piedi di Guglielmo di Nassau
3del pittore Brandon, il
pulpito della chiesa di Saint-Magloir, capolavoro dell'architettura del
XVI secolo, il pozzo in ferro battuto che si apre in mezzo alla vasta
piazza di Saint-Ernuph, la cui mirabile ornamentazione è dovuta al
pittore e fabbro Quintino Mestys, la tomba provvisoriamente eretta a
Maria di Borgogna, figlia di Carlo il Temerario,
4che riposa ora nella
chiesa di Notre-Dame di Bruges, ecc. Infine, Quiquendone ha per
principale industria la fabbricazione della panna montata e delle
caramelle su larga scala. Tale industria è diretta di padre in figlio, da
parecchi secoli a questa parte, dalla famiglia van Tricasse. Eppure,
Quiquendone non figura sulla carta delle Fiandre! È dimenticanza
dei geografi? è omissione volontaria?
Non lo posso dire; ma Quiquendone esiste davvero, con le sue vie
strette, la sua cinta fortificata, le sue case spagnole, il suo mercato e
il suo borgomastro; esiste al punto che, recentemente, fu teatro di
fenomeni sorprendenti, straordinari, inverosimili, e pur veri,
avvenimenti che ora saranno fedelmente riferiti in questa nostra
narrazione.
Certo, non possiamo né dire né pensare male dei fiamminghi della
Fiandra occidentale. Sono brave persone, sagge, parsimoniose,
socievoli, di umore costante, ospitali, forse un tantino gravi nel
linguaggio e nello spirito; ma ciò non spiega come mai una delle più
interessanti città del loro territorio non sia giunta ancora a figurare
nella moderna cartografia.
Una simile omissione è certamente deplorabile. Se almeno la storia,
e in mancanza della storia le cronache, o in mancanza delle
cronache la tradizione del paese, facessero menzione di
Quiquendone! Ma no; né gli atlanti, né le guide, né gli itinerari ne
parlano. Lo stesso signor Joanne, il più attento scopritore di borgate,
non ne fa parola. Si capisce quanto questo silenzio debba nuocere
al commercio e all'industria di questa città. Ma noi ci affretteremo ad
aggiungere che Quiquendone non ha industrie rilevanti né
commercio, e che ne fa magnificamente a meno. Le sue caramelle e
la sua panna montata, le consuma in luogo e non le esporta.
Insomma, gli abitanti di Quiquendone non hanno bisogno di
nessuno.
I
loro desideri sono limitati, la loro vita è modesta; sono calmi,
moderati, freddi, flemmatici; in una parola «fiamminghi», i più
fiamminghi che s'incontrano tra la Schelda e il mare del Nord.
CAPITOLO II
IL
BORGOMASTRO VAN TRICASSE E IL CONSIGLIERE
NIKLAUSSE S'INTRATTENGONO A DISCUTERE SUGLI AFFARI
DELLA CITTA
— CREDETE? — chiese il borgomastro.
— Lo credo, — rispose il consigliere, dopo alcuni minuti di silenzio.
— Non bisogna agire con leggerezza, — ripigliò il borgomastro.
— Sono dieci anni che parliamo di quest'affare così grave, — replicò
il consigliere Niklausse — e vi confesso, mio stimabile van Tricasse,
che non posso ancora prendermi la responsabilità di decidere.
— Comprendo la vostra esitazione — ripigliò il borgomastro, dopo
un buon quarto d'ora di riflessione, — comprendo la vostra
esitazione, e la condivido. Faremo bene a non decidere nulla prima
d'un più ampio esame della questione.
— È certo che questo posto di commissario civile — aggiunse
Niklausse — è perfettamente inutile in una città pacifica come
Quiquendone.
— Il nostro predecessore, — riprese van Tricasse con tono grave, —
il nostro predecessore non diceva mai, non avrebbe mai osato dire
che una cosa «è certa». Qualunque affermazione è soggetta a
spiacevoli rettifiche.
Il
consigliere scrollò la testa in segno d'assenso, poi stette
silenzioso, una mezz'ora circa. Dopo tutto questo tempo, durante il
quale il consigliere e il borgomastro non mossero neppure un dito,
Niklausse domandò a van Tricasse se il suo predecessore, qualche
ventina d'anni addietro, non avesse avuto come lui l'idea di
sopprimere il posto di commissario civile che, ogni anno, gravava la
città di Quiquendone di una somma di milletrecentosettantacinque
franchi e di qualche centesimo.
— Infatti — rispose il borgomastro, che si portò con maestosa
lentezza la mano alla limpida fronte, — infatti; ma quel degno uomo
morì prima d'aver osato prendere una decisione, sia riguardo a
questa, sia riguardo ad alcun'altra misura amministrativa. Era un
saggio. Perché non faccio come lui?
Il
consigliere Niklausse sarebbe stato incapace d'immaginare una
ragione che potesse contraddire l'opinione del borgomastro.
— L'uomo che muore senza essersi mai deciso a nulla durante la
vita, — soggiunse gravemente van Tricasse, — ha raggiunto molto
da vicino la perfezione in questo mondo!
Ciò detto, il borgomastro premette con la punta del mignolo un
campanello dal suono velato, che fece udire, più che un suono, un
sospiro. Quasi subito, alcuni passi leggeri sfiorarono lievemente il
pianerottolo. Un topolino non avrebbe fatto maggior rumore
saltellando sopra un soffice tappeto. La porta della stanza si aprì
girando sui cardini silenziosi, e comparve una giovinetta bionda,
dalle lunghe trecce. Era Susette van Tricasse, la figlia unica del
borgomastro. Ella consegnò al padre, insieme con la pipa caricata a
puntino, un piccolo braciere d'ottone, non pronunciò una parola, e
scomparve subito, senza che la sua uscita avesse prodotto più
rumore della sua entrata.
Il bravo borgomastro accese l'enorme fornello della sua pipa, e si
eclissò ben presto in una nuvola di fumo azzurrastro, lasciando il
consigliere Niklausse immerso nella più profonda riflessione.
La stanza in cui conversavano questi due importanti personaggi
incaricati dell'amministrazione di Quiquendone era un salotto
riccamente adorno di sculture in legno scuro. Un alto camino, un
vasto focolare in cui si sarebbe potuto bruciare una quercia o
arrostire un bue, occupava una intera parete del salotto, e faceva
fronte a una finestra ad inferriata, i cui vetri colorati facevano
dolcemente schermo ai raggi del sole. Al di sopra del camino
pendeva un quadro col ritratto, attribuito a Hemling, di un certo
signore che doveva rappresentare un antenato di van Tricasse, la
cui genealogia risaliva con certezza al XIV secolo, tempo in cui i
fiamminghi e Guido di Dampierre
5 ebbero a lottare contro
l'imperatore Rodolfo d'Absburgo.
6
Questo salotto faceva parte della casa del borgomastro, una delle
più graziose di Quiquendone.
Costruita secondo il gusto fiammingo e con tutto l'imprevisto, il
capriccio, il pittoresco, il bizzarro che comporta l'architettura ogivale,
la si citava tra i più curiosi monumenti della città. Un convento di
certosini o un collegio di sordomuti non sarebbero stati più silenziosi
di quell'abitazione. Il rumore non vi esisteva; non si camminava, si
scivolava; non si parlava, si sussurrava. Eppure le donne non
mancavano nella casa, che, senza contare il borgomastro van
Tricasse, accoglieva sua moglie, la signora Brigitte van Tricasse, la
figlia Susette van Tricasse, e la domestica, Lotchè Janshéu.
Bisogna inoltre ricordare la sorella del borgomastro, la zia
Hermance, vecchia zitella che rispondeva ancora al nome di
Tatanémance, che le dava in passato sua nipote Susette, al tempo
ch'era una fanciulletta. Ebbene, nonostante tutti questi elementi di
discordia, di chiasso, di cicaleccio, la casa del borgomastro era
calma come un deserto.
Il borgomastro era un personaggio di cinquant’anni, né grasso né
magro, né basso né alto, né vecchio né giovane, né colorito né
pallido, né gaio né triste, né contento né annoiato, né energico né
molle, né orgoglioso né umile, né buono né cattivo, né generoso né
avaro, né coraggioso né poltrone, né troppo né troppo poco - ne quid
nimis
7— un uomo, in sostanza, moderato in tutto. Ma dalla lentezza
invariabile dei suoi movimenti, dalla sua mascella inferiore un po'
pendente, dalla sua palpebra superiore immutabilmente rialzata,
dalla sua fronte piatta come una piastra di ottone e senza una ruga,
dai suoi muscoli poco segnati, un fisionomista non avrebbe fatto
fatica a riconoscere che il borgomastro van Tricasse era la flemma in
persona. Mai, né per ira né per passione, mai un'emozione
qualunque aveva accelerato i moti del cuore di quest'uomo né
arrossata la sua faccia; mai le sue pupille si erano contratte per un
qualsiasi moto d'irritazione, sia pur passeggero. Era invariabilmente
vestito di buoni abiti, né troppo larghi né troppo stretti, che non
riusciva a consumare.
Calzava grosse scarpe quadre a triplice suola e con fibbie d'argento,
le quali, per la loro durata, facevano la disperazione del suo
calzolaio. Portava in testa un largo cappello che datava dall'epoca in
cui la Fiandra venne decisamente separata dall'Olanda, il che
mostrava all'evidenza che questo venerabile copricapo aveva
quarant'anni.
Ma che volete? Sono le passioni che consumano il corpo quanto
l'anima, gli abiti quanto il corpo, e il degno borgomastro, apatico,
indolente, indifferente, non s'appassionava in nulla; egli non
consumava, e per ciò stesso era precisamente l'uomo che occorreva
per amministrare la città di Quiquendone e i suoi tranquilli abitanti.
La città, infatti, non era meno calma della casa di van Tricasse.
Ora, in questa pacifica dimora, il borgomastro s'avviava a
raggiungere l'età più avanzata cui arriva l'esistenza umana, dopo
aver visto tuttavia la buona signora Brigitte van Tricasse, sua moglie,
precederlo nella tomba, dove non avrebbe avuto un riposo più
profondo di quello che già gustava da sessant’anni sulla terra.
Ciò merita una spiegazione.
La famiglia van Tricasse avrebbe potuto chiamarsi giustamente «la
famiglia Jeannot»
8. Ecco perché.
È noto che il coltello di questo personaggio caratteristico è tanto
celebre quanto il suo proprietario, e non meno inconsumabile, grazie
alla duplice operazione, sempre rinnovata, che consiste nel sostituire
il manico quando è consumato e la lama quando non vale più nulla.
Tale era l'operazione, assolutamente identica, praticata da tempo
immemorabile nella famiglia van Tricasse, e alla quale la natura si
era prestata con una compiacenza alquanto straordinaria. Dal 1340
in poi, si era sempre visto invariabilmente un van Tricasse, divenuto
vedovo, rimaritarsi con una van Tricasse, più giovane di lui, che,
vedova a sua volta, si risposava con un van Tricasse più giovane di
lei, che, vedovo a sua volta... ecc. ecc. senza soluzione di continuità.
Ciascuno moriva al suo momento giusto con meccanica regolarità.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :


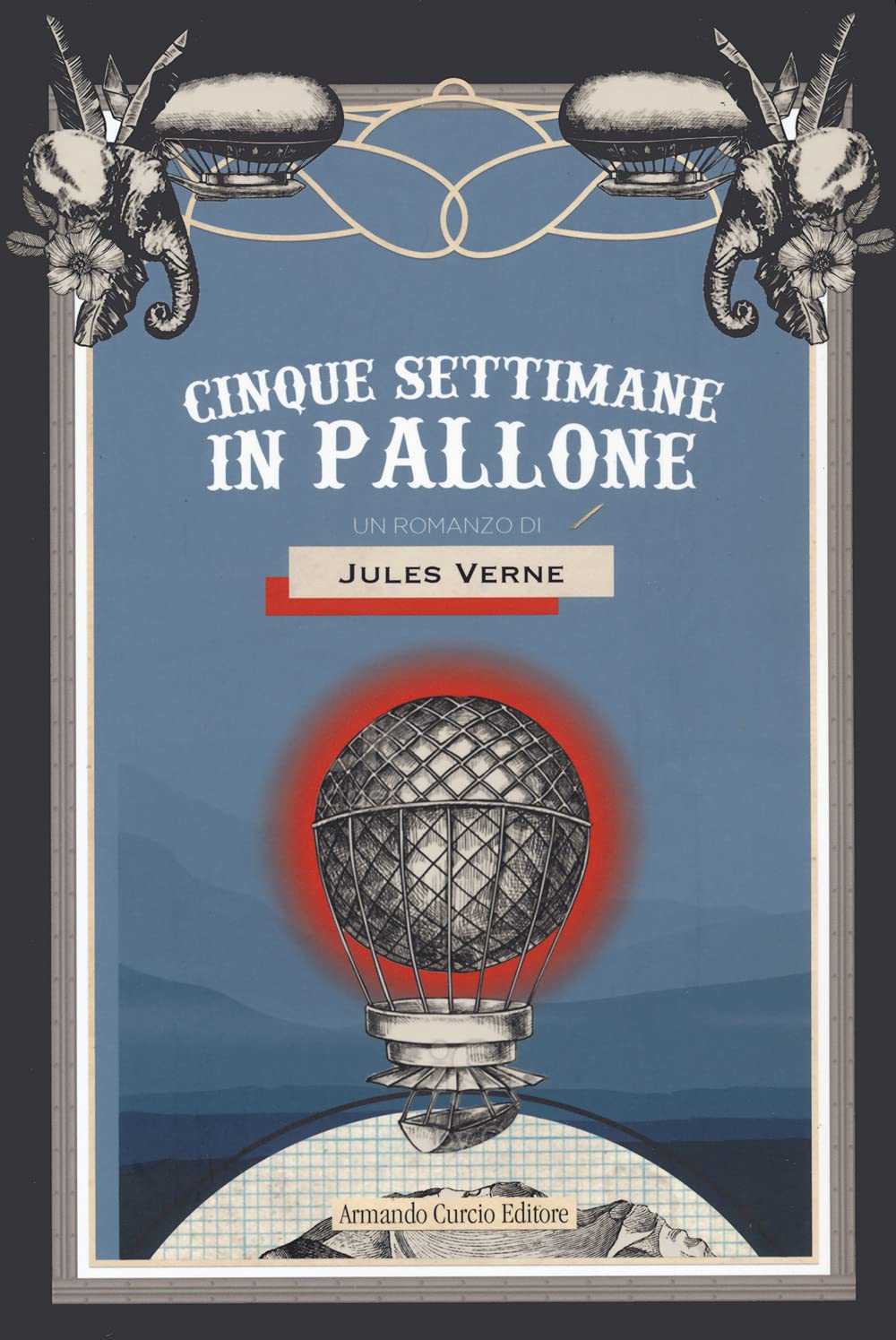
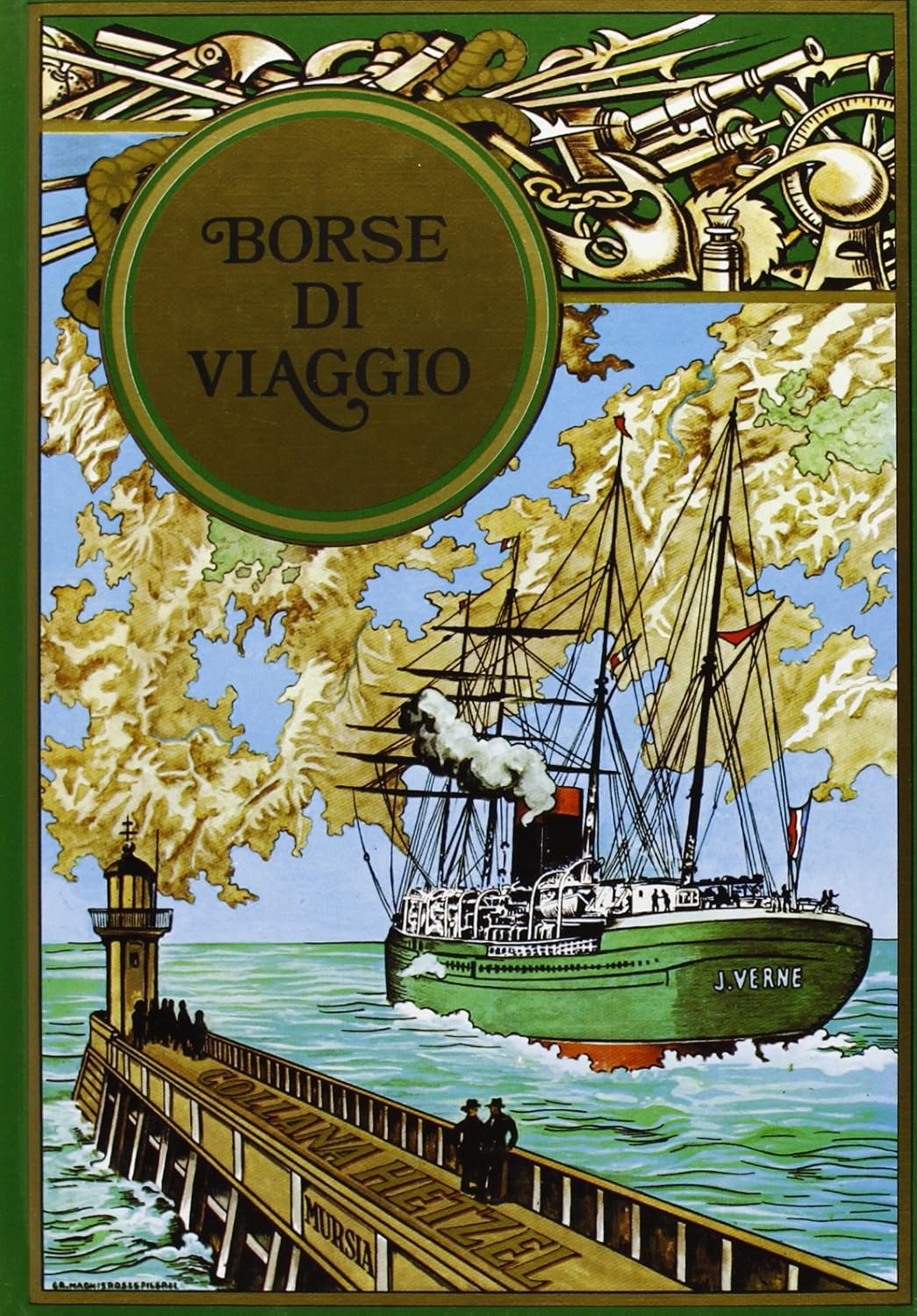
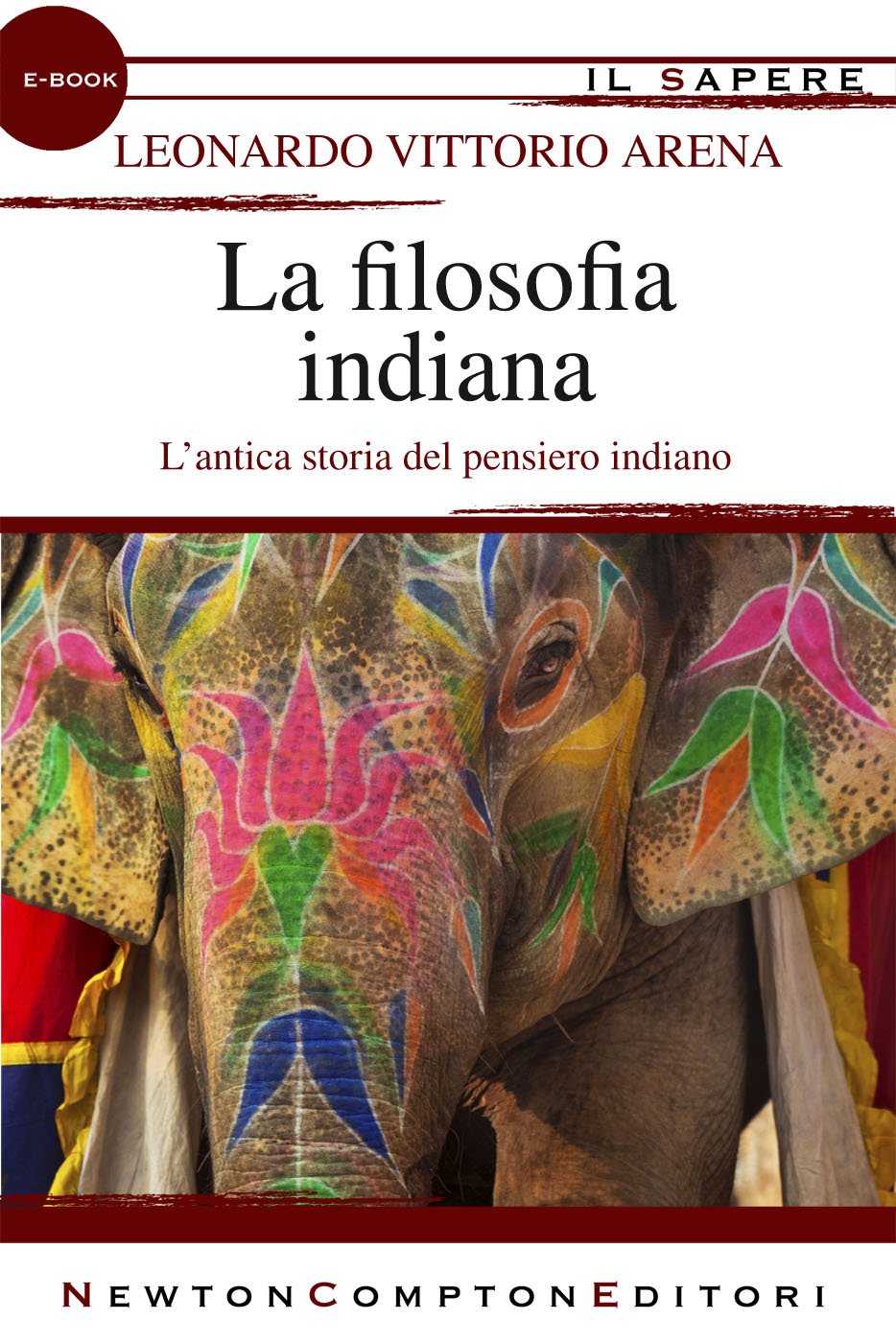
Commento all'articolo