La filosofia indiana – Leonardo Vittorio Arena
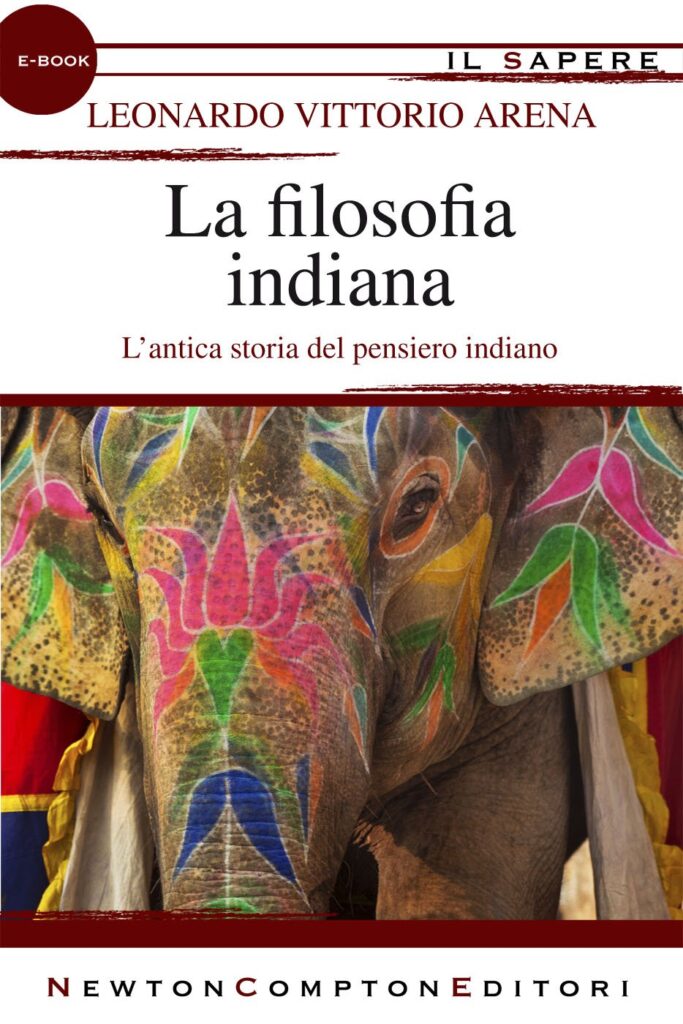
SINTESI DEL LIBRO:
La speculazione indiana si apre con i Veda.
Si tratta di una raccolta di opere in quattro gruppi: Rig-Veda, Yajur
Veda, Sàma-Veda e Atharva-Veda. Il termine veda deriva dalla
radice indo-ariana vid («conoscere»).
Gli autori dei Veda vengono tradizionalmente ritenuti i rishi. Si tratta
dei «veggenti»: in forza delle proprie intuizioni e del soma, una
bevanda inebriante, essi si sentono ispirati e sollecitati a trasmettere
all’umanità quanto hanno appreso.
Lo Yajur-Veda ha per oggetto le formule del sacrificio; il Sàma
Veda, le melodie musicali; l’Atharva-Veda, la raccolta più tarda,
nonché un compendio delle teorie mediche indiane, le formule
magiche. La raccolta filosoficamente rilevante è il Rig-Veda.
Si tratta presumibilmente del più antico documento filosofico della
letteratura indoeuropea. Radhakrishnan lo colloca, generosamente,
nel XV secolo a.C. L’eterogeneità di visioni e contenuti è imputabile
alla redazione di più autori. Vi sono assemblati 1017 inni, suddivisi in
dieci libri.
Vengono cantati e adorati parecchi dèi. Essi corrispondono ai
fenomeni naturali: per esempio, Agni (il fuoco), Dyaus (il cielo), Vàyu
(il vento o l’aria) e Sùrya (il sole). Divinità corrispondenti a entità
astratte, come Indra, Varuna e Vishnu, venivano correlate anch’esse
in origine a elementi naturali. Indra, che finì per diventare il dio più
popolare, era associato al fulmine.
I pensatori del Rig-Veda ritengono che ogni fenomeno naturale sia
da considerarsi divino e degno di adorazione.
Accanto agli dèi di questo pantheon, si ammette l’esistenza degli
spiriti dei boschi, delle fate (gandharva) e delle damigelle celesti
(apsara).
La religiosità del Rig-Veda, più che al politeismo, sembra
improntata all’enoteismo (il termine è di Max Müller): a turno, la
divinità riverita in uno specifico inno viene considerata la più
importante.
Nel Rig-Veda si celebra l’ordine del mondo (Rita): tutto avviene in
conformità a leggi basilari, che si ripetono costantemente. L’uomo si
sforza di conoscerle, ma i suoi tentativi rimangono frustrati, ed egli
s’incanta davanti al grande mistero della vita.
«Da dove veniamo?», «Chi ha creato l’universo?»: sono le prime
questioni dei pensatori indiani. Alcune risposte vengono indicate
nell’Inno alla creazione (Rig-Veda, 10, 129).
Si parla di un tempo in cui non esisteva né l’essere, né il non
essere. Non c’era ancora il vento, e nemmeno il cielo. Di vita e
morte, notte e giorno, non si parlava ancora. Soltanto quell’Uno (tad
Ekam) respirava, in virtù della propria forza intrinseca. In
quell’istante il vuoto fu colmato, e l’Uno, grazie al suo «calore
interno» (tapas), si autogenerò. L’Inno si conclude con la
constatazione dell’impotenza cognitiva: l’enigma della vita non sarà
mai decifrabile. Non si sa da dove la creazione derivi; gli dèi furono
generati in seguito, quindi non ne sanno nulla. Forse soltanto lui
quell’Uno – ne sonda gli arcani, dal più alto dei cieli. Oppure, chissà,
neanche lui ne sa niente!
Con il riferimento all’Uno si passa dal primitivo politeismo a una
sorta di monoteismo. Il passaggio è preparato dall’ammissione della
possibilità di identificare un dio con un altro. Tuttavia, non si deve
pensare a un monoteismo di stampo occidentale: un dio che non
conosca neppure la propria origine appare assai singolare alla
nostra mentalità, assuefatta alla tradizione biblica.
Nei Bràhmana, manuali per la classe sacerdotale, Prajàpati
assurgerà a divinità principale, come creatore del mondo; e verrà
identificato con un altro dio, Viçvakarman.
Dell’ordine cosmico si è già detto. I pensatori vedici tentano di
modellare una società che possa riprodurlo. Viene accolta l’idea di
una stretta corrispondenza tra il micro e il macrocosmo.
In un passo si allude alle quattro caste: bràhmani (sacerdoti),
kshatriya (guerrieri e principi), vaiçya (agricoltori, artigiani e
commercianti) e çùdra (servi e operai) (Rig-Veda, 10, 90). Le prime
tre caste erano quelle dei dominatori ariani, i quali s’imposero sui
pacifici abitanti della valle dell’Indo; l’ultima è quella dei vinti, i non
ariani. Verrà anche ammessa una categoria «fuori casta», composta
dai membri delle tribù non sottomesse.
Ulteriori indicazioni sul comportamento delle caste verranno fornite
in un’opera più tarda, il Codice di Manu, relativa al diritto, all’etica e
alla politica.
Già nel periodo vedico si afferma che ciascun individuo deve
restare al proprio posto, e svolgere le funzioni che gli competono, in
modo da garantire il perfetto funzionamento della società. Ciò
comporta il compimento dei doveri etici (dharma). Si raccomanda
inoltre di amare il prossimo e di essere gentili e ben disposti con tutti.
Anche il controllo delle passioni viene suggerito.
Ma non è ancora l’epoca dell’ascesi: i Veda cantano la vita, la gioia
di esistere e il godimento dei fenomeni naturali – per esempio, della
bellezza d’un tramonto. Così, i loro autori affermano il mondo.
Negli Inni non viene formulata una concezione univoca della
condizione post-mortem. In genere, l’uomo è considerato immortale.
A seconda della sua buona o cattiva condotta, dopo il decesso fisico,
finirà, rispettivamente, nel mondo di Vishnu o di Yama.
Yama divenne in seguito la divinità per eccellenza degli Inferi.
Poiché fu il primo uomo a morire, egli governa il regno dei morti,
assolvendo anche la funzione di giudice e castigatore degli uomini.
In altri inni l’immortalità è qualcosa che va conquistato: per
esempio, grazie ai sacrifici. In tal modo, si ottengono i favori degli
dèi. Si ritiene che i malvagi cadano in una sorta di abisso, e che
siano destinati all’estinzione. Sembra che manchino tracce della
dottrina della reincarnazione, più tardi ampiamente diffusa.
Upanishad
Le Upanishad costituiscono la parte conclusiva dei Veda. Ne
esistono più di 200, benché, per tradizione, ne siano enumerate 108.
La loro datazione è incerta: le più antiche dovrebbero risalire all’VIII e
al VII secolo a.C., e sarebbero quindi pre-buddhistiche; le più recenti,
al V o IV secolo a.C.
Le Upanishad sono state composte da autori ispirati, e
appartengono alla letteratura rivelata o çruti (lett.: «ciò che è stato
udito»). Al pari dei Veda, esse hanno un carattere religioso-culturale;
tuttavia, a differenza di quelli, presentano tratti altamente speculativi.
In effetti, tutta la filosofia indiana non è altro che una glossa e un
commento alle Upanishad. Esse rappresentano, mutatis mutandis,
l’equivalente della dottrina platonica per il pensiero occidentale: un
costante referente tematico.
Il termine upanishad significa letteralmente «seduto/giù/accanto».
Si allude alla collocazione del discepolo, seduto ai piedi del maestro.
Esaminando le tematiche delle Upanishad più importanti, ne
emergerà la continuità di fondo, benché non una visione unitaria od
omogenea.
Nella Brihadàranyaka Upanishad è formulata una cosmologia
primitiva. All’inizio c’era soltanto il nulla, il non-essere, dal quale si
produsse l’universo. In ogni uomo alberga una scintilla del Brahman,
l’energia cosmica: si tratta dell’àtman, il principio dell’individualità o il
sé personale (di solito, erroneamente tradotto con «anima»; per
quanto concerne la possibilità di definire «personale» l’àtman, cfr. la
mia «Introduzione»). Viene postulata una corrispondenza intima tra il
micro e il macrocosmo, sulla base di vari spunti vedici.
Ogni creatura riceve qualcosa dal Brahman: l’incarnazione più
completa di quest’energia è il bràhmano, il sacerdote. In questa
Upanishad si torna sulla questione delle caste. Tuttavia, nonostante
l’evidente enfasi sulla casta bràhmanica, nella Upanishad è un
guerriero a istruire un sacerdote. Evidentemente alla classe dei
Bràhmani non era ancora stato assegnato il ruolo di primo piano che
avrebbe avuto in seguito.
Si dichiara che del Brahman non si può parlare. Nessuna
determinazione verbale riuscirebbe a renderne la natura: «non così,
non così» (neti neti): è l’unica espressione applicabile all’energia
cosmica.
Viene poi indicata l’identità tra il Brahman e l’àtman, tra l’energia
impersonale e l’identità personale (4, 4, 5). «Tutto il mondo non è
altro che l’àtman.» L’àtman è indistruttibile ed eterno. Questa
cosmologia ha importanti risvolti etici.
L’uomo dovrà prendere coscienza della propria identità autentica,
per capire che il suo àtman, la propria natura intima, contiene un
principio universale. Egli rifuggirà dalle passioni, votandosi
all’ascetismo.
A un certo punto della propria evoluzione, infine, si lascerà dietro
qualsiasi massima o norma etica: sarà libero sia dal male che dal
bene. In questo stato d’animo non traccerà più alcuna distinzione tra
sé e gli altri, rendendosi conto della perfetta identità tra il Brahman e
l’àtman. E non potrà più temere nulla: la sua vita sarà immortale,
ormai, come quella del cosmo.
Anche nella Chàndogya Upanishad, un membro della casta
guerriera, cioè un principe, si rivela più perspicace dei suoi
interlocutori bràhmani. Il protagonista della Upanishad è il bràhmano
Uddàlaka Àruni. Anche qui viene postulata una perfetta
corrispondenza tra il micro e il macrocosmo: uno stesso fenomeno, il
respiro, pervade ogni ambito dell’universo, e continua a sussistere in
ogni istante, persino nel sonno profondo.
Con alcune varianti, ci si riallaccia alla cosmologia della
Brihadàranyaka Upanishad: dal non-essere deriva l’essere; in
questo caso, si passa poi alla produzione di un uovo cosmico, le cui
metà compongono l’universo.
Tuttavia, in altre sezioni della Upanishad questa dottrina viene
negata: «com’è possibile che dal non-essere sia sorto l’essere?».
Ciò attesta la presenza di alcune incrostazioni, quindi l’apporto di
vari autori alla redazione dell’opera.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :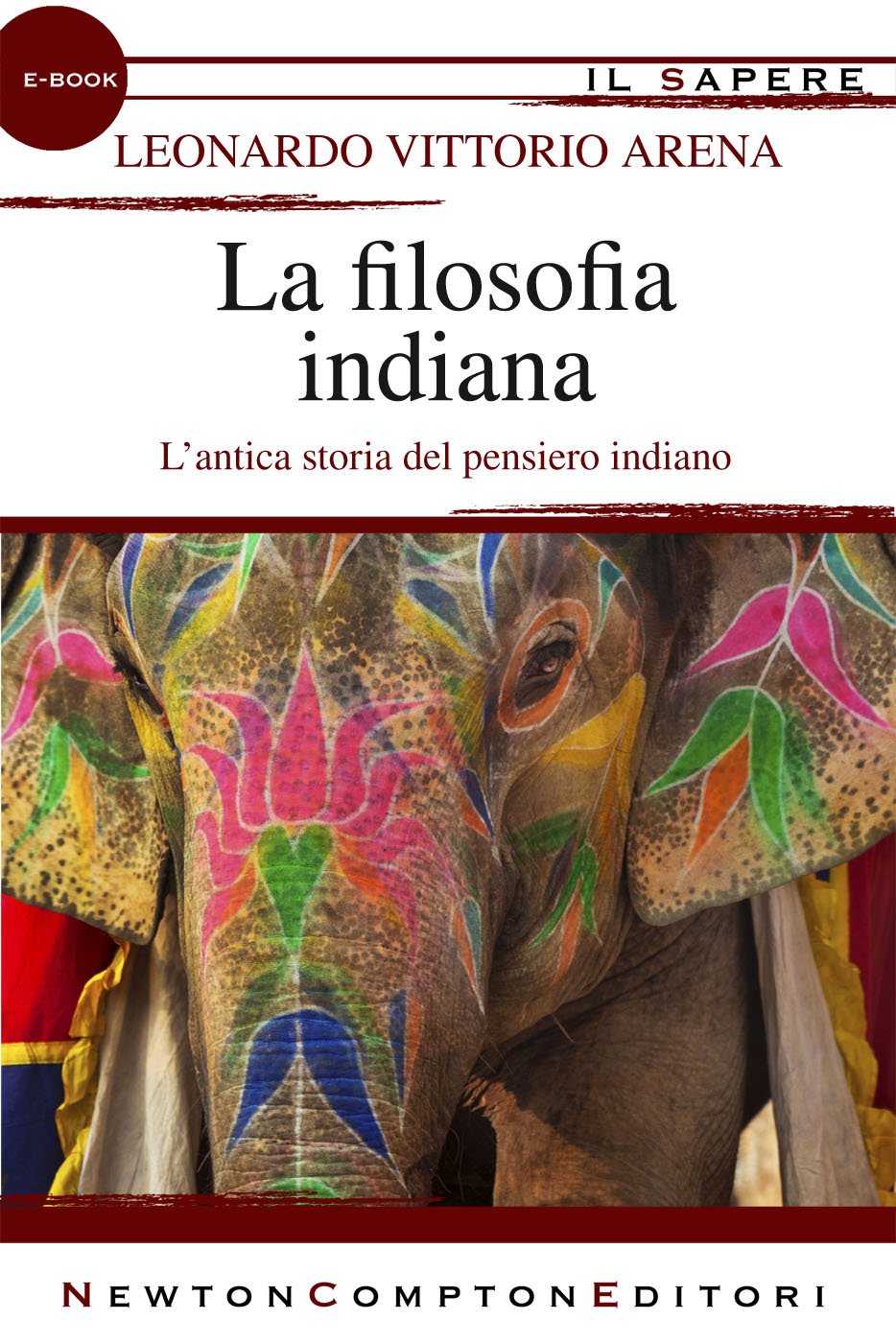






Commento all'articolo