Il destino del cibo – Così mangeremo per salvare il mondo – Agnese Codignola
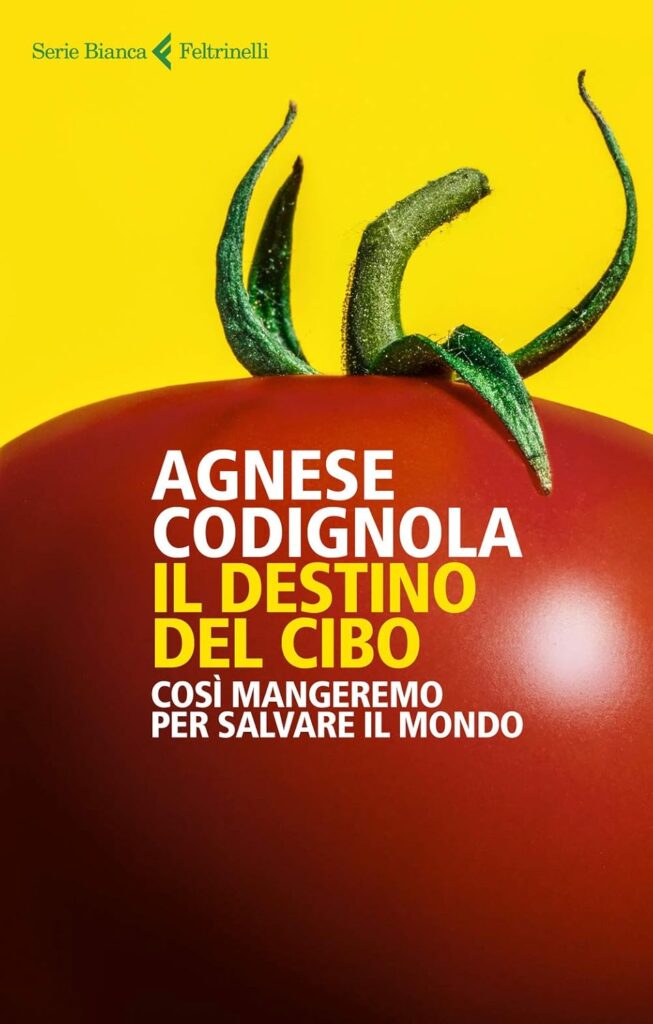
SINTESI DEL LIBRO:
Secondo la Fao nel mondo, in questo momento, vivono circa
ventotto miliardi di animali da carne tra bovini, suini, ovini e pollami.
Nella loro infelice esistenza, questi animali emettono circa il 15% di
tutto il metano e il 30% di tutto il biossido d’azoto e in totale poco
meno della metà dei gas serra che finiscono in atmosfera,
consumano un terzo delle terre emerse e poco meno del 10% di
tutta l’acqua disponibile, nonché l’80% degli antibiotici prodotti,
lasciando come eredità la stratosferica cifra di quattro miliardi di
tonnellate di letami all’anno, impossibili da utilizzare o smaltire
interamente.
Tutto ciò per assicurare a noi umani un consumo pro capite di 43,7
chilogrammi di carne all’anno, per produrre un chilo della quale, se di
manzo, occorrono circa quindicimila litri di acqua.
E non c’è solo la carne. Da quegli stessi animali, infatti, otteniamo
anche quasi novecento milioni di tonnellate all’anno di latte, per
assicurarci i nostri 108,3 litri di consumo personale annuale (tra latte
e derivati), ognuno dei quali richiede mille litri di acqua, se si
considerano tutte le necessità delle mucche. E naturalmente quel
trilione di uova da impiegare in un anno negli alimenti più disparati.
Per questo è sempre più chiaro che, per quanto si possa pensare
di migliorare l’efficienza dei sistemi di allevamento, l’unica vera
soluzione è cambiare modello di alimentazione e, soprattutto,
scordarsi o quasi la carne così come la conosciamo oggi.
Tutti vegetariani dunque? Non proprio: numerosi studi effettuati
negli ultimi anni hanno dimostrato che la percentuale di chi decide di
nutrirsi di soli vegetali in tutte le possibili varianti, pur in grande
crescita, è e resta non molto rilevante (al momento si stima che i
vegetariani siano poco meno di quattrocento milioni nel mondo,
quindi ben al di sotto del 10% della popolazione) e, soprattutto, che
più dell’80% di chi lo fa, nell’arco di qualche anno, torna alla bistecca
o, quantomeno, a diete miste. Sul perché ciò accada sono state
avanzate le più svariate ipotesi, per lo più psicologiche, sociologiche,
antropologiche, e non è questa la sede per affrontare la questione.
Tuttavia accade: inesorabilmente.
E se non accadesse, se cioè andassimo verso un mondo di soli
vegetariani, sorgerebbero, tra gli altri, problemi di due tipi, entrambi
gravi. Il primo relativo alla salute: il corpo umano necessita di una
ragguardevole varietà di nutrienti che una dieta esclusivamente
vegetale può assicurare solo se estremamente bilanciata, calibrata
sulle esigenze del singolo in base a sesso, età, condizioni fisiche,
microbiota intestinale e altro, e controllata, nei suoi effetti, con
frequenti esami del sangue, per evitare stati carenziali. Tra miliardi di
vegetariani e vegani, il numero di persone che si ammalano perché
non assumono tutto ciò di cui hanno bisogno sarebbe
insopportabilmente alto, e particolarmente preoccupante in quelle
decine di paesi a sviluppo basso o intermedio dove ancora oggi non
è garantito l’accesso a tutto ciò di cui si ha bisogno. Tutto questo
andrebbe purtroppo di gran lunga a controbilanciare, in senso
negativo, gli effetti positivi sulla salute, che pure ci sarebbero:
secondo numerose stime effettuate negli ultimi anni, se l’umanità
fosse vegetariana ci sarebbero molti milioni di decessi in meno
rispetto a oggi per patologie cardiovascolari e metaboliche, tumori e
così via. Ma il saldo sarebbe pessimo.
La seconda questione riguarda il pianeta: per nutrire di sole piante
dieci miliardi di esseri umani ne occorrerebbe uno di riserva, da
adibire a campo o a serra. Questo dipende da una questione molto
semplice: l’efficienza dei vegetali come nutrienti. Senza entrare nel
dettaglio dei numeri, i nutrienti che si ricavano da un pomodoro
richiedono un certo quantitativo di terra, acqua, elettricità, al cui
consumo sono associati emissioni e scarti. Con lo stesso
quantitativo di risorse e di scarti, le carni sono estremamente più
efficienti, cioè forniscono molti più nutrienti e calorie. Per avere lo
stesso quantitativo di proteine, vitamine, sali minerali, grassi e tutto il
resto che assicurano le carni bisognerebbe quindi produrre molti più
vegetali di oggi: troppi, per le risorse a disposizione, e in assenza,
per ora, di un pianeta B.
Come se ne esce? Nell’immediato, come hanno quasi urlato negli
ultimi mesi le più disparate autorità scientifiche e sanitarie mondiali,
cambiando abitudini, ovvero relegando alla carne un ruolo ancillare,
secondario, in una dieta che preveda molti più vegetali rispetto a ora.
Ma nel futuro prossimo e a medio termine bisogna pensare ad
alternative, a strumenti e sistemi che permettano davvero di nutrire il
maggior numero possibile di persone senza distruggere quello che
resta della Terra e senza che il surriscaldamento del clima, anziché
fermarsi o diminuire, subisca un’impennata.
Una delle possibili soluzioni è quella dei surrogati vegetali dei
prodotti a base di carni, che negli ultimi mesi, anche grazie alla
partnership dei produttori con alcuni grandi marchi del fast food,
hanno conquistato fette importanti di mercato, e stanno conoscendo
una vera e propria esplosione di vendite, al punto che gli analisti
scomodano numeri a due cifre, in miliardi di dollari, per le previsioni
a breve e medio termine. Prodotti di aziende quali Impossible Foods
e Beyond Meat, le più grandi e famose, sono ormai disponibili in
migliaia di ristoranti in numerosi paesi, Italia compresa (nell’autunno
del 2019 Burger King ha lanciato la linea Rebel, grazie alla
collaborazione con Unilever anche in Europa), e negli Stati Uniti
stanno raggiungendo gli scaffali dei supermercati. Colossi
dell’agroalimentare mondiale quali Kellogg’s, Nestlé e Cargill stanno
inoltre per sbarcare sul mercato con le loro proposte vegetali.
Tuttavia è forse bene chiarire alcuni aspetti fondamentali non
scontati e soprattutto non raccontati della “carne finta”, come viene
spesso chiamata non senza un certo disprezzo, che riguardano sia
la salute umana sia l’impatto ambientale.
In generale, si tratta di prodotti che hanno come base una farina
vegetale, per esempio di riso, di piselli o di soia, spesso proveniente
da piante Ogm. Purtroppo, però, le farine vegetali non sono affatto
buone da mangiare. Anzi, in alcuni casi possono assumere odori
disgustosi, e sapori assai poco appetibili.
Per renderle palatabili, negli ultimi decenni – perché le prime
polpette e simili sono in vendita da almeno una trentina d’anni – le
aziende hanno provato di tutto, e sono in effetti arrivate ad alimenti
che hanno saputo conquistarsi un proprio mercato grazie a una
corposa, spesso eccessiva, messe di coloranti, addensanti,
aromatizzanti, correttori del gusto, zuccheri, sale e tutto ciò che la
chimica moderna può offrire. Il risultato lo si vede, per esempio, in
uno studio pubblicato nel settembre del 2019 da ricercatori
australiani, che hanno analizzato nel dettaglio 560 prodotti da
supermercato (l’offerta nella grande distribuzione è cresciuta del
150% in meno di dieci anni), soprattutto per quanto riguarda il sale.
E hanno scoperto che il quantitativo medio di sale era di circa 1
grammo ogni 100 di prodotto (ovvero 379 milligrammi di sodio), cioè
un terzo del sale consigliato per ogni giorno, e che meno del 70%
dei prodotti aveva livelli di sale accettabili in base ai valori soglia
indicati dalle autorità sanitarie quali l’Oms, che ha fissato in tre
grammi la dose massima giornaliera, invitando tutti a ridurne il
consumo e gli stati a introdurre leggi specifiche per fissare valori
massimi per gli alimenti industriali. Perché troppo sale fa male alla
salute, ma da molti anni la sua concentrazione è in crescita negli
alimenti industriali e i consumatori occidentali, anche senza volerlo,
ne assumono troppo.
Le nuove false carni non sembrano tuttavia porsi più di tanto il
problema dell’eccesso di sale né quello, altrettanto grave e
importante, dello zucchero aggiunto, sul quale i dati, per ora,
latitano, ma che viene utilizzato in quantità in tutti gli alimenti
industriali, perché è un fenomenale correttore di gusti.
Oltre al sale e allo zucchero, poi, c’è il caso leghemoglobina, la
molecola che ha fatto fare a Impossible Foods il salto di qualità,
ovvero le ha permesso di offrire hamburger che hanno una
somiglianza assoluta con quelli di carne, grazie a quel liquido
rossastro che cola dalla polpa, che sembra proprio quello animale e
che conferisce quel retrogusto ferroso simile, anch’esso, a quello
della carne. E in effetti, da certi punti di vista, lo è, o è come se lo
fosse.
Il
colore rosso nel sangue dell’uomo è dato dall’emoglobina,
proteina del gruppo delle proteine chiamate “eme” che fissa il ferro e
regola gli scambi con l’ossigeno; negli animali e in alcune piante vi
sono molecole del tutto simili, che esercitano la stessa funzione. Per
questo i ricercatori di Impossibile Foods hanno pensato di inserire
una forma di emoglobina vegetale, quella della soia, detta appunto
leghemoglobina, nei loro surrogati vegetali. Per averne quantità
sufficienti per le migliaia di ristoranti che ormai devono accontentare
e per il recente arrivo nei supermercati, hanno dovuto tuttavia
accelerare la sintesi e ricorrere a fabbriche biologiche come i lieviti,
nei quali hanno inserito il gene specifico della leghemoglobina per
ottenerne quantità enormi in poco tempo. Hanno cioè fatto ricorso a
un’operazione che sfrutta al meglio le potenzialità tecnologiche della
modificazione genetica.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :



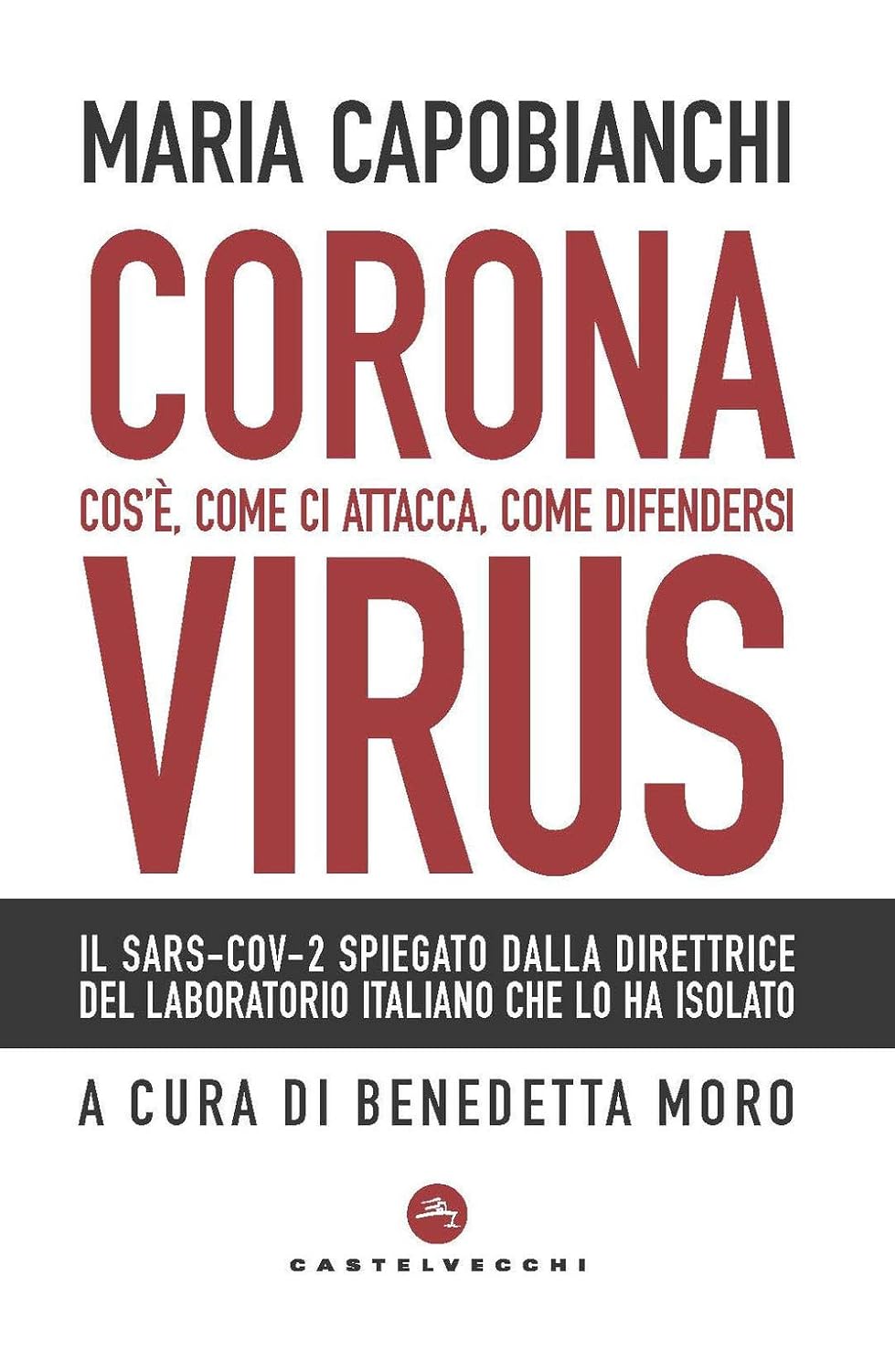
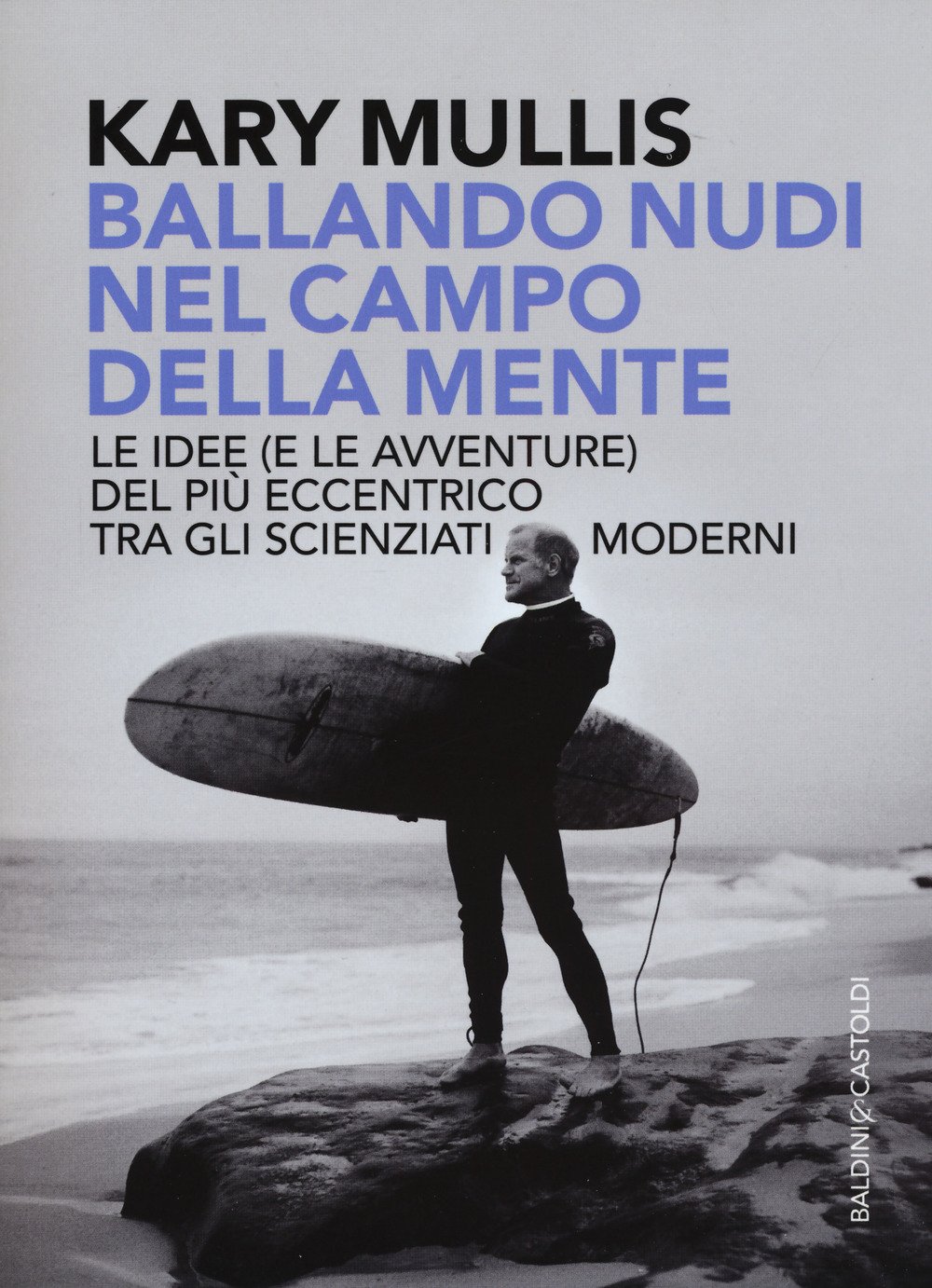
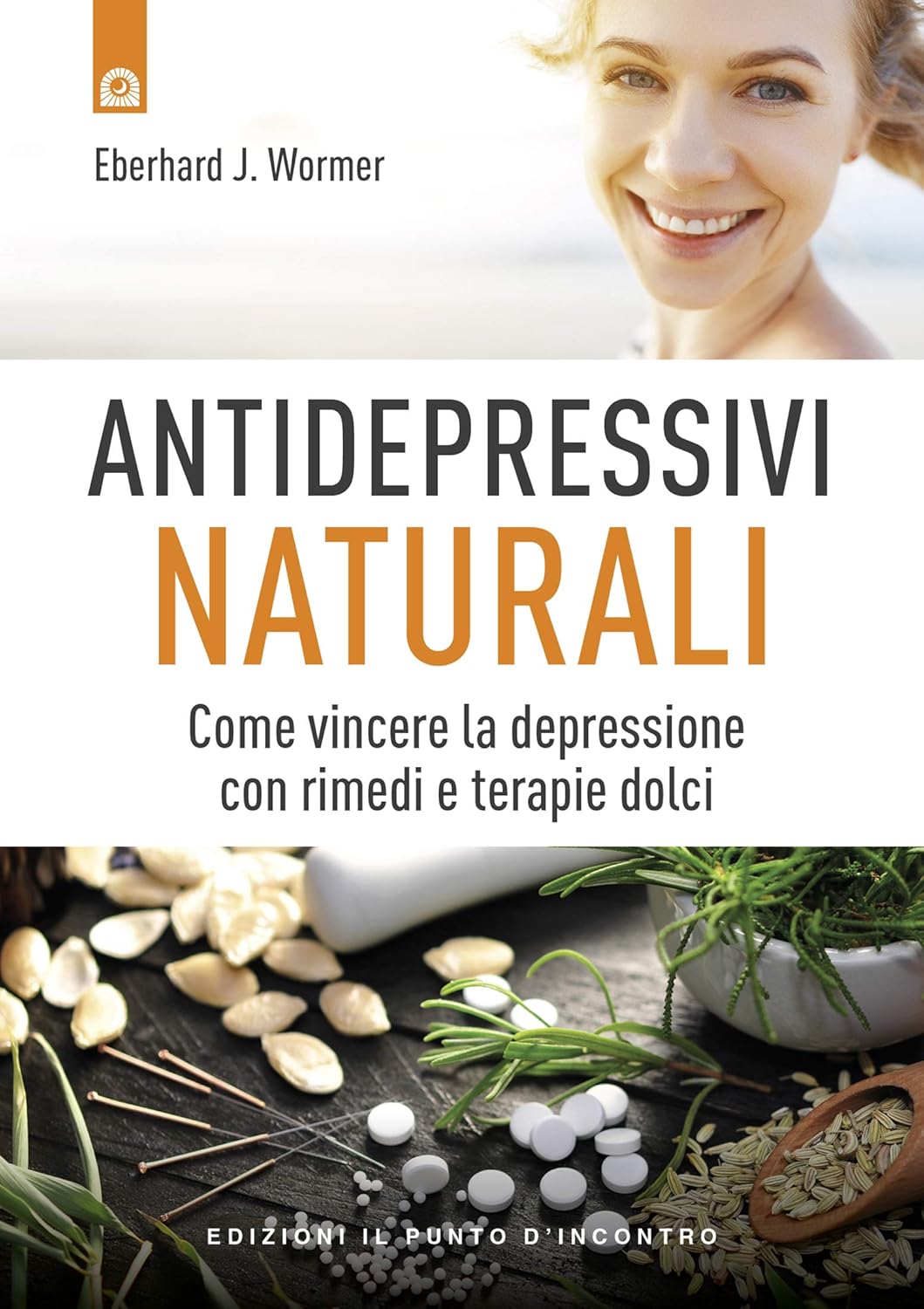
Commento all'articolo