Quaderni dal carcere – Antonio Gramsci
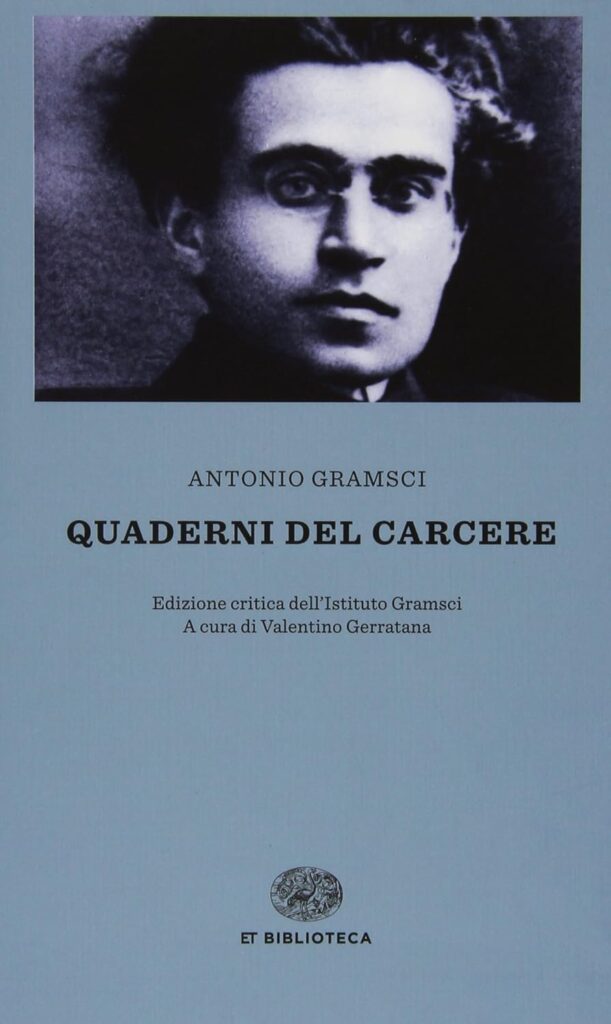
SINTESI DEL LIBRO:
Alle 22,30 dell’8 novembre 1926 il deputato comunista Antonio
Gramsci, segretario del suo partito, venne arrestato nella casa dove
aveva affittato una camera, in via Giovan Battista Morgagni 25 a
Roma, e rinchiuso in stretto isolamento presso il carcere di Regina
Coeli.
Già nella prima lettera dal carcere che di lui si conservi1, dopo
essersi scusato con la sua padrona di casa «per i disturbi e i fastidi
[…] i quali non entravano, in verità, nell’accordo di inquilinato»,
Gramsci chiede immediatamente di poter ricevere tre libri:
Vorrei avere questi libri:
1° la Grammatica tedesca che era nello scaffale accanto
all’ingresso; 2° il Breviario di linguistica di Bertoni e Bartoli2 che era
nell’armadio di fronte al letto; 3° gratissimo le sarei se mi inviasse
una Divina Commedia di pochi soldi, perché il mio testo lo avevo
imprestato.
Se i libri sono rilegati, occorre strappare il cartone, badando che i
fogli non si stacchino
[…]3.
Antonio Gramsci ha insomma ben chiara, fin dai primi giorni della
sua detenzione, la necessità di rendere il tempo che lo attende in
carcere essenzialmente un tempo di studio4. E si tratta di un tempo
lungo: Gramsci non si fece mai il-1 Alla signora Clara Passarge, sua
padrona di casa; la missiva, intercettata dalle autorità fasciste, non
giunse mai a destinazione e si conservò allegata agli atti del
processo contro Gramsci. La missiva non è datata, ma essendo
stato Gramsci detenuto a Regina Coeli dall’8 al 25 novembre, e
considerando che già il 19 gli fu comunicata la condanna al confino
(di cui non c’è traccia nella lettera alla signora Passarge) essa risale
al primissimo periodo della vita carceraria di Gramsci e certamente
precede la prima lettera alla moglie Giulia (datata 20 novembre); la
si può leggere in A.
GRAMSCI, Lettere dal carcere, a cura di S. Caprioglio e E.
Fubini, Torino 1965, p. 3.
2 Si tratta di G. BERTONI e M. G. BARTOLI, Breviario di
neolinguistica, Modena 1925. All’Università di Torino d Bartoli era
stato professore di Glottologia di Gramsci che aveva curato
personalmente le dispense del corso; è in Glottologia anche l’unico
trenta e lode della breve carriera universitaria di Gramsci, conseguito
il 12 novembre 1912. Gramsci tornerà sulla richiesta in una lettera a
Tania del 3 ottobre 1927: «Ancora, desidero avere il Manualetto di
linguistica di Giulio Bertoni e Matteo Giulio Bartoli, stampato a
Modena nel 25 o 26» (A. GRAMSCI, Lettere dal carcere cit., p. 134).
Si veda, ancora, un affettuoso ricordo del «buon professor
Bartoli», ibid., pp. 58-59. Forse proprio l’affetto per il Bartoli rende al
contrario assai duro il giudizio di Gramsci nei Quaderni sul Bertoni
(cfr.: ID., Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci,
a cura di V. Gerratana, 4 voll., Torino 1975, I, pp. 351-52, e passim).
D’ora in poi citeremo in modo abbreviato i Quaderni facendo
riferimento a questa edizione critica: faremo seguire alla sigla Q in
corsivo il numero arabo assegnato al quaderno nell’edizione critica
citata e, dopo la virgola, la pagina dell’edizione stessa. Tralasceremo invece, per non appesantire il testo, la numerazione dei
Quaderni effettuata da Tatiana Schucht alla morte di Gramsci, che
l’edizione critica conserva fra parentesi (in numeri romani) dopo la
nuova numerazione (cfr. infra, pp. 622-23) 3 ID., Lettere dal carcere
cit., p. 3. La necessità di strappare la rilegatura dipende dal
regolamento carcerario.
4 Sono dedicate a questa intenzione le richieste di libri e riviste
che riempiono le lettere di Gramsci fin dai primi mesi di detenzione,
cioè molto prima che (a Turi, nel 1929) egli possa intraprendere il
lavoro di stesura dei Quaderni (cfr. infra, p. 96).
Letteratura italiana Einaudi
5
«Quaderni dal carcere» di Antonio Gramsci - Raul Mordenti
lusioni a proposito della durata della sua detenzione; se già nella
citata lettera al-la signora Passarge invita la sua pigionante a
«ritenere libera la stanza e dispor-ne», nella prima lettera a sua
moglie Giulia (Julca) Schucht respinge implicita-mente da sé l’idea,
avanzata dalla donna «che noi due siamo ancora abbastanza
giovani per poter sperare di vedere insieme crescere i nostri
bambini»5, e il 25
aprile 1927 scrive alla madre: «sono anche arcisicuro che sarò
condannato e chissà a quanti anni»6. Il 12 marzo 1928, prima
ancora del processo, scrive ancora a sua madre:
Adesso sarò certamente condannato a molti anni, nonostante
che l’accusa contro di me si basi su un semplice referto della polizia
e su impressioni generiche incontrollabili
[…]. Ecco perché io sono così tranquillo. Tu pensi che ciò che
deve contare sono queste circostanze accessorie, ma il fatto reale
della condanna e del carcere dà soffrire? Ma de-vi anche contare la
posizione morale, non ti pare? Anzi è solo questo che dà la forza e
la dignità. Il carcere è una bruttissima cosa; ma per me sarebbe
anche peggiore il disono-re per debolezza morale e per
vigliaccheria7.
Se volessimo (utilizzando anche noi il metodo di studio a cui
Gramsci fu costretto)8 percorrere fino in fondo le labili tracce ed i
riposti significati di quella primissima lettera scritta dal carcere alla
sua padrona di casa, allora si potrebbe sottolineare che lo studio a
cui Gramsci si dispone presenta già dei connotati precisi: esso
riguarda argomenti di alta cultura, für ewig (per sempre) come lo
stesso Gramsci scriverà più tardi, cioè non limitati o troppo
immediatamente legati alla contingenza politica; ed entro
quest’ambito o livello unificante Gramsci 5 A. GRAMSCI, Lettere dal
carcere cit., p. 5.
6 Ibid., p. 80.
7 Ibid., pp. 188-89. Si vedano anche le lettere (a Tania del 6
settembre 1928, ibid., pp. 227-29 e passim) in cui Gramsci esprime
la sua collera per il progetto di farlo trasferire nel più accogliente
carcere di Soriano al Cimino o di ottenere la commutazione del
carcere in confino. Scrive al fratello Carlo il 3 dicembre 1928:
«Tatiana mi ha disilluso; credevo fosse più sobria nell’immaginazione
e più pratica. Vedo invece che si fa dei romanzi, come quello che sia
possibile che la reclusione venga trasformata, per ragioni di salute,
in confino: possibile in via ordinaria, già si intende, cioè in virtù delle
leggi e regolamenti scritti. Ciò sarebbe possibile solo per via di una
misura personale di grazia che sarebbe concessa, già s’intende,
solo dietro domanda motivata per cambiamento di opinioni e
riconoscimento ecc. ecc.
Tatiana non pensa a tutto ciò: è di una ingenuità candida che mi
spaventa qualche volta, perché io non ho nessuna intenzione né di
inginocchiarmi dinanzi a chicchessia, nè di mutare di una linea la
mia condotta. Io sono abbastanza stoico per prospettarmi con la
massima tranquillità tutte le conseguenze delle premesse suddette.
Lo sapevo da un pezzo cosa poteva succedermi. La realtà mi ha
confermato nella mia risoluzione, nonché scuotermi per nulla. Dato
tutto ciò, occorre che Tatiana sappia che di simili romanzi non
bisogna neanche parlare, perché il solo parlarne può far pensare
che si tratti di approcci che io posso aver suggerito. Questa sola idea
mi irrita. Fa il piacere di scrivere tu queste cose a Tatiana, perché se
le scrivo io, temo di trascendere e di offendere la sua sensibilità» (
ibid. p. 239). Secondo Ercole Piacentini, che incontrò Gramsci in
carcere, a Turi: «Era molto malato. In verità Gramsci era convinto di
non uscire vivo dal carcere» (E. PIACENTINI, Con Gramsci in
carcere testimonianza raccolta da P. Giannotti, in
«Rinascita», XXXI (1974), 42, p. 32).
8 Gramsci scrive a Tania: «Ricostruire da un ossicino un
megaterio o un mastodonte era proprio di Cuvier, ma può avvenire
che con un pezzo di coda di topo si ricostruisca invece un serpente
di mare» (A. GRAMSCI Lettere dal carcere cit., p. 314; cfr. anche Q
28, p. 2327 e passim).
Letteratura italiana Einaudi
6
«Quaderni dal carcere» di Antonio Gramsci - Raul Mordenti
allude a tre direttrici: lo studio delle lingue straniere (qui il
tedesco) per potere tradurre; gli interrotti (ma sempre presenti) studi
universitari di linguistica; la Divina Commedia, cioè il testo letterario
per antonomasia della nostra tradizione culturale. Tutte e tre queste
direttrici qui subito accennate nei primissimi giorni della detenzione
saranno peraltro percorse, in varia misura, nel corso del lungo lavoro
dei Quaderni.
Inizia insomma fin dai primi giorni del carcere la lotta personale e
psicologica, ma anche politica, di Gramsci contro i devastanti effetti
di abbrutimento9 che il carcere reca con sé:
ho sempre la paura di essere soverchiato dalla routine
carceraria. E questa una macchina mostruosa che schiaccia e livella
secondo una certa serie. Quando vedo agire e sento parlare uomini
che sono da 5, 8, 10 anni in carcere, e osservo le deformazioni
psichiche che essi hanno subito, davvero rabbrividisco, e sono
dubbioso nella previsione su me stesso. Penso che anche gli altri
hanno pensato (non tutti ma almeno qualcuno) di non lasciarsi
soverchiare e invece, senza accorgersene neppure, tanto il processo
è lento e molecolare, si trovano oggi cambiati e non lo sanno, non
possono giudicarlo, perché es-si sono completamente cambiati.
Certo io resisterò10.
Questa determinazione morale di Gramsci, talvolta eroica anche
se mai reto-ricamente atteggiata o autocompiaciuta («Io non voglio
fare né il martire né l’e-roe. Credo di essere semplicemente un uomo
medio, che ha le sue convinzioni profonde, e che non le baratta per
niente al mondo»)11, è il terreno su cui si costruisce l’intero edificio
dei Quaderni. Non a caso lo stesso verbo, «resistere», comparirà
all’estremo opposto della parabola di Gramsci, in una delle ultimissime sue lettere a Giulia, datata 25 gennaio 1936.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
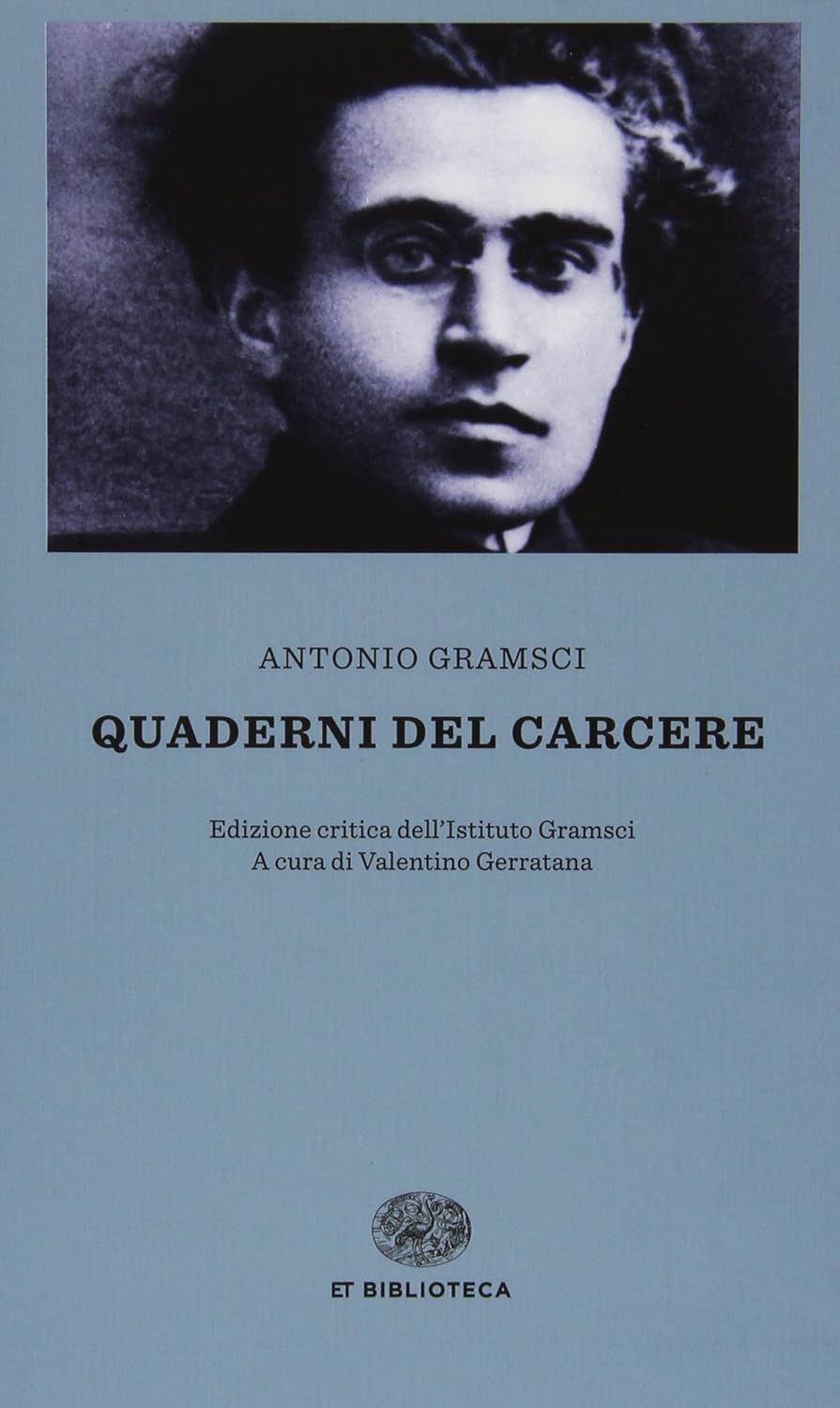






Commento all'articolo