Odio gli indifferenti – Antonio Gramsci
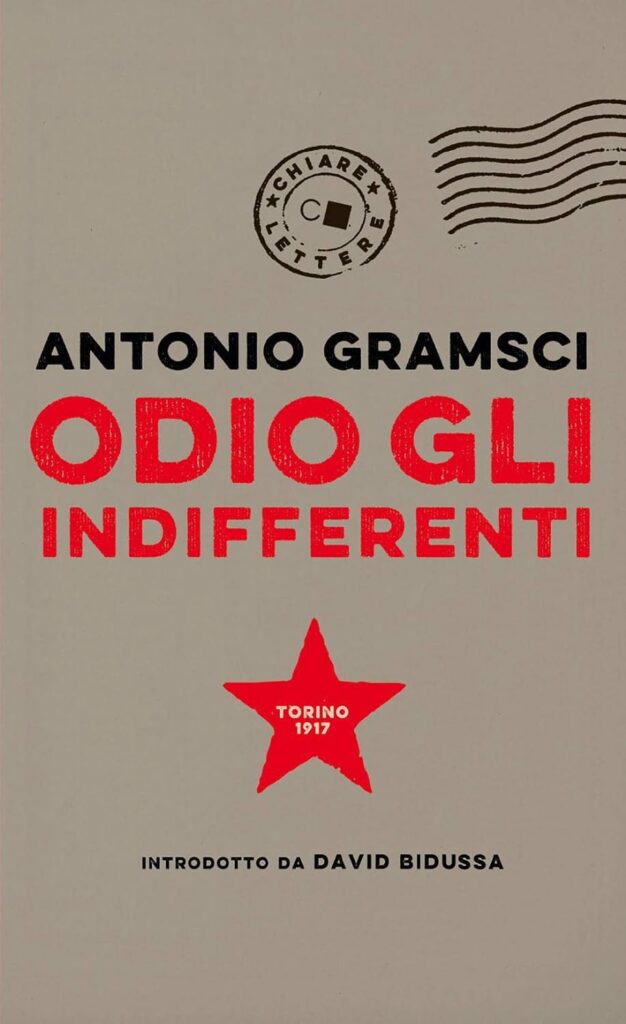
SINTESI DEL LIBRO:
All’inizio c’è il disprezzo.
«Odio gli indifferenti» sono le prime parole che il lettore si trova di fronte.
Ma poi occorre l’intelligenza, se si vuol provare a cambiare. L’intelligenza
per cogliere i molti malesseri della società italiana, quelli che ancora oggi
sono irrisolti: la nullità della classe politica; il trasformismo; l’assenza del
senso dell’istituzione parlamentare nella coscienza pubblica; il conflitto
politica-magistratura; la scuola; gli scandali; la dimensione astratta della
libertà nella vita politica; il «perbenismo». Intelligenza, tuttavia, non significa
solo «essere puntuti», ma anche scavare nelle parole arroganti dell’avversario
e costringerlo, appunto, con l’intelligenza, sulla difensiva.
Il frammento del discorso parlamentare che chiude questa antologia, un
testo continuamente interrotto dalle urla, lo dimostra. Un testo in cui Gramsci
costringe sulla difensiva Mussolini, formalmente non ancora, ma nei fatti già
«duce», riuscendo a mantenere la parola e a parlare per ultimo. La politica
non è mai solo forza, è anche autorevolezza. E l’autorevolezza dei «senza
potere» si chiama intelligenza. Persino quando si è puniti per la propria
intelligenza. E il proprio coraggio.
A un primo sguardo, si potrebbe far rientrare questi scritti di Gramsci nella
rubrica «l’Italia com’è oggi non ci piace», per riprendere la dichiarazione
perentoria di Giovanni Amendola. Sarebbe banale. Li distingue l’adesione
alla politica più che il fascino per l’antipolitica, ma anche la determinazione
di parlare di una realtà concreta, di comprenderne i meccanismi. Non solo di
lamentarsi.
In questi scritti c’è il Paese Italia, come scriveva, inascoltato, in anni più
vicini a noi, Ruggiero Romano. Il Paese Italia, non la nazione italiana: le cose
minute, i comportamenti, i caratteri, l’alimentazione, la retorica, i tic che si
hanno, le parole che si usano, le consuetudini con cui si organizza la vita
associata. Una realtà che sollecita l’indagine sulla vita reale non la
costruzione di proiezioni ideologiche.
Ma rimaniamo a quel tempo storicamente definito.
Un evento: la guerra. Un luogo: Torino. Un tempo: il 1917-1918. In
mezzo: Caporetto; gli scioperi per il pane; la caduta dello zar in Russia e poi
la presa del Palazzo d’Inverno; l’entrata in guerra degli Stati Uniti; l’ingresso
delle truppe inglesi a Gerusalemme; la fine del conflitto e la dissoluzione
degli imperi centrali. In mezzo l’inizio dell’ultima grande epidemia d’Europa,
la Spagnola (solo in Italia mezzo milione di morti, tra il 1918 e il 1919). È il
Novecento, definitivamente.
In quella temperie Gramsci è uno dei pochi intellettuali giovani che una
malformazione fisica ha tenuto lontano dalla trincea. Molti dei suoi amici
sono stati richiamati, alcuni non torneranno. A Torino la fame, la stanchezza,
le fabbriche con gli operai che ritornano a occupare il centro della scena. C’è
la guerra con tutte le sue miserie, ma anche con tutti i problemi che iniziano a
intravedersi. Occorre un occhio acuto per fissarli e uno sguardo lungo per
dare loro un senso. Antonio Gramsci li ha entrambi.
Riconsideriamo i temi di questi scritti: Contro la burocrazia , la reiterata
vicenda di una estenuante storia di inefficienza; Come cambia il linguaggio e
Capovolgimenti del senso comune, la disintegrazione delle parole nel
linguaggio pubblico, la denuncia della loro inconsistenza; Politici inetti, la
crisi della classe politica; Capitalismo fuori controllo, la «clip» di un film le
cui parti in commedia costituiscono uno schema consolidato; Le donne, i
cavalieri e gli amori, un’esposizione dei molti vizi privati e pubbliche virtù
che ci caratterizzano; Risorgimento e Unità d’Italia , il nostro amore freddo
per il Risorgimento, che ha radici lunghe.
Ma non è l’«Italia eterna». Per Gramsci il problema è come si delinei una
fuoriuscita che prima di tutto significa rifiutare l’accettazione passiva e prona
della realtà. È per questo che Gramsci «si mette in ascolto», e non perde un
particolare. Gli uomini e le donne non sono pupazzi. Per pensare una risposta
che contribuisca a migliorare la loro vita si tratta di prendere in carica,
seriamente, la loro fatica quotidiana, continuando a esserci anche quando si
tratta di fare i conti con una sconfitta epocale (è il tema di Gli operai della
Fiat). Appunto: contrastare la convinzione che non ci sia cambiamento e che
la quotidianità possa apparire come l’unico dei mondi possibili.
«Nel 1918 e nel 1919 non c’era che una sola sezione socialista a Torino e
aveva sede nel palazzo dell’Alleanza cooperativa. L’assemblea si teneva in
una grande sala, affollatissima. Gramsci non era tra i primi a giungere.
Quando giungeva, passava inosservato tra i presenti, già appassionati nella
discussione, e andava a mettersi nel vano di una portafinestra che dava sul
balcone esterno. Lì prendeva una seggiola, l’appoggiava al muro, si sedeva e
stava a seguire e ad ascoltare.»
In questo ricordo di Umberto Terracini, che assomiglia molto a un
«frammento cinematografico», c’è più di uno scorcio della Torino subito
dopo la guerra. Comunque più del ritratto simpatetico, ma anche di maniera,
che spesso di Gramsci è rimasto. Uno sguardo dove predomina, soprattutto in
coloro che l’hanno frequentato negli anni di Torino tra guerra e immediato
dopoguerra, la sensazione di avere di fronte un soggetto geniale, vivace,
testardo, ma «amico», e perciò da tutelare, su cui stendere una rete di
protezione in una sorta di solidarietà nell’utopia.
Nei ricordi di chi ebbe modo di frequentarlo, Antonio Gramsci è descritto
come un uomo che parlava molto, ascoltava volentieri. Un uomo con lo
sguardo attento, un buon sorriso, intransigente, categorico, rafforzato da una
concezione stoica della vita e della morale e dotato di una vocazione
pedagogica spiccata. Una figura che molti guardano con rispetto, ma che non
è immediatamente «il Capo». Gramsci, per diventarlo, ha dovuto superare un
lungo tirocinio politico tra il dopoguerra e il suo arresto (novembre 1926).
La costruzione della dittatura fascista fa emergere definitivamente la sua
statura intellettuale. La sconfitta politica della sua parte, soprattutto la
consapevolezza che occorra attraversare un lungo purgatorio, costringe
Gramsci a misurarsi con una riflessione tutta rivolta a riformulare una
piattaforma politica in grado di rispondere alla nuova realtà. È di nuovo
l’intelligenza a tornare in campo.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
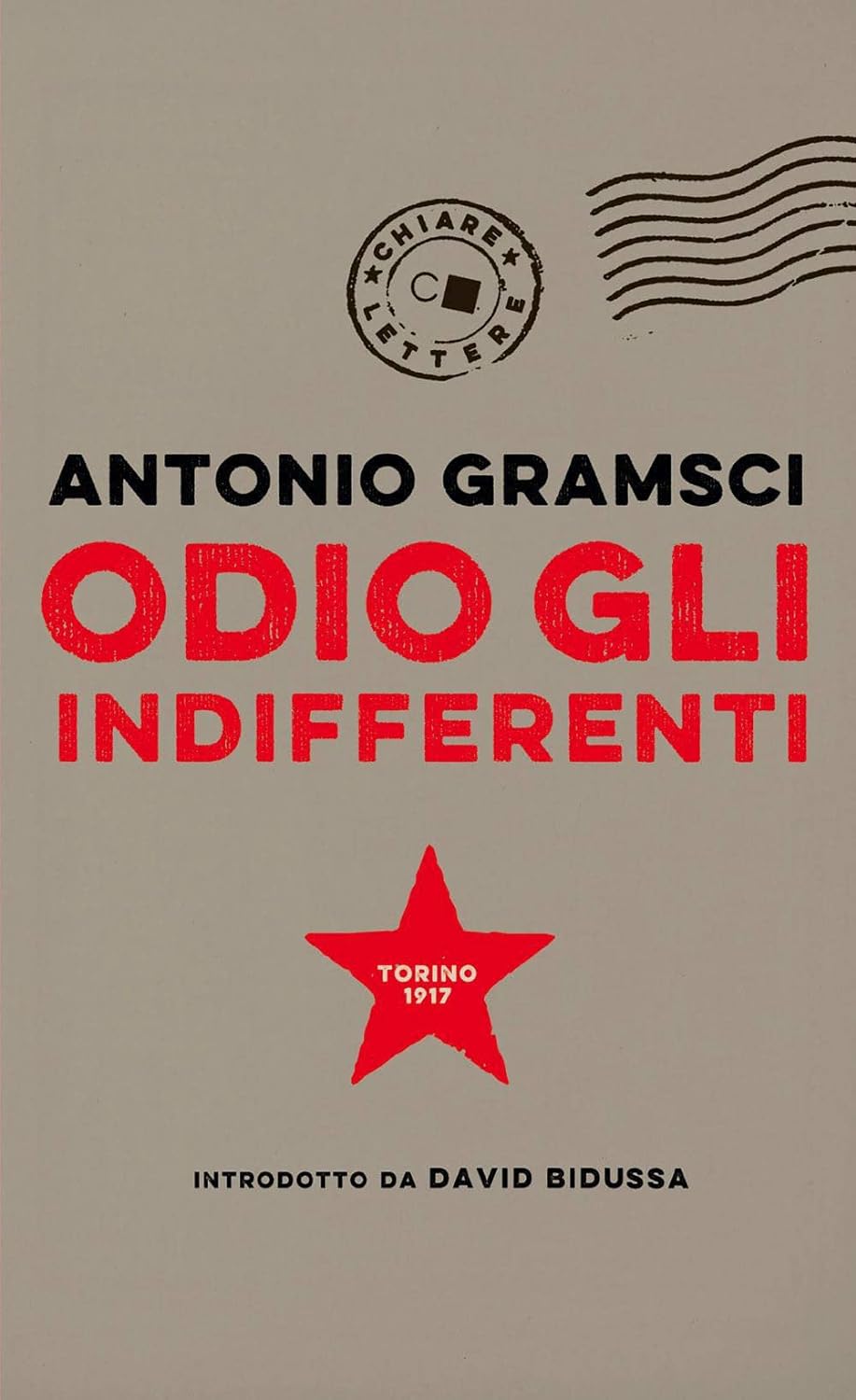






Commento all'articolo