Genitori gentili – Interpretare le emozioni per crescere figli calmi e felici – Sarah Ockwell-Smith
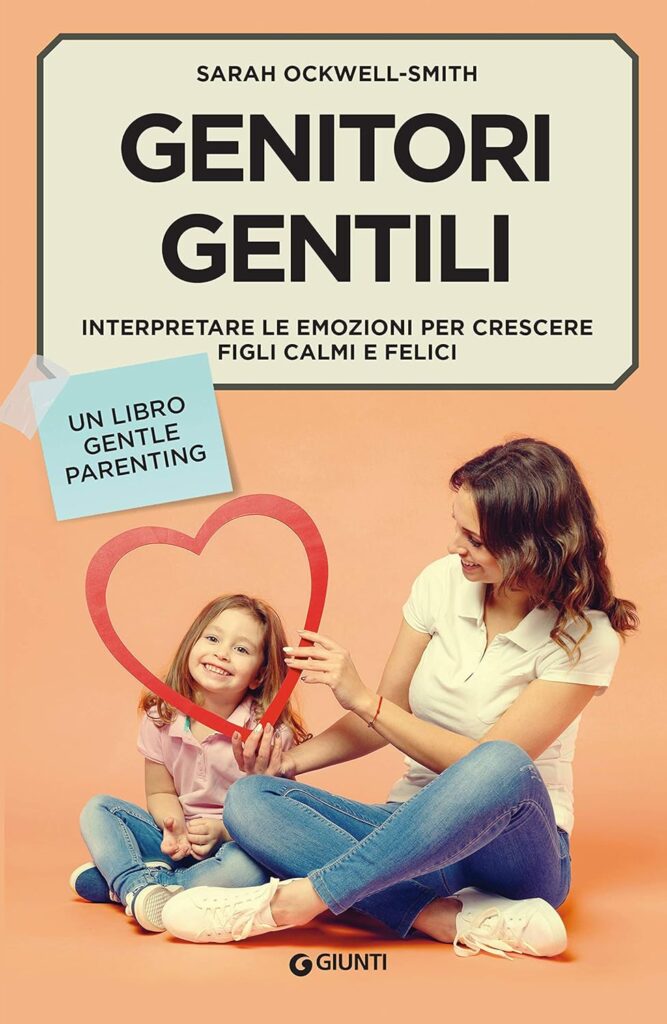
SINTESI DEL LIBRO:
Essere genitori gentili non vuol dire essere perfetti. Tutti i genitori
commettono errori. L’importante è imparare dai propri errori: capire
cosa è successo, perché e come si può agire meglio la volta
successiva. In questa prospettiva, che un genitore faccia un errore
non è solo comprensibile, ma fondamentale. Perché è proprio
quando non agiamo nel migliore dei modi, che possiamo imparare
ad agire meglio in futuro. Essere genitori gentili vuol dire, quindi,
accettarci in quanto imperfetti, perdonare i nostri errori e impegnarci
a crescere come genitori. Così come i nostri figli, anche noi siamo in
un processo di apprendimento. Abbiamo tutti giornate storte,
giornate in cui alziamo la voce, giornate di cui ci vergogniamo. Ma
essere genitori gentili vuol dire mantenere i piedi per terra e capire
quando siamo stressati e abbiamo bisogno di un po’ di tempo per noi
stessi in modo da poter essere genitori migliori. Questa necessità è
così importante che le ho dedicato un intero capitolo (vedi
capitolo
10).
La genitorialità gentile non richiede altro che amore, dedizione e
coerenza. Non è una scienza riservata a genitori naturalmente
predisposti alla calma o eruditi, a genitori che decidono di restare a
casa con i figli o a quelli con un figlio unico. Denaro, lauree e
carattere non sono importanti, né lo sono il tipo di genitori con cui si
è cresciuti, o se si è cominciato il proprio percorso da genitore
usando un approccio diverso. Il
capitolo 8 è dedicato a quei genitori
che utilizzavano altri metodi, forse meno gentili, e stanno cercando
un’altra via. Troverete anche una sezione dedicata a come affrontare
le critiche dirette al vostro modo di essere genitore e cosa aspettarvi
in termini di risultati (quando questi potrebbero iniziare a vedersi e
cosa fare se la genitorialità gentile sembra non funzionare).
Perché la genitorialità gentile è importante?
Viviamo in un mondo in cui le cose sono più importanti delle
persone. Tutto ruota intorno ad acquistare oggetti e a ricercarne
sempre di più. Passiamo così tanto tempo rimuginando sul passato
e pianificando il futuro, che ci dimentichiamo di vivere nel presente,
spesso trascurando le cose davvero importanti. La nostra società è
egoista, violenta e di corte vedute. Preferisce che ci si conformi ai
più, piuttosto che rispettare l’individualità. E questo è il mondo a cui
stiamo preparando i nostri figli. Ma dobbiamo davvero farli crescere
in linea con quest’ideologia?
Cos’è più importante: la felicità o l’adeguamento al sistema?
Possiamo crescere bambini che rispettino il proprio corpo e i propri
pensieri, invece di creare le basi per futuri problemi di autostima e di
accettazione della propria immagine? Possiamo crescere una
generazione che prenda a cuore l’ambiente, invece di vedere tutto
come veloce, facile e usa e getta? Paradossalmente, cercando di
inserire i nostri figli nella società, ci dimentichiamo di cos’è
davvero meglio per loro. Come possiamo sperare che cambi
qualcosa nel mondo, se non mettiamo in discussione le credenze
comunemente accettate e incoraggiamo i nostri figli a fare
altrettanto?
La genitorialità gentile va oltre i singoli momenti passati con i
propri figli: essere genitori gentili pone le basi per un futuro migliore
per tutti noi. Essere genitori gentili vuol dire creare un futuro in cui la
felicità non dipenda dalla casa in cui si vive, dalla macchina che si
guida o dalla marca dei vestiti che si indossano. Vuol dire creare un
futuro in cui la violenza sia drasticamente ridotta e in cui opinioni e
credenze diverse non siano solo rispettate ma apprezzate. Un futuro
in cui la disciplina non si ottenga infliggendo, ai membri più
vulnerabili della società, pene corporali, dolore, esclusione,
vergogna e colpe.
Opinioni comuni sull’educazione dei bambini durante il secolo
scorso
Per capire meglio il modo in cui siamo stati cresciuti e le opinioni comunemente diffuse
nella società odierna, penso sia importante analizzare l’evoluzione delle tendenze
dominanti sull’educazione dei bambini nel corso del secolo scorso.
All’inizio del ventesimo secolo, si tendeva a esigere molto dai bambini e a rispondere
poco ai loro bisogni, esercitando un forte controllo genitoriale: uno stile che può essere
definito come autoritario. Nel 1913, Sir Frederick Truby King, medico fondatore della
Plunket Society neozelandese (un servizio che fornisce una varietà di servizi per la salute
dei bambini), pubblicò un libro sull’educazione dei bambini, intitolato Feeding and Care of
Baby (Cura e alimentazione dei neonati). A Truby King viene attribuito il merito di un
miglioramento radicale della nutrizione dei bambini in Nuova Zelanda, ma è più noto,
forse, per il suo approccio autoritario alla disciplina e il suo ethos del distacco. Il medico
consigliava, infatti, di adottare un rigido orario che prevedeva di allattare i neonati ogni
quattro ore di giorno e di non allattarli affatto durante la notte. Raccomandava di far
dormire i bambini nella loro cameretta fin dalla nascita, di lasciarli fuori nel passeggino
per i riposini e di non coccolarli per più di dieci minuti al giorno. Ciò, riteneva egli, avrebbe
lasciato il bambino libero di utilizzare tutta la sua energia per crescere e svilupparsi,
senza essere disturbato dal legame con i genitori. Truby King sosteneva che la scuola
dovesse temprare i bambini per prepararli al servizio militare e addestrare le bambine per
diventare madri e brave donne di casa.
Nel 1928, lo psicologo americano John B. Watson pubblicò il libro Psychological Care of
Infant and Child (Cura psicologica dell’infante e del bambino). Per Watson, i bambini
venivano, in un certo senso, prodotti più che dati alla luce. Egli riteneva che il sentimento
dell’amore nei neonati scaturisse dal contatto e dalle carezze, e, per questo, consigliava
alle madri di non coccolare troppo i propri bambini, per evitare che diventassero adulti
con un permanente bisogno di coccole e difficoltà a formare relazioni a causa di un
attaccamento troppo forte alla propria madre. Watson sintetizzò le sue idee come segue:
«Non abbracciateli né baciateli mai e non teneteli seduti in braccio. Se proprio dovete,
baciateli sulla fronte e solo al momento della buonanotte. Salutateli con una stretta di
mano al mattino. Premiateli con un buffetto sulla testa se hanno fatto un ottimo lavoro o
portato a termine un compito particolarmente difficile». Inoltre, Watson enfatizzava
l’importanza di una rigida tabella oraria che regolarizzasse tutte le aree della vita del
bambino, stabilendo quando farli mangiare, bere, dormire, giocare e quando cambiargli il
pannolino. Benché Watson sia famoso per le sue raccomandazioni dure e
potenzialmente nocive, non tutte le sue opinioni sono da scartare. Ad esempio, Watson
consigliava di far crescere i bambini in un ambiente calmo e non violento e incoraggiava i
genitori a promuovere la loro indipendenza, tenendoli occupati e coinvolti, in modo da
ridurre l’insorgenza di accessi di rabbia.
Nel 1946, il pediatra americano Benjamin Spock pubblicò il libro Il bambino. Come si cura
e come si alleva. Spock è noto per aver introdotto più affetto ed emozioni nel mondo della
genitorialità e per aver proposto un approccio considerevolmente innovativo rispetto a
quello vigente all’epoca. Spock è famoso per essersi rivolto alle madri di tutto il mondo
dicendo loro «Sai più di quello che pensi di sapere» e incoraggiandole a dare ascolto e
fiducia a sé stesse e ai loro bambini. Spock promuoveva una routine più flessibile,
individuale e improntata ai bisogni del bambino, in un periodo in cui quasi tutti gli esperti
raccomandavano ai genitori di esercitare un rigido controllo. Questo gli costò una valanga
di critiche che lo accusavano di promuovere un tipo di educazione permissivo, basato
sulla gratificazione istantanea di neonati e bambini. Benché il libro abbia venduto più di
cinquanta milioni di copie, queste critiche lo accompagnarono per oltre cinquant’anni, fino
alla sua morte nel 1998.
Negli anni cinquanta e sessanta, Donald Winnicott, pediatra e psicoanalista britannico,
elaborò i concetti di holding (sostegno) e di «madre sufficientemente buona», tuttora
validi. Per Winnicott, l’atto della madre di «sostenere» suo figlio, sia fisicamente sia
psicologicamente, serve a fornirgli la fiducia e il supporto necessari per crescere e
svilupparsi, diventando un adulto sano. Riteneva infatti che «le fondamenta della salute
sono poste dalla madre comune nel suo atto, anch’esso comune, di accudire
amorevolmente il suo bambino» e fu inoltre promotore di una maggiore empatia e fiducia
nei confronti delle mamme. Il suo concetto di madre sufficientemente buona metteva in
evidenza il fatto che sono proprio i piccoli errori della madre ad agevolare lo sviluppo del
figlio. Sosteneva che non ci fossero madri perfette e che, in realtà, la perfezione fatta
madre fosse controproducente: «la madre dà il meglio di sé quando si affida al proprio
1
giudizio».
Nel 1951, l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicò l’opera dello psicologo
britannico John Bowlby: Cure materne e salute mentale del bambino. Il suo pensiero si
basava in gran parte sull’osservazione di bambini ricoverati in ospedale separati dai loro
genitori e sull’opera di René Spitz, che aveva studiato le conseguenze subite da bambini
orfani o separati dai loro genitori durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Al contrario
di Watson e Truby King, Bowlby riteneva che l’amore e l’affetto fossero indispensabili alla
crescita sana del bambino. Le sue teorie promuovevano un alto grado di reattività. In uno
dei suoi passaggi più conosciuti, scrive che «un principio d’importanza fondamentale per
la salute mentale» è che «il neonato ed il bambino piccolo dovranno essere allevati in
un’atmosfera calda e dovranno essere uniti alla propria madre (o alla persona che ne fa
le veci) da un legame affettivo intimo e costante, fonte per entrambi di soddisfazione e di
gioia».
2Più tardi, insieme alla sua collega Mary Ainsworth, Bowlby sviluppò le sue idee
raggruppandole attorno a un concetto noto come «teoria dell’attaccamento», alcuni
elementi del quale hanno formato le basi per la definizione di uno stile di genitorialità
chiamato appunto dell’attaccamento.
Nel 1977, fu pubblicato il libro di Penelope Leach Come allevare il bambino dalla nascita
ai 6 anni, che ha venduto a oggi più di due milioni di copie. I temi portanti erano empatia,
fiducia e connessione, veicolati da uno stile genitoriale autorevole, con un alto grado di
reattività. Leach sosteneva fermamente una genitorialità guidata dal bambino, libera dalle
routine imposte dai genitori.
Poi, nel 1985, il pediatra americano Richard Ferber portò alla ribalta il concetto di
educazione al sonno attraverso l’estinzione graduale del pianto, il cry-it-out, un metodo
promosso quasi cento anni prima dal pediatra americano Luther Emmett Holt. Benché
Ferber abbia esaminato molteplici approcci volti ad affrontare i problemi relativi al sonno
dei bambini, è forse meglio conosciuto per la cosiddetta «ferberizzazione»: il processo
che consiste nel lasciar piangere un bambino per intervalli di tempo crescenti fino a che
non impari a dormire tutta la notte senza piangere e senza bisogno di aiuto da parte dei
genitori. Questo approccio è molto esigente nei confronti dei bambini e richiede poco
sforzo di reattività da parte dei genitori: è un classico esempio di un approccio autoritario
alla genitorialità.
Nel 1999, il bestseller della puericultrice Gina Ford Il primo anno del bambino, segnò un
netto ritorno a uno stile genitoriale più autoritario, incentrato sui genitori. Ford sosteneva
la necessità di seguire una routine imposta dai genitori che coprisse quasi tutti gli aspetti
della giornata del bambino, stabilendo quando dovesse mangiare, dormire e giocare.
Inoltre, consigliava di sottoporre i bambini all’educazione al sonno.
Queste tendenze continuarono a imperversare nel primo decennio degli anni 2000, con la
«super tata» Jo Frost, che, attraverso i suoi libri e programmi televisivi, guidò milioni di
famiglie verso uno stile di genitorialità autoritario, rigido e severo. Frost viene
generalmente ricordata per il suo «scalino del bambino cattivo», un metodo per
controllare comportamenti indesiderati che consiste nel punire i bambini mettendoli in
isolamento su un gradino.
Così, nel giro di poco più di cento anni, sembrerebbe si sia chiuso il cerchio, nonostante
molti studi scientifici abbiano dimostrato che lo stile genitoriale reattivo e autorevole, e
non autoritario, sia il più sano ed efficace. Non dimentichiamoci, quindi, che le tendenze
prevalenti al tempo in cui sono cresciuti i nostri genitori e nonni erano probabilmente di
stampo autoritario. Probabilmente, avranno pensato che i loro genitori avessero fatto del
loro meglio crescendoli in quel modo e che di sicuro quello fosse il modo migliore di
crescere voi. Per questo, forse, si chiederanno perché non stiate scegliendo di seguire lo
stesso metodo per crescere i vostri figli.
Cosa non vuol dire essere genitori gentili
Chiariamo questo punto una volta per tutte: essere genitori gentili
non vuol dire essere permissivi. La critica più comune fra coloro che
si sono appena avvicinati a questo concetto, e che forse praticano
metodi più tradizionali, è che sia troppo permissivo. In realtà, paletti,
limiti e disciplina hanno un ruolo cruciale nell’essere genitori gentili.
Se non disciplinassimo i nostri figli, potremmo realmente rispettarli?
Parte del fraintendimento nasce dalla concezione comune di
disciplina. La parola disciplina viene da «discepolo», definito come
«seguace delle dottrine di un insegnante o di una scuola di
pensiero». Viene dal latino discipulus, allievo, e discere, imparare.
Quindi, la disciplina implica due ruoli attivi, quello dell’adulto
che insegna e quello del bambino che impara, ed entrambi
dovrebbero avere un ruolo di pari importanza nel processo. I bambini
imparano meglio quando ci imitano, seguendo il proprio ritmo
naturale (in termini di sviluppo), in un luogo sicuro e in un ambiente
in cui il loro desiderio naturale di comprendere il mondo non sia solo
rispettato, ma incoraggiato. Ciò nonostante, se si chiedesse a un
gruppo di persone cosa significa per loro l’idea di disciplina, ci sono
buone probabilità di ottenere risposte del tipo: «Con me usavano la
bacchetta», «I miei me le davano quando non ubbidivo», «Bisogna
mettere il bambino in punizione nell’angoletto», «Se fa il cattivo, lo
mettiamo in punizione», «Se rispondevo male, mi mandavano a letto
senza cena» e via dicendo.
Secondo me, questi non sono affatto strumenti efficaci di
disciplina. Funzionano tutti infliggendo dolore fisico o psicologico,
attraverso la vergogna e l’esclusione. Come può un bambino
imparare qualcosa se nessuno gli mostra cosa fare, se non ha
niente e nessuno che gli faccia da modello o se non capisce cosa ha
fatto di male e come si sarebbe dovuto comportare?
La disciplina vera e propria si trova raramente nella nostra
società. La maggior parte dei bambini oggi giorno viene punita.
Vengono puniti perché sono bambini, perché non si comportano
come adulti, perché sono troppo curiosi e desiderosi di imparare e
perché il loro sistema di autocontrollo non è ancora ben sviluppato.
Un bambino che si comporta male sta di solito chiedendo
aiuto, sta cercando di dirci che nel suo universo non sta
andando tutto per il meglio. Ma la maggior parte dei metodi
utilizzati al giorno d’oggi per controllare il comportamento dei
bambini li penalizza per il fatto di avere un problema, piuttosto che
cercare di aiutarli a risolverlo.
La definizione di punizione è «un atto che causa, o è
caratterizzato da, un trattamento duro o nocivo, severo, brutale».
Quando un bambino viene punito, non si verifica alcun
apprendimento: il ruolo del bambino è passivo e l’obiettivo dell’adulto
è quello di esercitare controllo e conformare il bambino alle regole. È
possibile che le loro manifestazioni vocali o fisiche spariscano, ma i
problemi veri e propri dei bambini rimangono, pronti a sorgere
nuovamente l’indomani, come una ferita infetta coperta da una
fasciatura pulita. Perché non dovremmo aiutare i bambini a risolvere
i
loro problemi? Di sicuro, se lo facessimo, saremmo insegnanti
migliori.
Genitori autoritari, autorevoli e permissivi
Nel 1966, la psicologa Diana Baumrind identificò tre distinti stili
genitoriali: autoritario, autorevole e permissivo.
3
Questi stili possono essere riassunti come segue:
Autoritario
Molto esigente nei confronti del bambino. I genitori si aspettano
comportamenti forse non adeguati all’età del bambino.
Limiti e paletti rigidi, spesso eccessivi.
Limiti e paletti fatti rispettare attraverso l’uso di punizioni.
Al bambino è concessa pochissima autonomia.
Non viene data molta importanza a quanto le punizioni siano
appropriate all’età del bambino.
L’approccio è completamente incentrato sul genitore: l’adulto sa
cosa fare.
I
genitori non si preoccupano del proprio comportamento e
spesso non costituiscono buoni modelli.
Scarso livello di affetto. Scarsi livelli di reattività.
Si rispetta poco il bambino, pur esigendo molto rispetto nei
confronti del genitore.
Autorevole
I
genitori sono esigenti, ma le loro aspettative sono adeguate
all’età del bambino.
I genitori stabiliscono limiti e paletti realistici.
I
limiti e paletti vengono sempre fatti rispettare in modo
rispettoso.
Libertà e autonomia sono in linea con l’età del bambino.
La disciplina è appropriata all’età del bambino.
L’approccio è incentrato sul bambino. Sia il bambino che i
genitori vengono rispettati.
I genitori capiscono gli effetti delle proprie emozioni.
I
genitori dimostrano molto affetto e instaurano una buona
connessione con il bambino.
I genitori sono molto reattivi ai bisogni dei bambini.
Permissivo
I genitori sono poco esigenti nei confronti del bambino e hanno
poche aspettative riguardo al loro comportamento.
Il bambino sarebbe spesso capace di comportarsi meglio, ma
non viene incoraggiato a farlo.
Non vengono stabiliti limiti e paletti, o in modo minimo.
I pochi paletti stabiliti non vengono fatti rispettare.
Al bambino viene spesso data troppa libertà o gli è permesso di
fare quello che vuole.
I comportamenti indesiderati non vengono scoraggiati e spesso
vengono giustificati.
Il bambino ha il controllo totale e i genitori hanno poco controllo.
I genitori hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni.
I genitori sono molto affettuosi.
I genitori sono molto reattivi ai bisogni dei bambini, ma corrono il
rischio di non interpretarli correttamente.
Dunque, qual è lo stile ideale di genitorialità? Quello in cui i
genitori camminano su un filo ben equilibrato, rispondendo ai bisogni
del bambino e facendogli richieste adeguate alla sua età, tenendo
sempre conto dello stadio del suo sviluppo. Qual è la definizione che
riassume questa tendenza? Genitorialità autorevole, o, come mi
piace chiamarla, genitorialità gentile.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :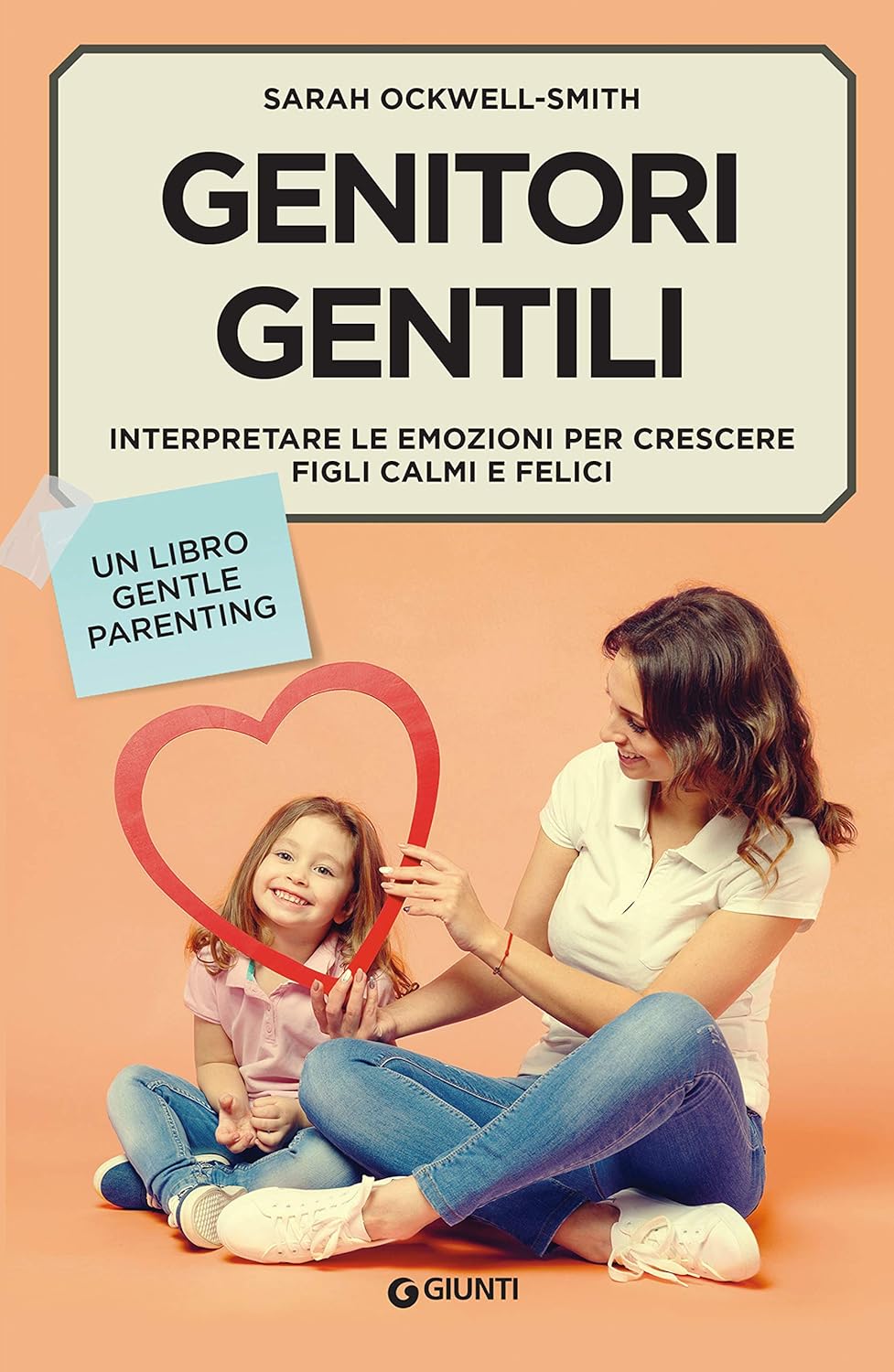






Commento all'articolo