Fiume – L’avventura che cambiò l’Italia – Pier Luigi Vercesi
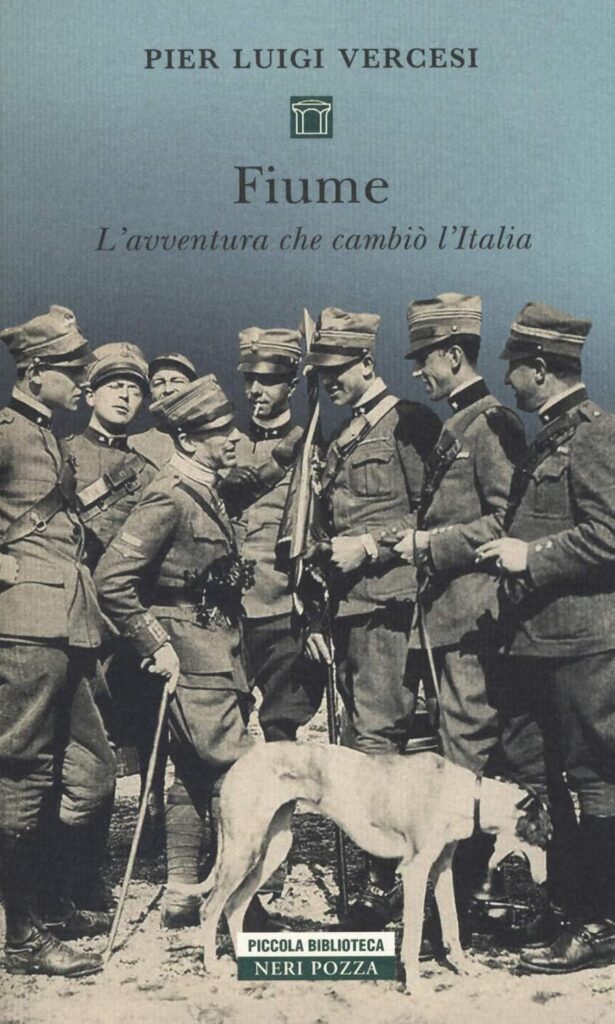
SINTESI DEL LIBRO:
L’11 settembre del 1919 è un giovedì. Da un pontile sul canal
Grande a Venezia, alle tredici e trenta un uomo esile con il cranio
rasato, il volto pallido e incavato, sale su un motoscafo. Non è solo.
Devono condurlo alla punta San Giuliano a Mestre. Visto
passeggiare per le vie di Torino o di Milano in normali abiti borghesi,
non desterebbe interesse. Quell’uomo però è la figura più
carismatica che l’Italia possieda. Indossa una giubba di gabardine
grigioverde con il bavero bianco dei Lancieri di Novara. A tracolla
porta la bandoliera di cuoio marrone degli alti reparti a cavallo. Sul
petto, dalla parte del cuore, sono appuntati i nastrini delle
decorazioni guadagnate durante la Grande Guerra: una medaglia
d’oro, tre d’argento, due di bronzo, due ordini militari di casa Savoia,
tre croci al merito, il distintivo d’onore di mutilato per aver perso un
occhio in azione. Sui risvolti delle maniche, i gradi di tenente
colonnello sormontati da due spade incrociate sotto una corona
reale, a testimoniare le tre promozioni per merito in combattimento.
Appena sopra il gomito, su entrambe le maniche, uno scettro
ricamato in filo d’oro tra due ali stilizzate e una “O” argentata a fare
da sfondo: è il distintivo di Osservatore dall’aeroplano. Sulla manica
destra, tre barrette ricamate in oro, quante sono le ferite riportate
durante il conflitto. I pantaloni sono da cavallerizzo, stesso tessuto
della divisa; gli stivali in pelle. In testa porta il chepì con i gradi e il
fregio dei Lancieri ma, al posto del numero del reggimento,
s’intravvede un’elica bipala e un motore in argento da aviatore.
Ha cinquantasei anni, Gabriele d’Annunzio. Il poeta, drammaturgo
e romanziere abruzzese sempre sopra le righe mentre recita la sua
vita, si era trasfigurato da Vate profano in Vate sacro durante le
“radiose giornate” del maggio 1915: sulla rocca di Quarto,
nell’anniversario della partenza dei Mille per il Volturno, aveva
invocato la discesa in campo dell’Italia attribuendole il valore di
quarta guerra “santa” d’indipendenza. Soldato dove gli parve e
piacque durante il conflitto, era asceso all’olimpo degli eroi con la
beffa di Buccari e il volo propagandistico sopra Vienna. Due azioni di
grande impatto psicologico sulle masse per le quali occorreva, oltre
al fegato, immaginazione. La gioventù aristocratica e alto-borghese
delusa dall’Italietta giolittiana, leggendolo e ammirandolo, vedeva in
lui l’incarnazione italiana del superuomo vagheggiato da Friedrich
Nietzsche. Al fronte, nello zaino, portavano Le vergini delle rocce e
declamavano strofe delle Laudi.
Salendo su quel motoscafo, in un soleggiato giorno di tarda
estate, d’Annunzio stava mutando il corso della storia d’Italia e
probabilmente d’Europa; orchestrava la più reale rappresentazione
dello spirito del tempo, raccogliendo in un teatro naturale tutte le
forze, le ideologie, le passioni, le aspirazioni, le follie e le
contraddizioni che aleggiavano nell’aria. Nulla escluso: dal fascismo
al bolscevismo, dall’anarchia al cameratismo, dallo spiritismo all’arte,
alla poesia, alla vita inimitabile. Al nichilismo. Scioglieva le briglie
all’istinto di ribellione contro l’ipocrisia di un mondo dominato dagli
interessi economici: l’uomo divenuto ingranaggio, l’imperialismo
rapace, l’oppressione dei popoli. Anticipava Charlie Chaplin e Che
Guevara, la guerra di Spagna e il Sessantotto, il movimento dei
Paesi non allineati e il rifiuto di un ordine mondiale pensato a
Washington. Tutto ebbe origine, infatti, da un’imposizione del
presidente degli Stati Uniti, Thomas Woodrow Wilson, dalle astuzie
diplomatiche delle due principali potenze coloniali, Francia e Gran
Bretagna, e dall’inadeguatezza dei governi italiani.
La prima guerra mondiale era finita da quasi un anno e la
conferenza per la pace convenuta a Versailles, alle porte di Parigi,
aveva relegato l’Italia al ruolo di paria tra le nazioni vincitrici. Così,
almeno, si percepiva nel Paese più povero e arretrato fra i quattro
grandi alleati che avevano, insieme, piegato gli imperi centrali,
lasciando milioni di morti nei cimiteri, decine di migliaia di mutilati per
le strade, infinite schiere di disoccupati nelle campagne e nelle città.
Tutti, a suo tempo, illusi di combattere per un destino migliore.
Gabriele d’Annunzio riassunse quell’angoscioso malessere con due
parole lapidarie: «Vittoria mutilata».
Prima ancora di celebrare ufficialmente l’apertura dei negoziati
diplomatici, l’attenzione si concentrò su un porto fino ad allora
sconosciuto alle masse, collocato a sud-est di Trieste, nella striscia
di terra affacciata sull’Adriatico che porta nomi attribuiti, nei secoli,
dalla Serenissima Repubblica di Venezia. Prima del conflitto
mondiale, Fiume era il terminale marittimo del Regno d’Ungheria,
collegato a Budapest con una rete ferroviaria necessaria per gli
approvvigionamenti della seconda capitale asburgica. Nell’equilibrio
dell’impero multietnico ora in fase di smembramento, aveva la
stessa importanza di Trieste per Vienna.
La parte storica della città era a maggioranza italiana; Sussak, il
sobborgo proletario oltre l’Eneo, il corso d’acqua che sfocia
nell’Adriatico, era prevalentemente abitato da croati. A guerra finita, i
dignitari della città chiesero a maggioranza di essere annessi
all’Italia e il 17 novembre 1918 un contingente di granatieri di
Sardegna la occupò, respingendo le truppe croate e serbe. Anche
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti inviarono loro militari. Il
presidente francese Georges Clemenceau e l’americano Wilson si
mostrarono subito ostili all’annessione italiana. Il premier britannico
David Lloyd George, sornione, osservava con distacco, ma
segretamente covava mire sulla città che spalancava le porte ai
mercati della Mitteleuropa.
Occorre precisare che nel patto segreto di Londra, firmato
nell’aprile del 1915, di Fiume italiana non c’era traccia (in base a
quel trattato, l’Italia entrava in guerra al fianco di Francia, Inghilterra
e Russia in cambio di acquisizioni territoriali ai danni dell’Austria
Ungheria). Non se n’erano dimenticati, come qualcuno sostenne, era
un pegno pagato allo zar, protettore delle popolazioni slave dell’area
balcanica. Ma nei “quattordici punti”, i princìpi imposti dagli Stati Uniti
come base delle trattative, un concetto cardine, insieme alla
creazione di una Società delle nazioni incaricata di prevenire nuovi
conflitti, era l’autodeterminazione dei popoli. Se l’Italia non poteva
rivendicare l’annessione di Fiume, Fiume poteva decidere
liberamente con chi stare. E aveva scelto l’Italia. Ma gli interessi
commerciali in gioco e la supremazia nel Mediterraneo avevano
trasformato quel porto in un pegno a cui nessuno intendeva
rinunciare. Tantomeno l’Italia: se le potenze coloniali avessero
convogliato i loro traffici su Fiume, sulle banchine e sul molo di
Trieste sarebbe cresciuta l’erba.
Nella primavera del 1919 la tensione nella città contesa era
altissima. I soldati italiani di stanza a Sussak erano osteggiati. Il
contingente francese, composto in prevalenza da indocinesi, non
perdeva occasione per mortificare i sentimenti italiani. Ciò che stava
accadendo a Parigi deprimeva la popolazione e, di giorno in giorno,
sfumava la fiducia nel governo di Roma. Gli ufficiali più giovani e di
basso rango, i più irrequieti, passavano le giornate imprecando
contro l’armistizio e chi l’aveva firmato. Spesso nemmeno
comprendendo ciò di cui discutevano. L’unica certezza «è che tutti
abbiamo una gran voglia di menare le mani», racconta nelle sue
memorie Riccardo Frassetto, tenentino giunto a Fiume in aprile. Di lì
a qualche settimana, inaspettatamente, Frassetto si troverà al centro
di questa complicata vicenda di cui tutti parlano, tutti pianificano
soluzioni, ma nessuno sa come e da che parte iniziare. Il tenente
dovrà raggiungere Venezia e convincere Gabriele d’Annunzio a
compiere l’impresa rimasta, finora, in grembo agli dèi.
Cosa hanno fatto al povero vecchio signore?
Frances Stevenson si stava preparando al picnic promessole dal
suo amante, il primo ministro britannico David Lloyd George (ne
diverrà la seconda moglie molti anni dopo). Era giunta con lui nella
capitale francese come assistente personale, ma tutti sapevano
della loro relazione. Negli ambienti della politica britannica, David era
noto come The Goat, “il capricorno”, per la sua impenitente attività di
donnaiolo.
Il 20 aprile 1919 era la domenica di Pasqua, una bella giornata di
primavera. Frances si affacciò alla finestra dell’appartamento in rue
Nitot a Parigi per verificare se nella casa di fronte, occupata da
Wilson, fosse ancora in corso la riunione del “consiglio dei quattro”
convocata d’urgenza. Temeva potesse sfumare l’occasione per il
picnic. A un tratto vide il presidente del Consiglio italiano, Vittorio
Emanuele Orlando, affacciarsi alla finestra, appoggiarsi alla sbarra
che l’attraversava e prendersi la testa tra le mani. Nelle sue memorie
annotò: «Ebbi l’impressione che stesse piangendo, ma non lo ritenni
possibile finché non lo vidi estrarre un fazzoletto, con il quale si
asciugò gli occhi e le guance». Alle sue spalle, il cameriere
personale di Lloyd George sussurrò: «Cosa hanno fatto al povero
vecchio signore?»
Sir Maurice Hankey, segretario del Gabinetto di guerra britannico,
tre giorni dopo ricostruì la stessa scena in una lettera alla moglie,
descritta però dall’interno della stanza: «Se mio figlio si fosse
lasciato andare a una simile, vergognosa manifestazione di emotività
l’avrei sculacciato» concluse. In quella sala, Clemenceau assisteva
imperturbabile alla disperazione di Orlando, come se lo sfogo del
premier italiano non lo riguardasse; Wilson, col suo fare profetico, fu
l’unico a consolarlo con una pacca sulla spalla, nonostante fosse lui
la principale causa di tanta disperazione.
Orlando sarà generoso nei giudizi su Clemenceau, la Tigre della
Vandea, terra irriducibile. Con le sue maniere feline sembrava
volesse mordere l’avversario, poi si appoggiava allo schienale della
poltrona e restava, occhi socchiusi, a osservarlo, sperando di averlo,
se non tramortito, almeno confuso. Ricordando Lloyd George,
Orlando sarà addirittura affettuoso: era un uomo segnato, nella sua
azione politica, dal ricordo d’infanzia del giorno in cui vennero
venduti all’asta i «poveri mobili della sua povera casa». In campagna
elettorale ripeteva: «Un duca è inutile e costa più di una corazzata»
o,
alternativamente: «L’aristocrazia è come il formaggio, più
invecchia e più costa».
Il giudizio espresso su Wilson, invece, è spietato: era animato da
«ipocrisia spontanea»; «non agì mai per il bene, ma ebbe sempre
presente un secondo fine»; era armato «di quegli astuti artifici che
son propri dei politicanti di villaggio»; «un politicante in tutto il senso
più consumato della parola, rivestito di una brillante forma esteriore
di filosofo e di missionario»; «univa un orgoglio smisurato a
un’ostinazione che nulla consentiva alle ragioni di un eventuale
contraddittore». Gli dedica solo due pagine, ben intrise di veleno.
Le lacrime di Orlando erano motivate, seppure poco dignitose per
un capo di governo. Alla fine di quella riunione, il suo destino era
segnato. E nel momento meno opportuno: di lì a poche settimane i
delegati tedeschi e quelli austriaci sarebbero giunti a Parigi.
Le rivendicazioni italiane spaziavano dall’Africa al Medio Oriente
all’Europa, ma le trattative si arenarono su Fiume. Il ministro per gli
approvvigionamenti italiano, l’industriale lombardo Silvio Crespi,
uomo pratico, con malizia spiegò che a Parigi, «nell’ombra o nelle
coulisses delle grandi sale, eminenze grigie, collaboratori e,
soprattutto, collaboratrici delle personalità accreditate, operavano
per creare stati d’animo, intese sotterranee, favori incrociati». Tra le
più ammirate, la moglie del ministro jugoslavo Milenko Vesnić:
americana d’origine, era tra le più «vivaci signore a loro agio nel
mondo dei diplomatici»; oltre a essere attraente, era molto ricca e
intima della seconda moglie di Wilson. I nostri maturi Orlando e
Sidney Sonnino, notò Crespi, erano tra i meno attrezzati in questo
senso; non avevano la sensibilità di un Cavour nel comprendere
quanto le grazie femminili potessero avvicinare e rendere compatibili
posizioni diplomatiche tra loro apparentemente inconciliabili.
Tra il presidente Wilson e il ministro degli Esteri italiano l’antipatia
e l’incapacità di comprendersi erano totali. Wilson aborriva il patto di
Londra, di cui Sonnino era il firmatario italiano: riteneva quei metodi
diplomatici la principale causa delle guerre e individuava nel
settantenne ministro degli Esteri, folti capelli bianchi e baffoni
spioventi, tutto quanto lo inorridiva della Vecchia Europa.
Sonnino era nato in Egitto da un uomo d’affari ebreo di nazionalità
italiana e da madre gallese, era protestante in un Paese di cattolici e
brillante polemista con una passione sconfinata per la Beatrice di
Dante. Entrato in politica per caso, era diventato una delle
personalità di governo più rispettate. A detta di alcuni suoi intimi,
«soffriva di complessi di superiorità». E ciò non giovava nelle
delicate trattative diplomatiche, soprattutto di fronte a potenze
coloniali che di tali complessi ne avevano da vendere. La sua
concezione bismarckiana che le nazioni dovessero essere sempre
motivate da «sacro egoismo» questa volta giocava contro di lui. Non
aveva colto il mutare dei tempi e sembrava seduto al congresso di
Vienna di cent’anni prima piuttosto che a quello di Versailles, dove le
carte erano distribuite da un croupier venuto d’oltreoceano. Quando
nel 1918 Wilson proclamò i suoi “quattordici punti”, Sonnino
commentò: «Una subdola campagna di propaganda straniera tenta
di insinuare che le aspirazioni italiane si rifanno a concezioni
imperialistiche, antidemocratiche e antinazionalistiche. Sono tutte
falsità».
A guerra finita, le battute contro l’Italia raggiunsero livelli
intollerabili. La formula «vittoria mutilata», a dar ascolto a tali battute,
sembrava la definizione di un’educanda. Per Clemenceau, la
partecipazione italiana alla guerra si era risolta, più o meno, così: «Si
fecero incontro con una magnifica scappellata in puro stile XVII
secolo e, dopo essersi inchinati, tesero il cappello in cerca di
elemosine».
L’ambasciatore
britannico
a
Parigi
ammise:
«L’atteggiamento nei confronti dell’Italia è stato finora di massimo
disprezzo e adesso è di estrema irritazione. Tutti dicono che
l’armistizio è stato preso dall’Italia come il segnale per cominciare a
combattere».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :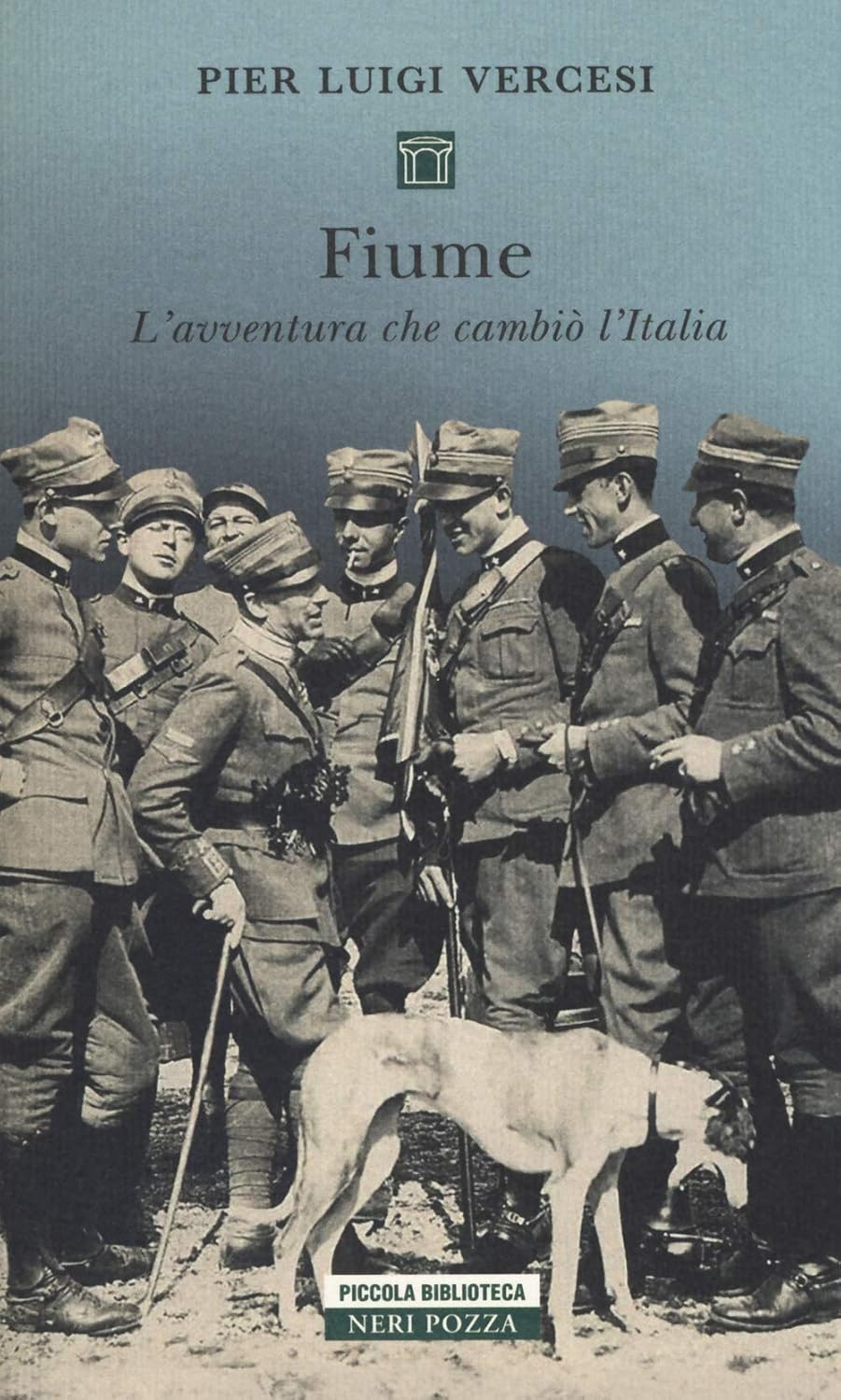






Commento all'articolo