Dentro e fuori la stanza – Costanza Jesurum
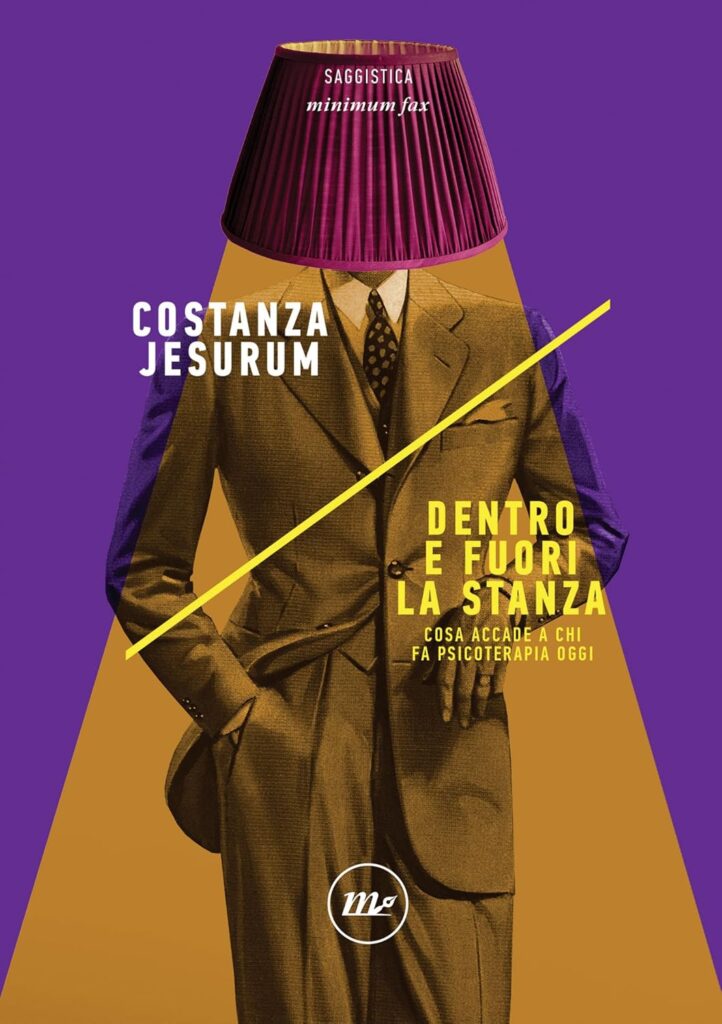
SINTESI DEL LIBRO:
Rispetto a cinquant’anni fa la percezione del malessere psicologico
e delle psicoterapie è largamente mutata, in una maniera pervasiva
e capillare. Cinquant’anni fa in Italia non esisteva un albo
professionale degli psicologi, con relativo codice deontologico, né
esisteva una facoltà di psicologia, né era normativizzato in maniera
particolarmente seria e attendibile l’accesso alle scuole di
specializzazione e l’itinerario didattico che queste dovessero
prevedere. Adriano Ossicini infatti, dopo una lunga e penosa
battaglia non solo parlamentare ma anche culturale, riuscì a ottenere
nel 1989 l’istituzione dell’Albo. Parallelamente, si può dire negli
stessi decenni, Ernesto Valentini aveva lottato per l’istituzione prima
di un corso autonomo di studi psicologici, e poi per la creazione di
una vera e propria facoltà di psicologia distaccata dalle altre – un
progetto politico e accademico che avrebbe ottenuto il suo scopo nel
1991.
Nel mondo che Ossicini e Valentini cambiarono, e di cui ancora
avvertiamo qualche strascico, la psicoterapia era da una parte un
affare da ricchi, un problema che affliggeva signore borghesi troppo
lamentose e sfaccendati aristocratici in disarmo, dall’altra un
giocattolo per intellettuali annoiati e con scarso senso pratico.
In alternativa a tutto questo c’erano i trattamenti, ma non ancora
psicoterapici, soprattutto farmacologici per tutti i titolari di
psicopatologie gravi, che la Legge 180 aveva liberato dai manicomi
ma la cui parziale realizzazione aveva qualche volta lasciato in
mezzo alla strada. Nel mondo di allora cioè, un rigido classismo,
condiviso dall’alto e dal basso, non riconosceva ai ceti meno
abbienti, al mondo operaio o contadino, sufficiente complessità
mentale per toccare gli alati vertici della tristezza, della malinconia,
della depressione, e le uniche visibilità concepite erano concesse
agli uccelli del paradiso altoborghese, o in alternativa ai paria di tutte
le comunità – quelli che un tempo venivano segregati nei manicomi
e che dopo, con alterne vicende, sarebbero stati seguiti dai servizi
territoriali. Di conseguenza, il mondo delle psicopatologie si divideva
in due grandi gruppi: da una parte le avvilenti quanto incomprese
depressioni e dall’altra le romantiche schizofrenie, che ancora oggi
seducono scrittori. In questa mappatura così rigida del
funzionamento psicologico allora, la psicoterapia aveva un margine
modesto per svilupparsi ed emanciparsi, un campo applicativo
troppo ristretto, per tipo di utenti e per oggetti di cura; buoni modelli
teorici facevano fatica a inglobare le diverse realtà della vita delle
persone, che pure avrebbero avuto bisogno in più di un caso di
sostegno. All’epoca c’era già in effetti una vasta zona grigia
intermedia, tra le psicosi e le depressioni gravi, ed era costituita dal
vasto oceano degli esaurimenti nervosi. Prima della Legge Ossicini,
ogni volta che qualcuno stava male e magari mandava a rotoli la
propria vita si diceva: «Ha un brutto esaurimento nervoso!» E se in
famiglia c’erano soldi a sufficienza si mandava il giovanotto o la
giovanotta col brutto esaurimento nervoso a cambiar aria in un’altra
città, a fare esperienza altrove, oppure se si era più grandicelli si
sfasciava un matrimonio. Se invece niente di tutto ciò era possibile,
si virava verso gli psicofarmaci – all’epoca meno efficaci di oggi, e
spesso con effetti collaterali decisamente più invalidanti. Il vasto
oceano degli esaurimenti nervosi comunque riguardava la media e
certo anche l’alta borghesia. Al di sotto della media borghesia non
c’era però tempo manco per quelli, e la scorciatoia dell’alcolismo
arrivava più immediata, e ancora più immediata purtroppo, da un
certo momento in poi, la via regia della tossicodipendenza.
D’altra parte la nebulosa galassia degli addetti ai lavori, senza un
centro ideale di riferimento – un albo, un’università, insomma un
canone – si mostrava più che mai confusa, quanto mai esoterica,
con picchi di seducente sciamanesimo a cui si mischiavano solidi
elementi di dilettantismo. Tutti potevano diventare psicoterapeuti
senza alcun obbligo di formazione precisa, bastava qualche lezione
in una qualche associazione ed eventualmente una psicoterapia su
di sé. Sulla bocca degli intellettuali trionfava il prestigio delle grandi
associazioni analitiche, la junghiana e la freudiana, ma tutto intorno
cominciavano a fiorire altri piccoli gruppi e piccole associazioni. La
specializzazione in psichiatria formava poi altri addetti ai lavori che
però si sarebbero accollati soprattutto il lavoro sporco delle patologie
più gravi – e con metodologie non sempre limpide. Allora, come
ancora oggi, la formazione psichiatrica nell’università italiana
vantava solide basi per tutto quello che c’era e c’è di biologico da
sapere, rimanendo invece piuttosto generica e superficiale su tutto
quello che riguardava e riguarda la conoscenza psicodinamica del
comportamento, e quindi forniva e fornisce professionisti non
sempre garantiti sulla qualità della preparazione psicologica.
Era dunque anche normale che con un panorama così confuso
e poco affidabile, dove non era possibile capire cosa era abuso e
cosa no, dove si sentiva a tratti vociferare di approcci teorici l’uno in
competizione con l’altro, la possibile utenza si sentisse respinta,
poco attratta, spaventata, che alle normali resistenze che si possono
avere all’idea di parlare con qualcuno della propria vita privata, si
unisse una terrorizzata diffidenza verso un mondo di prassi che non
offriva davvero nessuna forma di garanzia. Con questi sentimenti di
diffidenza così diffusi, le retoriche di classe – l’analisi è una cosa da
ricchi! – e le retoriche di conformismo – la psicoterapia è per fuori di
testa! – fiorivano con maggior agio.
L’introduzione di un albo e di una facoltà di psicologia avviarono
allora un processo che si può dire ancora in atto. In Italia poté
cominciare a edificarsi, a partire dall’esistenza di un’università
dedicata, la psicologia come disciplina autonoma
1 che, per quanto
diversificandosi in svariati approcci, cominciò ad as somigliare più a
un albero che a una costellazione, più a un arcipelago di cui si
possono scorgere le relazioni sommerse tra isole, che a un
assembramento di pensieri diversi.
La presenza stessa delle facoltà negli atenei italiani, per quanto
battute dalle mareggiate delle mode teoriche, ha favorito lo sviluppo
di una ricerca rivolta ai presupposti che accomunano le diverse
prassi cliniche. Come vedremo meglio nei prossimi capitoli,
l’università rispetto alle diverse scuole teoriche ha costituito una
sorta di tribunale laico con lo scopo di valutare e validare le singole
teorie, e confrontasse i singoli approcci, restituendoli a tutti gli
studenti e futuri psicologi e gettando così le basi per un’identità
professionale nuova, quella dello psicologo. Io credo che ad oggi
questo processo non sia ancora esplicito e compiuto, ma che ci
siano una serie di premesse di cui psicologi e psicoterapeuti non
sono sempre perfettamente consapevoli che poi diventano operative
quando, pur provenendo da formazioni disparate, si trovano a
lavorare insieme in progetti di équipe o a confrontarsi tra loro in
scambi professionali. Oggi gli psicologi, e soprattutto gli psicologi
clinici,
2 condividono un unico vocabolario – ossia le diagnosi che
usano – un unico codice deontologico, e alcune regole ricorrenti del
loro lavoro. Le psicoterapie stanno diventando i membri di una
famiglia molto litigiosa, dove non sono morte ancora le antiche
rivalità ma in cui tutto sommato specie i nuovi arrivati sentono
fortemente l’appartenenza a un gruppo distinto riconoscibile e
circoscrivibile che ha una grande base condivisa e un idioma
proprio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :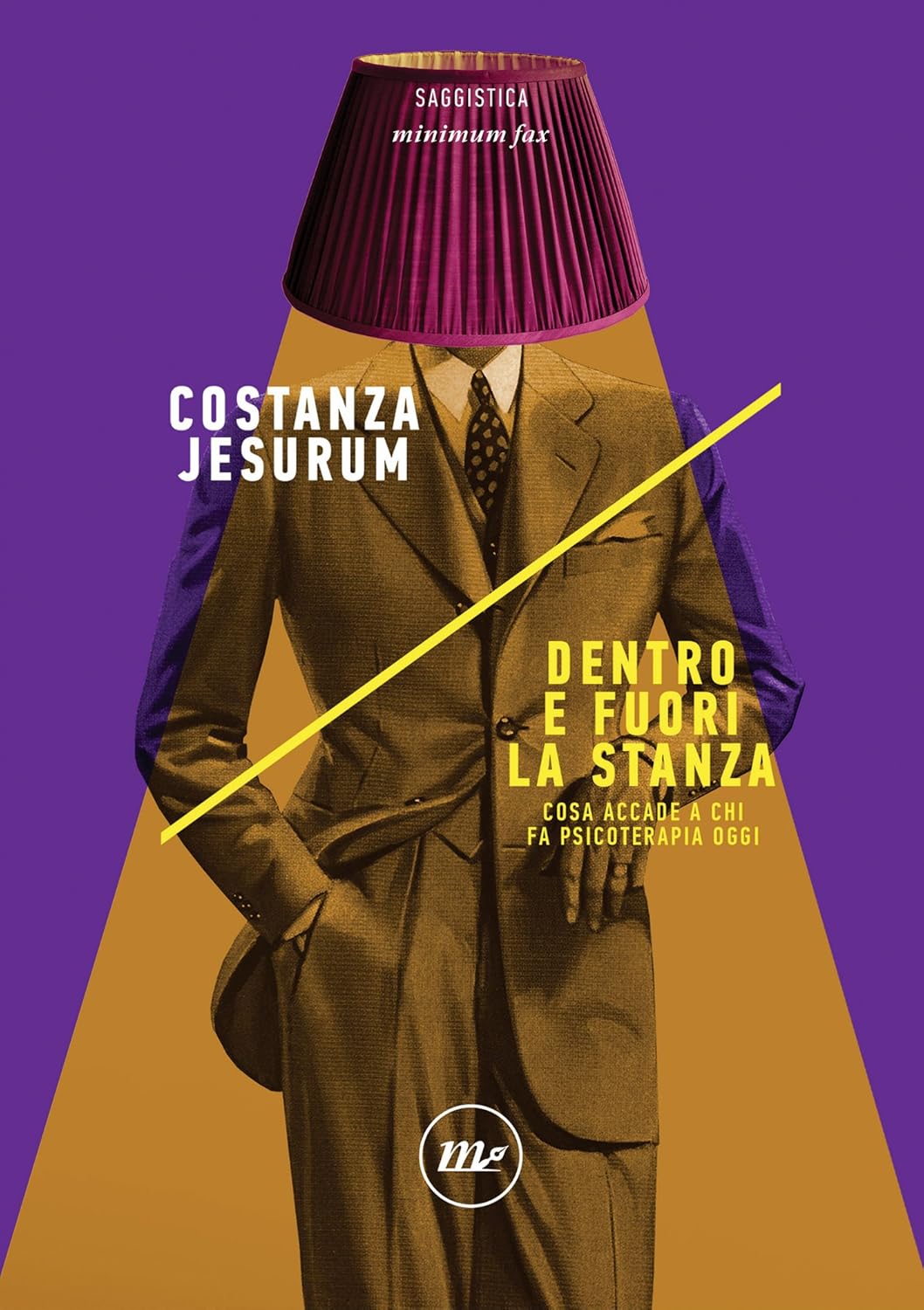






Commento all'articolo