Concupiscenza libraria – Giorgio Manganelli
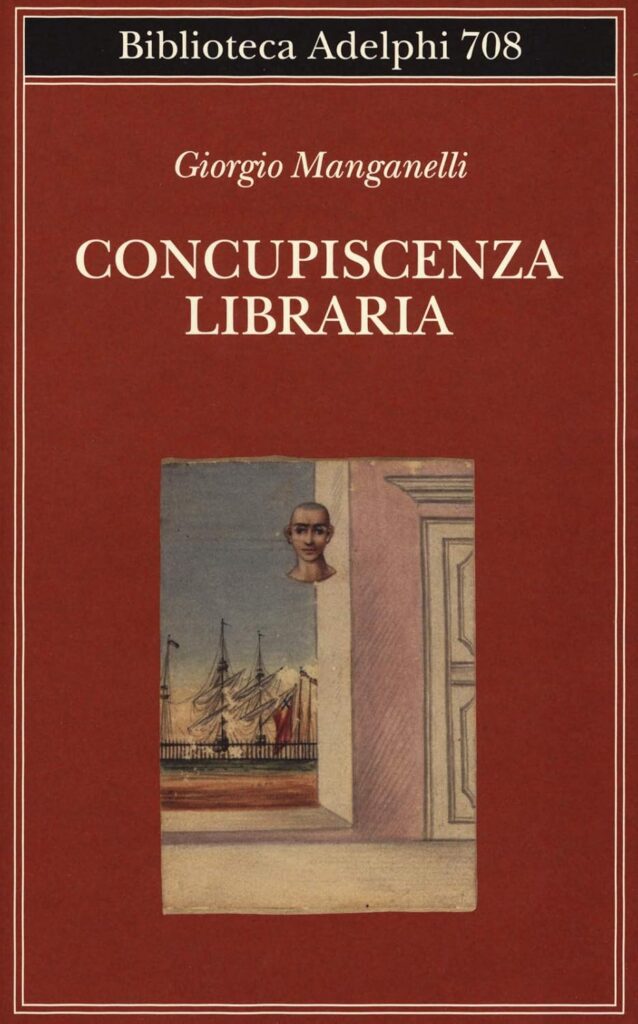
SINTESI DEL LIBRO:
A sentirsi chiamare critico, G.S. Fraser probabilmente si
turberebbe: una rattenuta, rispettosa agitazione, quale si
conviene alla sua prosa limpida e onesta, raggelata da una
delicata timidezza. Fraser vuol essere solo un «recensore»,
uno stimatore di testi poetici recenti: ed ora ha raccolto,
appunto, codeste stime ed assaggi in Vision and Rhetoric
(Faber & Faber, 1959).
«L’onnivoro appetito del recensore ha in certa misura
ottuso la mia sensibilità: le mani del prete si cauterizzano,
a contatto con i sacri oggetti». Fraser ama difendersi dietro
questi gesti di pudore, mitemente sfiduciati; certamente, il
recensore abbisogna di qualità non puramente critiche: è
ragionevole sospettare che esista una moralità del
recensire, che non coincide che parzialmente con la
moralità del criticare. Al recensore non chiederemo sintesi
temerarie e illuminanti, intuizioni intemporali, ma lo
assolveremo anche dalla solennità delle scelte irrevocabili;
lo vorremo candido, audace per naturale innocenza; capace
di dire cose di cui dovrà pentirsi, generoso ma attento,
pronto ad arrischiare la stoltezza, la bêtise: e appunto
quest’ultima, perigliosa qualità gli consentirà talora di
attingere una non effimera grandezza.
Tra i recensori di poesia in Inghilterra, A. Alvarez ha più
sistema di Fraser; Donald Davie è più caustico, asprigno e
socievole; Roy Fuller ha la zampata più ferma, più
autorevole, e più grossa: ma nessuno ha il candore,
l’intelligente cautela, la pazienza, e anche la rispettosa
cocciutaggine, di Fraser: giacché ha anche il coraggio di
dire cose che egli stesso sospetta inadeguate, ma di dirle in
tono così fermo e sommesso, da toglier loro il prestigio
della provocazione. «È indubbio che non soltanto ho scritto
troppo sulla poesia, ma che forse ho letto con troppa
attenzione e troppo rispetto poesie affatto insignificanti»:
ma appunto il rispetto ingenuo e puntiglioso è la qualità più
amabile di questo educato, civilissimo «giornalista
letterario». G.S. Fraser sottolinea, non senza una lieve
insolenza, di non avere una teoria letteraria: «Non ho mai
avuto tempo per sviluppare una teoria letteraria, e dubito
di avere le qualità necessarie a tanto compito». Ma non è
tutta colpa del tempo dedicato alle mediocri poesie: Fraser
ha della poesia una idea non sistematica, non intellettuale,
né discorsiva. «Descriverei il mio modo di accostarmi ad
un’opera letteraria come una sorta di groping tact, un
tentare col tatto ... posto davanti ad un nuovo libro, tendo
le mani, cerco di capirne qualcosa coi polpastrelli».
Il rapporto con la poesia è irrazionale, esistenziale; in uno
dei suoi rari momenti di solennità, di furor critico, Fraser
scrive: «Per trascegliere ed ordinare le impressioni che vi
ha dato una poesia, occorre in primo luogo avere a propria
disposizione una massa coerente di impressioni, tra cui
operare la scelta: direi che è necessario esser vissuto
intimamente con quella poesia per gran tempo: forse per
anni». Queste parole Fraser dedica, discorrendo di Yeats, a
certi new critics americani; ed è significativo che Fraser li
accusi in primo luogo di aver ricavato, dalla «impostazione
analitica» di Richards, Empson e Leavis, un «metodo
analitico». «L’analisi è metodo utilissimo per controllare,
corroborare, i giudizi sommari enunciati dal comune tatto o
sensibilità letteraria; ma non è, né sostituisce, tatto e
sensibilità; non è, né può essere, uno strumento primario di
ricognizione critica». E con inconsueta durezza: «in primo
luogo, una poesia vuol esser capita e goduta; non
discussa».
L’approach meno inadeguato alla poesia dovrà essere
vitale, sensitivo: e dunque il gesto critico dovrà essere una
semplice «posizione» di valori: il critico giudica con gesto
necessario e libero. Codesta idea della critica, cui pare
tendere, con perplessità, Fraser, si allea ad una idea della
poesia, non rettilinea, né tutta lavorata: una ipotesi di
lavoro. In polemica, devota e tenace, con Yvor Winters,
Fraser nota: «Per costoro (Winters, Wimsatt, Beardsley) la
nostra reazione emotiva ad una poesia dovrebbe venir
determinata dalla reazione della poesia stessa ad una
situazione che sta al di fuori della poesia, e che noi
possiamo individuare con notevole chiarezza e concretezza.
Per Yvor Winters, il giudizio conclusivo è un giudizio
morale, e su questo punto Matthew Arnold gli avrebbe dato
ragione ... Ora, in tutto questo libro io ho sempre
presupposto che la poesia sia a language by itself, un
linguaggio autonomo: ma se Winters e Arnold hanno
ragione, non è così». Secondo costoro, la poesia servirebbe
solo a esprimere i sentimenti «con maggior potenza» e
«sfumature più sottili»: «Certa prosa potrebbe venir
concentrata in poesia; una buona poesia potrà venir
parafrasata in prosa razionale e persuasiva ... Tutto ciò non
mi persuade. Io resto ostinatamente convinto che la
differenza tra un eloquente passo di Ruskin e una strofa di
In Memoriam sia una differenza di genere». E riprendendo
la definizione di Blackmur, Fraser precisa che non di
«enunciazione poetica» si tratta, ma di «gesto poetico»: e
che non conta «quel che dice una poesia, come risulta da
una possibile parafrasi, ma quel che fa, come insieme di
senso, tono, sentimento, intenzione».
Questa chiara idea della qualità non concettuale della
poesia consente a Fraser, ad esempio, di affermare di
Auden: «È uomo assai maggiore delle sue idee: una grande
voce poetica; ma come pensatore, al livello di un Middleton
Murry». Quando le idee entrano in una poesia, non contano
più per la loro autonoma dignità razionale: ma per la parte
che eventualmente loro compete nella strutturazione del
testo poetico.
Resta da vedere quale materiale critico, quali giudizi
reggano queste idee generali sulla poesia. Come è naturale
ad un recensore, animale dai gesti prensili e scattosi, i
giudizi di Fraser sono fortemente umorosi, talora in parte
privati: giacché Fraser è anche poeta, e voglioso di
imparare. Come s’è detto, Auden gli è palesemente
antipatico; ma Fraser è troppo dabbene per non dolersi di
codesto fastidio, e cerca di farselo scusare, giacché non
può svestirsene, con la mitezza del discorso. Non rinuncia
talora al gioco critico, che direi futile, di ricercare quel che
non c’è in un poeta, e poi deplorare che non ci sia: come si
vede con chiarezza da esempio didattico in quel che scrive
su Wallace Stevens, e che ha recentemente ribadito in un
articolo apparso nel «New Statesman». Non serve a molto
notare che Wallace Stevens è «freddo» e «privo di grandi
interessi umani»: è ovvio che chi abbisogna di forti
interessi umani, non li cerca in Stevens. È anche vero che
Stevens è «frivolo»: ma questo appunto è il problema
critico della sua poesia, giacché la sua frivolezza è tutt’uno
con la necessità e la autenticità che gli sono proprie. Allo
stesso modo, la fatuità ideologica di Auden è alla radice
della sua splendida vocazione all’orazione poetica.
A proposito di Stevens, Fraser tenta una definizione, se
pure cauta e discreta, del «grande poeta»: «Avvertiamo in
cuor nostro che Stevens non è un grande poeta, nel senso
in cui è grande un Eliot o un Yeats. Si avverte che manca
qualcosa: in parte, forse in primo luogo, quell’intera zona di
vita, che sta tra la distaccata percezione estetica e la
riflessione filosofica: e, corollario principale, l’urgenza della
comune passione umana, la devozione, l’intensità di fondo
... le qualità di Stevens vengono sfruttate con una certa
frivolezza ... manca il senso di una tensione superiore».
Dunque, Fraser cerca una grandezza esistenziale e,
indirettamente, morale: e appunto questa intensa vocazione
alla serietà morale ed estetica gli dà modo di scrivere le
sue pagine più intense, ad esempio su Yeats ed Eliot; e gli
consente di intravedere, a conclusione del libro, una
immagine tragica della poesia: «Quale è il contenuto di
questi versi» dice, toccando del Lycidas di Milton «che mi
muovono quasi alle lacrime? Per me, una gioia strana, in
cui in certo modo si consumano angoscia profonda, e
intensità di dolore, e terrore».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :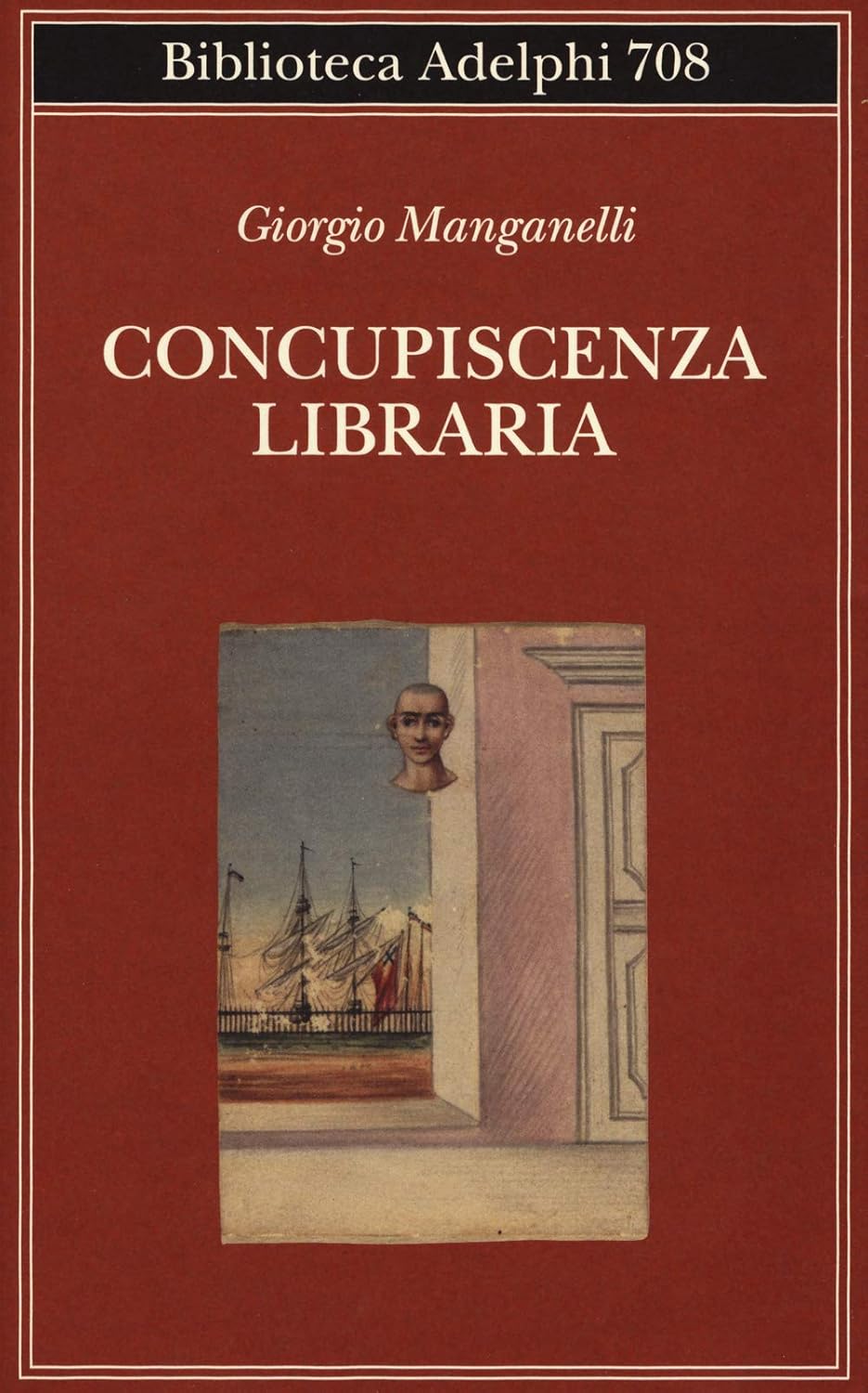






Commento all'articolo