Canto di una biblioteca – Maciej Bielawski
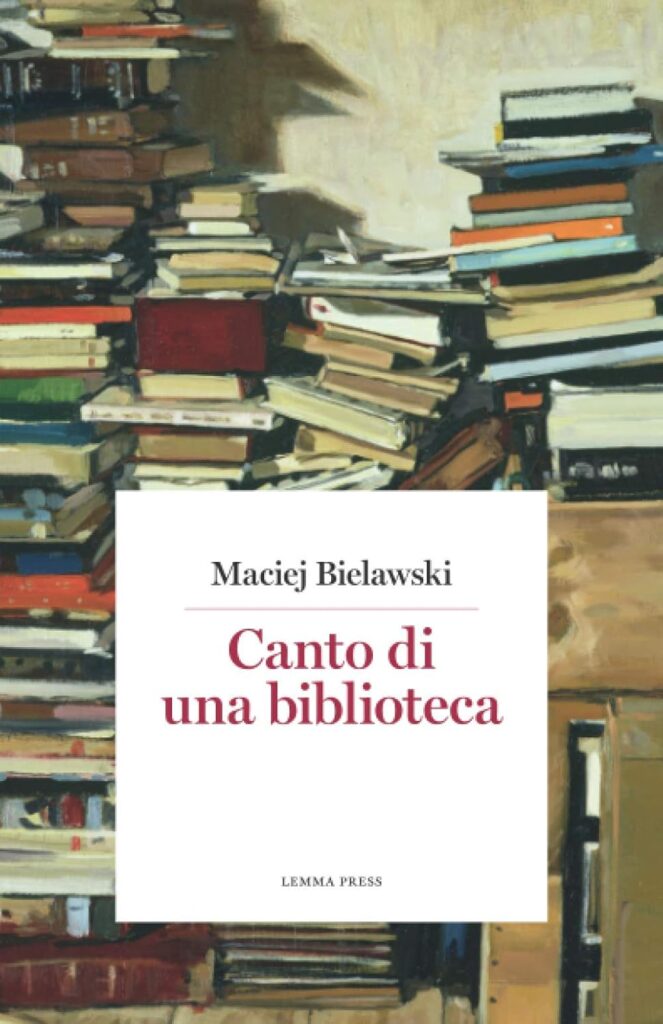
SINTESI DEL LIBRO:
I miei scaffali sono pentagrammi e note i miei libri, ma chi sentirà il
mio canto? Le copertine variopinte dei miei volumi fanno da cortina,
quale mano la alzerà? Le parole impresse sulle pagine stanno
ferme, quale mente le smuoverà? Ogni mia lettera è impregnata
dallo spirito, quale vento lo svelerà? Dentro di me a lungo ho covato
in silenzio suoni e voci che ora è tempo di esprimere, perché la
dimora della saggezza va indicata. Se qualcuno sente la voce del
mio silenzio, entri nel mio spazio come in un tempio in cui abita la
sofia. Io sono di tutti e di nessuno, perciò anche il mio canto è per
nessuno e per tutti. Venite, ascoltatemi.
Le mie melodie provengono da tempi lontani, ma la composizione è
stata messa per iscritto da poco. Le mie parole spaziano in vasti
universi, ma lo spartito è stilato su pochi metri quadri. Ho
canticchiato frammenti nella quiete del mio nascondiglio, senza
uscire pienamente allo scoperto. Questa è la mia prima esibizione,
perciò la voce mi trema.
Il mio canto è singolare, ma non unico, perché risuona insieme ai
canti di molte, moltissime altre biblioteche che sono esistite, esistono
ed esisteranno, perciò il mio apparente unisono è sinfonico e risiede
nell’armonia universale della biblioteca del mondo. Per
comprendermi occorre immaginare sconfinati scaffali pieni di libri che
scorrono attraverso i millenni, insieme alle incisioni su pietre e tavole
d’argilla, scritture stese su cortecce e foglie di piante, testi dipinti su
tele, stilati su pergamena e oggi trasformati in bit per apparire sugli
schermi dei lettori digitali. A essi vanno aggiunti tutti i testi mai scritti,
ma tramandati da bocca a bocca, e tutti quei libri solamente pensati,
sognati e vissuti, che compongono il libro della vita, a cui persino
Iddio aggiunge le sue tre righe. Io ne faccio parte e il mio canto
risuona con loro.
Guardo il mondo terribile e bello, consumato dalle fiamme della
storia che sempre si rinnova risuscitando dalle ceneri e spiccando il
volo. Apro per caso – ma che non è un caso – la prefazione a I Veda
del mio amico e padrone e chiedo a chi mi ascolta: «Che cosa
salvereste da una casa in fiamme? Un prezioso, insostituibile
manoscritto, contenente un messaggio di salvezza per il genere
umano o un piccolo gruppo di persone minacciate da quel fuoco? Il
dilemma è reale e non solo per chi scrive: come si può essere solo
un ‘intellettuale’, interessato alla verità, o solo uno ‘spirituale’,
impegnato nella bontà, quando gli uomini invocano disperatamente
cibo e giustizia? Come si può seguire un cammino contemplativo,
filosofico o persino religioso quando il mondo richiede azione,
impegno e politica? Viceversa, come ci si può dar da fare per un
mondo migliore o per una indispensabile rivoluzione quando ciò di
cui si ha bisogno è una serena intuizione e una giusta valutazione?
Che la casa in fiamme non sia un fatto che riguarda solo un
individuo dovrebbe essere chiaro a tutti coloro che condividono la
vita su questa nostra terra».
Perché sono stata creata? Perché, salvata, esisto ancora? Come
devo vivere e che posso fare? Il mio lettore diceva: «Se non sono
pronto a salvare il manoscritto dal fuoco, se non prendo cioè sul
serio la mia vocazione intellettuale, anteponendola a ogni altra cosa– anche a rischio di apparire disumano –, allora sono anche
incapace di aiutare le persone in un modo più concreto e immediato.
Viceversa, se non sono attento e pronto a salvare le persone da una
conflagrazione, vale a dire, se non considero la mia chiamata
spirituale con tutta onestà, sacrificandole tutto il resto, persino la mia
propria vita, allora sarò incapace di aiutare a mettere in salvo il
manoscritto. Se mi lascio coinvolgere nei problemi concreti del mio
tempo e se non apro la mia casa a tutti i venti del mondo, allora
qualsiasi cosa io possa produrre da una torre d’avorio sarà sterile e
maledetta. Eppure, se non chiudo porte e finestre così da
concentrarmi su questo lavoro, non potrò offrire al mio prossimo
niente che abbia un valore».
Sento che ogni libro sui miei scaffali grida in silenzio: «In verità, il
manoscritto può uscire dalle fiamme carbonizzato e le persone
ustionate, ma l’intensità di una preoccupazione mi ha aiutato
nell’altra. Il dilemma non è scegliere il monastero o la discoteca,
Harvard o Chanakyapuri (il Vaticano o il Quirinale), la tradizione o il
progresso, la politica o l’accademia, la Chiesa o lo Stato, la giustizia
o la verità. In una parola, la realtà non è una faccenda di ‘o … o’,
non si tratta di scegliere tra spirito e materia, contemplazione e
azione, messaggio scritto e persone vive, Oriente e Occidente,
teoria e prassi, oppure tra divino e umano».
1
Il mio senso e il mio destino sono inscritti in queste parole. Io sono
una biblioteca, perciò esisto nel mondo e grazie agli uomini che
hanno scritto, stampato, comprato e custodito i miei testi, esisto per
loro e nel loro mondo. Esisto anche perché è esistito un uomo.
1Le citazioni di questo capitolo sono tratte da .
,
I Veda-Mantramañjari, testi fondamentali della rivelazione vedica, vol. I, BUR 2001, pp. 37
38.
2. LAMPO
C’era un ragazzo. Nell’anagrafe di Barcellona, dove era nato,
quando in Europa finiva la Prima Guerra Mondiale, lo avevano
chiamato Raimundo Santiago Carlos Pániker, ma lui più tardi
desiderò essere chiamato Raimon Panikkar e con questo nome
passò alla storia. Siamo cresciuti, io con lui e lui con me.
Il ragazzo, sveglio e intelligente, era amante dei libri. Si dilettava in
letture e io, in quel tempo pur piccola e giovane, con sorpresa mi
accorgevo che gli piaceva isolarsi per leggere; con diletto lo
guardavo prendere durante la lettura appunti e ogni tanto perdersi in
pensieri originali e sublimi. Confesso di aver sperato che un giorno in
me si sarebbero trovati anche libri scritti da lui e oggi mi rallegra il
fatto che non mi sono sbagliata, perché questo uomo durante la sua
vita ha scritto molto creando un’opera monumentale. Pensate alla
poeticità metafisica di Eraclito mescolata alla perspicacia speculativa
di Aristotele, mettete insieme la paradossalità vertiginosa di
Nāgārjuna e la perspicace precisione di Immanuel Kant, immaginate
che da qualche parte si intreccino la gentilezza di Lao Tsu e la
fantasia filosofica di Platone, sognate l’incontro tra le espressioni
mistiche di Meister Eckhart e i ragionamenti di Shankara, e in
qualche modo potrete percepire, senza tuttavia venirne a capo, la
grandezza, l’estensione e la profondità dell’opera di Panikkar. Del
resto gli autori appena nominati erano ben noti a questo erudito, lui
dialogava di continuo con loro e sui miei scaffali si trovano anche i
loro scritti.
Di solito il nome di Panikkar appare quando si parla di dialogo tra le
religioni ed è giusto perché questo tema l’ha occupato
personalmente per decenni: egli stesso in età matura sosteneva di
essere cristiano, indù e buddhista. Il suo appello, affinché le religioni
del mondo si convertano radicalmente e si fecondino reciprocamente
per il bene dell’umanità, rimane tuttora valido. Ma in Panikkar c’è
molto di più. Come chimico e teologo cercava di armonizzare la
scienza moderna e la tradizione umanistica e parlava di “teofisica”.
Come filosofo, dialogando con quanti si occupavano di ecologia,
postulava la “ecosofia”, ossia l’ascolto della saggezza che giace
nella terra e aspetta di essere accolta dagli uomini. Affrontando la
questione della pace, trattava il problema della violenza alla radice e
parlava del disarmo della mente umana e della cultura
contemporanea. Conoscendo e abbracciando in sé molte religioni,
Panikkar ne apprezzava le ricchezze, ma non ignorava il loro
bagaglio obsoleto di stupidità e inerzia che soffocano la vita, e
sognava una loro autentica trasformazione provocata da un soffio
mistico. Era convinto che l’umanità fosse arrivata a un punto in cui
avrebbe dovuto ridefinire la sua visione del cosmo, il suo modo di
comprendere l’uomo e persino il suo concetto di Dio. In funzione di
quest’opera aveva creato una nuova parola, “cosmoteandrismo”, con
cui proponeva un nuovo disegno, paradigma o mito in cui avrebbe
dovuto trasformarsi la mentalità comune, grazie allo svuotamento
interiore, ossia una nuova innocenza che permettesse a tutti di
seguire il “ritmo dell’essere”, unico a poterci garantire la pienezza
della vita che ci è stata affidata.
Panikkar crebbe a Barcellona. Da questa città fu costretto a fuggire
durante la guerra civile spagnola. Tornato, a ventun anni divenne
membro dell’appena nascente Opus Dei e poi uno dei primi
sacerdoti di questo movimento da cui assorbì il radicalismo cristiano
e il meglio della scolastica cattolica. Col tempo però venne a crearsi
un conflitto tra lui e l’associazione e Panikkar fu espulso dall’Opus
Dei. Stabilitosi in India, nella santa città di Varanasi, con ardore si
dedicò allo studio del pensiero Vedico e all’approfondimento del
buddhismo. Simultaneamente entrò in rapporti con le università degli
Stati Uniti, prima Harvard e poi Santa Barbara, dove fu professore.
Per anni visse spostandosi continuamente tra la sua casetta con la
terrazza sul Gange a Varanasi e la bella casa sulla costa
californiana, soffermandosi regolarmente in vari paesi europei.
Sembra che questo continuo spostamento abbia rinforzato
l’effervescenza del suo pensiero, perché senza sosta scriveva,
studiava, predicava e insegnava. Diventò uno degli uomini più colti e
profondi dell’epoca, amico dei grandi del suo tempo, da Paolo VI al
Dalai Lama, da Martin Heidegger a Mircea Eliade, da Henri Le Saux
a Bede Griffiths, da Emil Cioran a Octavio Paz; con essi dialogava
pur conservando la propria originalità: Panikkar non fu discepolo di
nessuno.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :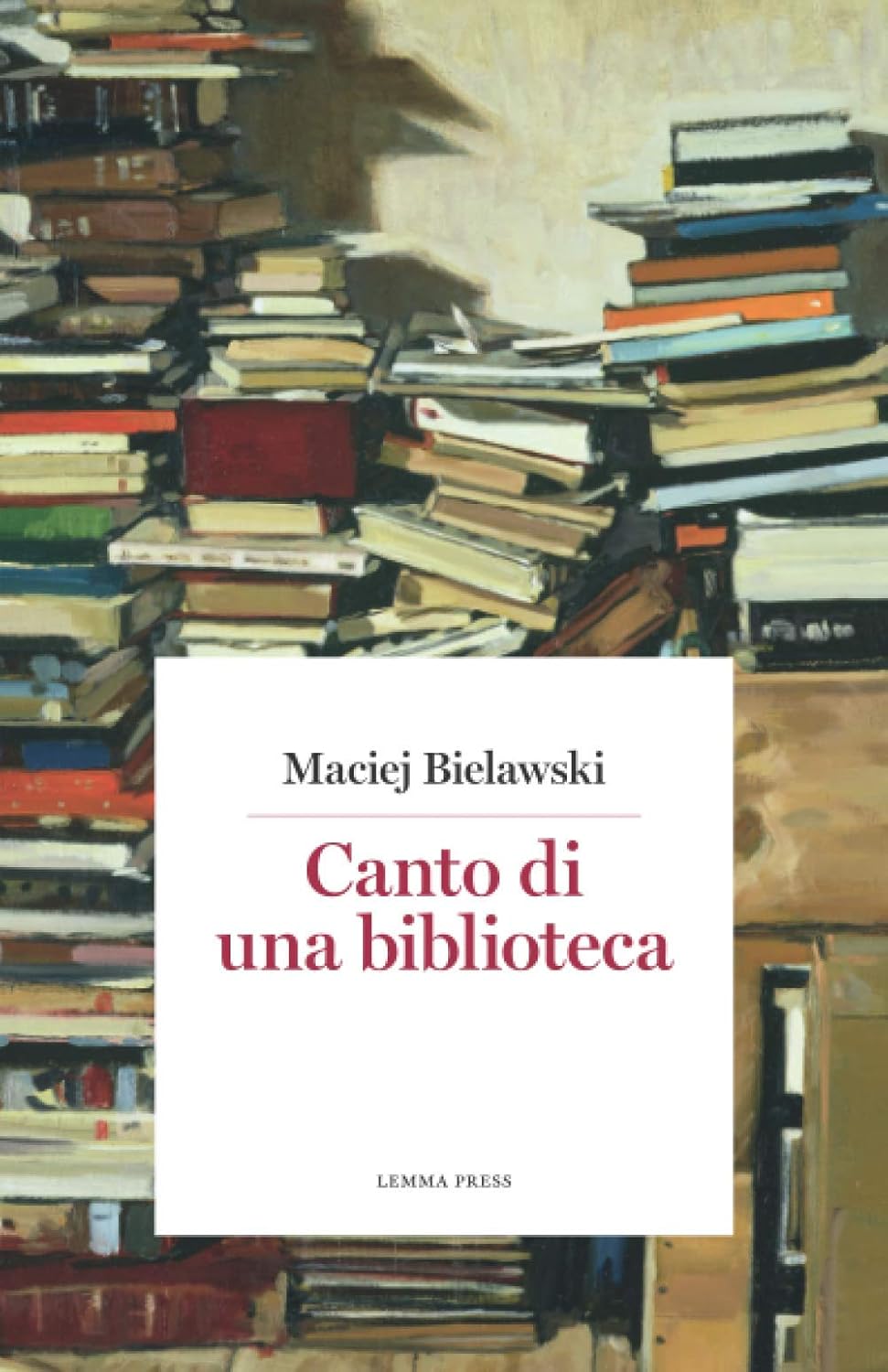






1 commento