Almost blue – Carlo Lucarelli
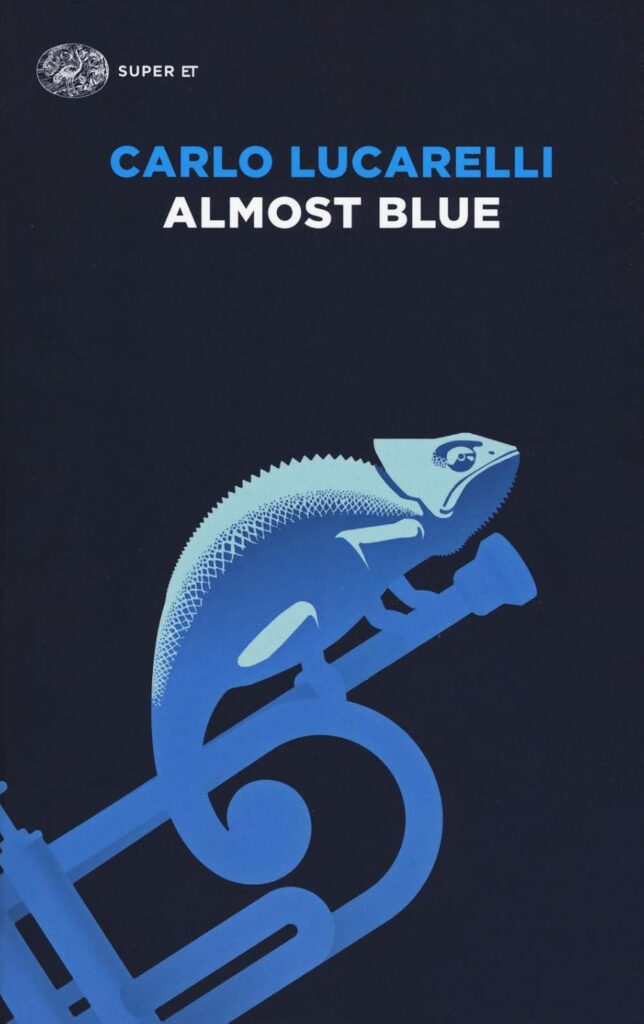
SINTESI DEL LIBRO:
Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce, che sa appena un
po’ di polvere. Quello del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo
trattenuto, come uno schioccare di lingua, ma non umido, secco. Una lingua di
plastica. La puntina, strisciando nel solco, sibila pianissimo e scricchiola, una o
due volte. Poi arriva il piano e sembrano le gocce di un rubinetto chiuso male e il
contrabbasso, come il ronzio di un moscone contro il vetro chiuso di una
finestra, e dopo la voce velata di Chet Baker, che inizia a cantare Almost Blue.
A starci attenti, molto attenti, si può sentire anche quando prende fiato e
stacca le labbra sulla prima a di almost, cosí chiusa e modulata da sembrare una
lunga o. Al-most-blue... con due pause in mezzo, due respiri sospesi da cui si
capisce, si sente che sta tenendo gli occhi chiusi.
Per questo mi piace Almost Blue. Perché è una canzone che si canta a occhi
chiusi.
Io, con gli occhi chiusi, ci sto sempre, anche se non canto. Sono cieco, dalla
nascita. Non ho mai visto una luce, un colore o un movimento.
Ascolto.
Scandaglio il silenzio che mi circonda, come uno scanner, uno di quegli
apparecchi elettronici che spazzano l’etere a caccia di suoni e di voci e si
sintonizzano automaticamente sulle frequenze occupate. So usarli benissimo, gli
scanner, quello che ho dentro la testa da venticinque anni, fin da quando sono
nato e quello che tengo in camera mia, accanto al giradischi. Se avessi degli
amici, se ne avessi, di sicuro mi chiamerebbero Scanner. Mi piacerebbe.
Io di amici non ne ho. Per colpa mia. Perché non li capisco. Parlano di cose
che non mi riguardano. Dicono lucido, opaco, luminoso, invisibile. Come in
quella favola che mi raccontavano da bambino per farmi dormire, in cui c’era
una principessa cosí bella e con una pelle cosí fine che sembrava trasparente. Ci
ho messo tanto, tante notti sveglio a pensare, prima di capire che trasparente
voleva dire che ci si poteva guardare dentro.
Per me significava che le dita ci passavano attraverso.
Anche i colori per me hanno un altro significato. Hanno una voce, i colori, un
suono, come tutte le cose. Un rumore che li distingue e che posso riconoscere. E
capire. L’azzurro, per esempio, con quella zeta in mezzo è il colore dello
zucchero, delle zebre e delle zanzare. I vasi, i viali e le volpi sono viola e giallo è
il colore acuto di uno strillo. E il nero, io non riesco a immaginarlo ma so che è il
colore del nulla, del niente, del vuoto. Però non è solo una questione di
assonanza. Ci sono colori che per me significano qualcosa per l’idea che
contengono. Per il rumore dell’idea che contengono. Il verde, per esempio, con
quella erre raschiante, che gratta in mezzo e prude e scortica la pelle, è il colore
di una cosa che brucia, come il sole. Tutti i colori che iniziano con la b, invece,
sono belli. Come il bianco o il biondo. O il blu, che è bellissimo. Ecco, ad
esempio, per me una bella ragazza, per essere davvero bella, dovrebbe avere la
pelle bianca e i capelli biondi.
Ma se fosse veramente bella, allora avrebbe i capelli blu.
Ci sono anche colori che hanno una forma. Una cosa rotonda e grossa è
sicuramente rossa. Ma le forme non mi interessano. Non le conosco. Per
conoscerle bisogna toccarle e a me toccare non piace, non mi piace toccare la
gente. E poi con le dita sento solo le cose che ho attorno, mentre con le orecchie,
con quello che ho dentro la testa, posso arrivare lontano. Preferisco i rumori.
Per questo uso lo scanner. Tutte le sere, salgo in camera mia e metto sul piatto
un disco di Chet Baker. Sempre lo stesso, perché mi piace il suono della sua
tromba, tutte quelle p, piccole e profonde, che mi girano attorno e mi piace la sua
voce che canta piano, come se venisse da dietro la gola e facesse fatica a uscire e
per farlo si dovesse soffiare con tanto impegno da dover chiudere gli occhi.
Soprattutto quel pezzo, Almost Blue, che io punto per primo, anche se è l’ultimo.
Cosí tutte le sere e tutte le notti aspetto che Almost Blue mi scivoli lentamente in
fondo alle orecchie, che la tromba, il contrabbasso, il pianoforte e la voce
diventino la stessa cosa e riempiano il vuoto che ho dentro la testa.
Allora, accendo lo scanner e ascolto le voci della città.
Io, Bologna, non l’ho mai vista. Ma la conosco bene, anche se probabilmente
è una città tutta mia. È una città grande: almeno tre ore.
L’ho sentito una volta che mi sono sintonizzato sul CB di un camion e l’ho
seguito per tutto il tempo che è rimasto nel raggio del mio scanner. Da quando è
entrato finché non l’ho sentito sparire all’improvviso, il camionista ha sempre
parlato con qualcuno, guidato e parlato, guidato e parlato, per tutta la mia città.– Qui Rambo, qui Rambo... chi mi copre? Sono appena entrato al casello di
Rimini sud... occhio perché c’è la Finanza in uscita...
Qui Rambo... vieni avanti El Diablo... ho una dritta per un pompino...
tangenziale, uscita Casalecchio di Reno, angolo distributore... chiedere di
Luana...
Qui Rambo... chi sei, Maradona? Senti un po’, come sarebbe che El Diablo è
incazzato? Non lo sapeva che la Luana è un travestito? Se lo copri digli che mi
sto fermando a dormire al Parma 2 e che lo aspetto lí... e che vada bene a farsi
dare nel cu...
Cessano di colpo le voci che corrono sulle strade, troncate all’improvviso. La
mia città ha un perimetro netto, definito dal silenzio, un bordo, come quello di
un tavolo sospeso nel nulla. Oltre il bordo c’è un abisso che le inghiotte, piú nero
del nero. E vuoto.
A volte, invece, mi sintonizzo sulla centrale operativa della questura e ascolto
la voce gracchiante delle volanti. È come se stessi sospeso nel cielo nero della
mia città e avessi decine di orecchie che corrono dovunque, nel buio.– Volante 4 a Centrale... abbiamo un incidente grave sulla via Emilia... serve
un’ambulanza con la massima urgenza...– Qui Volante 2... siamo davanti alla Banca Cooperativa... l’allarme suona ma
non c’è nessuno...– Fammi subito un terminale su questa targa... A come Ancona, D come
Domodossola...– Allora... il giovane, qui, è senza precedenti penali ma la ragazza è
minorenne e non ha i documenti... che si fa?– Ricevuto... ci portiamo in zona...– Overdose, cazzo... questo ci muore in macchina...– Siena Monza 51... Siena Monza 51...– Vieni avanti, Siena Monza...– Allora senti, siamo in viale Filopanti, angolo via Galliera e abbiamo qui una
negra senza documenti...
La voce è forte, tutta di naso, come se avesse il raffreddore. Dietro, in
sottofondo, c’è il ringhio verde delle auto che passano e quello sottile, ronzante e
azzurro, dei motorini. Dietro, ancora piú sotto, tanto che quasi si confonde con la
tromba di Chet Baker, voci acute, che pungono appena, «no, io non viene... hai
male, io non viene...» E un’altra, piú forte, voce grossa, voce rossa, «oh, sta’
qui... dove cazzo vai? Ne vuoi un’altra? Eh? Ne vuoi ancora?»
Quando voglio scendere e fermarmi ad ascoltare una storia, allora lascio che
lo scanner si sintonizzi sui cellulari.– Che cazzo fa quello lí con le cuffie?
Musica, dietro. Lontana. Soltanto il pulsare continuo di una batteria
elettronica, filtrata da qualcosa di spesso, forse un muro. Davanti, il fruscio
verdissimo di un GSM e dentro un’altra voce, dal fondo liquido, che gorgoglia
appena sotto le elle e le erre.– Merda se sono in cassa... pronto? oh, senti un po’, Lalla, dov’è il rave? Qua
non lo sa nessuno...– Che cazzo fa quello lí con le cuffie?
Meno liquida, questa, e piú appannata, fumosa, come velata da una nebbia
densa. Sta a metà tra il pulsare lontano della musica e la voce che parla nel GSM.– Oh, Tasso... che cazzo fa quello lí con le cuffie?– Va’ a cagare, Misero... che cazzo ne so? Sarà un buttafuori...– Ha le cuffie da fonico...– Allora sarà un fonico... pronto Lalla? Ci sei? Merda, Tasso... ha messo giú!
E adesso chi ce lo dice dov’è il rave?– Chiediamolo al fonico...– Ecco, bravo... chiedilo al fonico e togliti dal cazzo... Pronto, Lalla?– Oh, Tasso... non è un fonico, è uno schizzatissimo che dice di avere del gran
fumo. Che cazzo ci farà quello lí con le cuffie...
Quando la storia non mi interessa piú, quando non la capisco piú, spingo il
pulsante che cambia sintonia e vado avanti. Continuo cosí per tutta la notte,
perché quando non puoi vedere la luce dormire di giorno o di notte è la stessa
cosa. Continuo a scandagliare il nero, incrociando a volte il raschiare sottile di
altri scanner che incontrano il mio. Ascoltando le voci della città.
Quando mi stanco, spengo tutto.
Silenzio. Solo il fruscio sottile del silenzio che mi ronza, piano, nelle
orecchie.
Solo Chet Baker che canta Almost Blue.
– Che cazzo fa quello lí con le cuffie?
Sono nudo e ho freddo.
Guardo il mio volto riflesso nella pozza rossa che si è formata sotto il letto e
vedo che quell’animale continua a corrermi sotto la pelle, deformandomi la
faccia. Allora raccolgo da terra un pezzo della maschera che si è staccata dal
muro, una di quelle maschere africane dal viso allungato, e ce lo metto sopra, per
non vederlo piú.
Però le sento.
Le sento le campane dell’Inferno. Me le sento risuonare nella testa, sempre,
tutto il giorno e tutta la notte e a ogni rintocco vibrano fin dentro le ossa, come
se il mio cervello fosse lui stesso una campana viva che pulsa e si spacca a ogni
colpo. A volte sono lontane, giú, sotto la nuca e ne sento soltanto l’eco,
metallica, che mi si allarga dentro, lenta, come un cerchio sottile. Ma poi
ricominciano all’improvviso, piú alte, altissime, un rintocco forte al centro della
testa che mi vibra lungo il naso e sui denti, un rintocco forte che mi batte e
rimbalza dietro la fronte, un rintocco, forte, che mi sfonda le giunture delle ossa
e mi apre il cranio, un rintocco, forte, fortissimo. Le sento, le campane
dell’Inferno. Sempre, ogni giorno e ogni notte, sempre, le sento le campane
dell’Inferno che suonano a morto e suonano per me.
Per non sentirle mi sono coperto le orecchie con le cuffie dello stereo, ma non
basta. Arricciato come una molla, il cavo mi scende lungo il petto e lo spinotto
staccato mi penzola inerte e nudo tra le gambe. Allora accendo lo stereo, su tutti
i bassi e tutti gli alti, la manopola del loudness girata tutta verso destra, tutto il
volume su e tutti i led accesi, fissi sul rosso, fissi. Pianto lo spinotto della cuffia
dentro il buco e di colpo UN MURO nella testa, durissimo e compatto, che mi
scortica i timpani e corre da un orecchio all’altro e lí si blocca, dietro gli occhi,
fermo. La cassa della batteria, il rullante e i piatti serpeggiano veloci nella mia
testa come la lingua di un rettile, la chitarra è una raffica elettrica di pioggia, il
basso un tuono isterico che rotola sempre piú vicino e la voce è un lampo che
attraversa il cielo come un urlo nero. Ho un muro, un muro nella testa, UN MURO
e i rintocchi delle campane ci si schiantano contro, sordi e a ogni colpo
rimbalzano sempre un po’ piú lontano. Il cavo delle cuffie, teso come la catena di
un cane, basta appena per arrivare al letto a castello. Con le ginocchia premute
contro il petto, sento la pelle liscia e ghiacciata delle gambe e i brividi alti che mi
grattano i capezzoli.
Sono nudo e ho freddo ma i vestiti che avevo addosso li ho strappati e quelli
che sono sul pavimento erano cosí inzuppati che adesso si saranno rappresi e
saranno duri come pezzi di cartone. Allora mi rannicchio sul bordo del letto e
appoggio appena la testa sull’angolo del cuscino, per evitare le gocce che
colando dalle maglie della rete di sopra hanno ormai bagnato tutta la federa e il
lenzuolo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






1 commento