All’inferno e ritorno – Europa 1914-1949 – Ian Kershaw
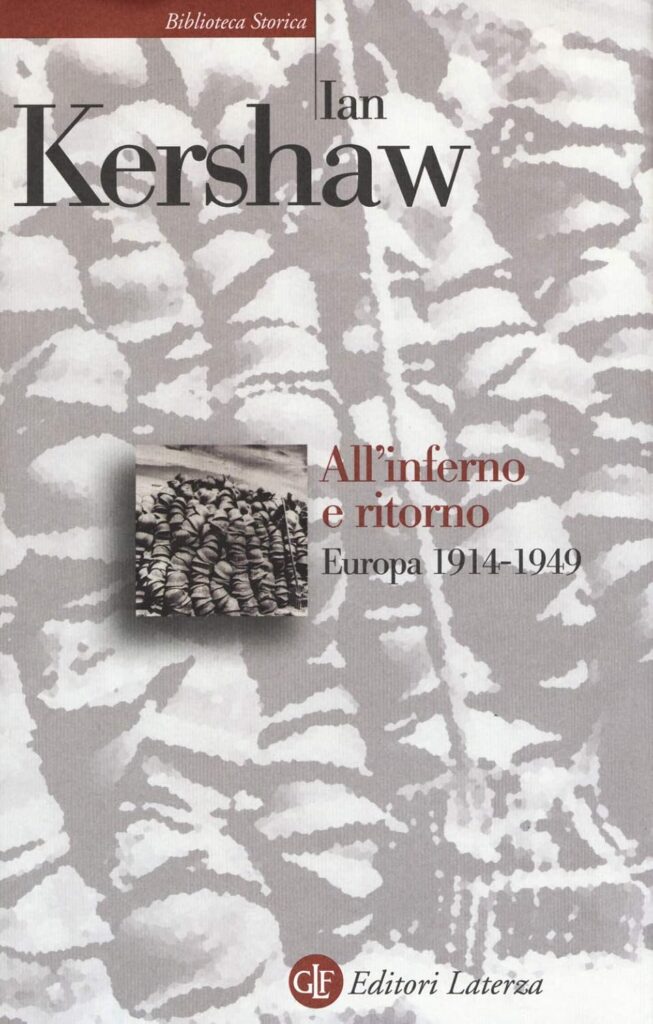
SINTESI DEL LIBRO:
Dopo la prima guerra mondiale l’immagine di una scintillante epoca di
stabilità, prosperità e pace tragicamente inabissatasi negli orrori del
conflitto rimase tenacemente nella memoria, specialmente delle classi
privilegiate. L’«Età dorata»: così gli americani chiamarono gli anni che
l’avevano preceduta. Ma l’espressione coglie bene anche la maniera in cui
gli europei cominciarono a guardare a quell’epoca. La borghesia parigina
ricordava la belle époque come il tempo in cui la cultura francese era
oggetto dell’invidia di tutto il mondo, quando Parigi sembrava il centro
della civiltà. I ceti possidenti di Berlino guardavano all’«epoca
guglielmina» come a un periodo di ricchezza, sicurezza e grandezza: uno
status appropriato alla Germania che aveva recentemente raggiunto la sua
unità nazionale. Anche Vienna sembrava su una vetta per quanto
riguardava la gloria della sua cultura, lo splendore intellettuale e la sua
storica grandezza di potenza imperiale. Monaco, Praga, Budapest, San
Pietroburgo, Mosca e altre città ancora da un capo all’altro del continente
partecipavano di una generale fioritura culturale. Nuove, spregiudicate,
provocatorie forme di espressione artistica abbracciavano praticamente
tutte le sfere dell’arte, della letteratura, della musica e del teatro in
un’esplosione di ardita creatività.
A Londra l’economia contava più della cultura. Nella capitale di un
impero globale la generazione post-Grande Guerra si struggeva per la
tramontata «età dell’oro» della crescita economica ininterrotta, del fiorire
dei commerci e della stabilità valutaria. Nelle parole famose scritte dopo il
conflitto dal grande economista britannico John Maynard Keynes,
«L’abitante di Londra poteva ordinare per telefono, sorseggiando a letto il
tè mattutino, i vari prodotti di tutto il globo terraqueo, nella quantità che
riteneva opportuna, e contare ragionevolmente sul loro sollecito recapito
a casa sua». Naturalmente la prospettiva di Keynes è quella, altamente
privilegiata, di un uomo della classe medio-superiore che dispone di
ricchezza e prestigio, e vive nella città che è il centro del commercio
mondiale. Ben pochi negli shtetlekh dell’Europa orientale, nelle campagne
impoverite dell’Italia meridionale, della Spagna, della Grecia o della
Serbia, o tra le masse urbane ammucchiate negli slum di Berlino, Vienna,
Parigi, San Pietroburgo, o della stessa Londra, avrebbero riconosciuto in
un ritratto così idilliaco qualcosa di familiare. E tuttavia l’immagine di
un’«età dell’oro» non era soltanto creazione del dopoguerra.
Malgrado le divisioni interne e le rivalità nazionalistiche dell’Europa,
tutti i paesi del continente erano accomunati dal libero movimento delle
merci e dei capitali, nel quadro di un’economia capitalistica globale le cui
componenti erano strettamente collegate. La stabilità, che era la
precondizione della crescita economica, poggiava sul riconoscimento del
gold standard come una sorta di moneta mondiale, che affondava le radici
nella posizione dominante della City londinese. In questa situazione, la
chiave della stabilità dell’economia mondiale era nelle mani della Banca
d’Inghilterra. Le entrate invisibili – spedizioni marittime, assicurazioni,
interessi, esportazioni – pareggiavano, e anzi superavano il deficit
risultante dal fatto che la Gran Bretagna importava più di quanto
esportava. Negli anni 1897-98 c’era stato un grande aumento dell’offerta
di oro, specialmente da parte del Sudafrica. Ma la Banca d’Inghilterra
evitò sia di accumulare riserve auree troppo ingenti (una cosa che avrebbe
danneggiato gli altri paesi) sia di ridurle. Le economie degli Stati Uniti e
della Germania erano più dinamiche di quella britannica, e crescevano
più velocemente. A questo punto, sembrava probabile che il futuro
avrebbe visto l’instaurazione di un dominio americano sull’economia
mondiale. Ma la Gran Bretagna continuava a detenere la quota più
cospicua (benché in diminuzione) del commercio mondiale, ed era
nettamente il maggior esportatore di capitale d’investimento. Non c’è
dubbio che la rivalità tra le grandi potenze per lo sfruttamento economico
del globo sottoponesse a una tensione crescente la stabilità dell’economia
capitalistica internazionale. Ma fino al 1914 il sistema, che nel corso dei
precedenti decenni era stato fonte di così grandi vantaggi per l’Europa, e
specialmente per le parti industrializzate del continente, rimase indenne.
La fiducia nel perdurare della stabilità, della prosperità e della crescita era
generale.
Quando nel 1900 fu inaugurata a Parigi l’Esposizione Universale, l’idea
era di farne la vetrina di una civiltà in piena fioritura il cui centro era
l’Europa, un altisonante peana in lode del progresso. Un’epoca di nuove
tecnologie si squadernava sotto gli occhi dei visitatori. Enormi macchine
li impressionavano con la loro potenza e velocità. Lo splendore del
Palazzo dell’Elettricità, illuminato da 5000 lampadine, era letteralmente
abbagliante. Ventiquattro nazioni europee, cui si aggiungevano paesi
africani, asiatici e latinoamericani e gli Stati Uniti, avevano allestito
elaboratissimi padiglioni, che nel corso dei sei mesi successivi sarebbero
stati visitati da non meno di 50 milioni di persone, molte in uno stato di
esterrefatta ammirazione. L’Europa orientale, soprattutto la Russia con i
suoi nove padiglioni, era presente in forze. E ben in vista era la «missione
civilizzatrice» dell’Europa. Con l’imperialismo al suo apogeo, le
rappresentazioni sontuosamente esotiche di remoti possedimenti coloniali
comunicavano l’irresistibile impressione di un’Europa dominatrice del
mondo. Il commercio, la prosperità e la pace sembravano garantire
l’illimitata continuazione di questo dominio. Il futuro si presentava con
colori brillanti.
L’ottimismo appariva giustificato. A paragone con ciò che l’aveva
preceduto, per tacere di ciò che l’avrebbe seguito, l’Ottocento era stato un
secolo di pace. In Europa l’ultima guerra generale, di portata
continentale, era stata quella conclusasi nel 1815 con la fine dell’epoca
napoleonica. La guerra nell’appartata Crimea tra il 1853 e il 1856, come
pure i brevi conflitti culminati nell’unificazione dell’Italia e della
Germania rispettivamente nel 1861 e nel 1871 non avevano minacciato la
pace complessiva del continente. Dieci anni dopo la grande Esposizione
parigina uno scrittore britannico, Norman Angell, pubblicò un bestseller
internazionale intitolato The Great Illusion, in cui si spinse addirittura ad
affermare che la ricchezza moderna, frutto dei commerci e di
un’economia globale interdipendente, faceva della guerra uno strumento
inutile. Molti, non solo in Gran Bretagna, erano d’accordo.
Era difficile immaginare che la prosperità, la pace e la stabilità non
sarebbero continuate indefinitamente, che potessero essere spazzate via
così presto e così rapidamente.
Ma l’Europa aveva anche un’altra faccia, molto meno attraente. Il tessuto
sociale stava mutando velocemente, benché in modo tutt’altro che
uniforme,
da un capo all’altro del continente. Regioni
d’industrializzazione intensa e accelerata coesistevano con vaste aree che
erano tuttora primariamente, spesso quasi primordialmente agricole. Nel
1913 circa i quattro quinti della popolazione lavoratrice serba, bulgara e
romena continuavano a ricavare i loro mezzi di sussistenza dalla terra.
Nell’insieme dell’Europa questa quota superava i due quinti. Soltanto la
Gran Bretagna faceva registrare un livello di poco superiore a un decimo.
E nel 1913 soltanto in Gran Bretagna, Belgio e, cosa più sorprendente, in
Svizzera (ma non ancora in Germania) la quota della popolazione
lavoratrice occupata nell’industria superava i due quinti. La maggior parte
degli europei continuava a vivere nei villaggi e nei piccoli centri. Il tenore
di vita migliorava costantemente, sebbene rimanesse miserabile per la
maggioranza degli europei: sia per le masse brulicanti che cercavano
lavoro nei malsani ambienti di città come Berlino, Vienna o San
Pietroburgo, sia per coloro che continuavano a sbarcare precariamente il
lunario lavorando nelle campagne. Molti invece andavano via. La povertà
e la mancanza di opportunità spinsero molta gente ad abbandonare il
proprio paese. Lungi dall’apprezzare i benefici della prosperità e della
civiltà, milioni di europei pensavano soltanto a scappare. L’emigrazione
verso gli Stati Uniti raggiunse il culmine nel 1907, quando furono più di
un milione gli europei che attraversarono l’Atlantico. La grande
impennata in questo principio di secolo (una triplicazione rispetto al
decennio precedente) riguardò coloro che fuggivano dall’Austria
Ungheria, dalla Russia e, più che da qualunque altra area, dal poverissimo
Mezzogiorno d’Italia.
La rapidità del cambiamento sociale creò nuove pressioni politiche, che
cominciarono a minacciare l’ordine politico costituito. Negli anni
immediatamente precedenti la prima guerra mondiale in Europa il potere
politico rimaneva nelle mani di pochi. Nella maggior parte dei paesi
erano ancora le élites terriere e le vecchie famiglie aristocratiche, talvolta
alleate per via di matrimonio con le nuove dinastie che traevano la loro
enorme ricchezza dall’industria e dal capitale finanziario, a comporre la
classe di governo e gli alti gradi della gerarchia militare. Va inoltre
ricordato (e non è la cosa meno importante) che l’Europa era ancora un
continente di monarchie ereditarie. Soltanto la Svizzera (la cui veneranda
confederazione aveva adottato una moderna costituzione federale
repubblicana nel 1848), la Francia (dal 1870) e il Portogallo (dal 1910)
erano delle repubbliche. Nell’Austria-Ungheria il Kaiser Francesco
Giuseppe, sul trono dal 1848, capo dell’immenso impero multinazionale
degli Asburgo, che contava più di 50 milioni di sudditi, sembrava
simboleggiare la capacità di durare dell’istituto monarchico.
Ciò non toglie che una forma di governo costituzionale, il pluralismo
dei partiti politici (poggiante peraltro su un suffragio estremamente
ristretto) e un sistema giuridico esistessero praticamente ovunque. Persino
l’autocrazia russa dovette fare concessioni in seguito al tentativo
rivoluzionario del 1905, quando lo zar Nicola II fu costretto a riconoscere
alla Duma (il parlamento russo) prerogative destinate a rivelarsi quanto
mai precarie. Ma ampie sezioni della popolazione, anche in Gran
Bretagna (considerata la patria della democrazia parlamentare), erano
tuttora prive di qualunque rappresentanza politica. È vero che in alcuni
paesi esisteva da tempo il suffragio universale maschile. In Germania, ad
esempio, la costituzione del Reich (1871) accordò a tutti i maschi sopra i
venticinque anni di età il diritto di votare per eleggere il Reichstag (ma
l’elezione del parlamento della Prussia, che costituiva i due terzi
dell’intero territorio del Reich, rimase governata da un suffragio
altamente restrittivo). In Italia il passaggio a un suffragio maschile (quasi)
universale arrivò molto più tardi, nel 1912. Ma all’alba del Novecento le
donne non erano ammesse a votare per eleggere il parlamento in nessun
paese europeo. In numerosi paesi le campagne femministe contestarono
questa discriminazione, ma prima della Grande Guerra ebbero scarso
successo, salvo che in Finlandia (dove, malgrado facesse parte dell’impero
russo, si dimostrò possibile introdurre un certo grado di democrazia sulla
scia dell’abortita rivoluzione russa del 1905) e in Norvegia.
La novità fondamentale, cui le élites di tutti i paesi guardavano come a
una minaccia mortale per il loro potere, era stata la nascita di un
movimento della classe operaia organizzato in partiti e sindacati. La
«Seconda Internazionale» dei partiti socialisti europei, fondata nel 1889,
era stata concepita come un’organizzazione-ombrello cui affidare il
compito di coordinare le piattaforme programmatiche dei singoli partiti
nazionali. Questi partiti rimanevano perlopiù legati in una forma o
nell’altra alla dottrina rivoluzionaria enunciata da Karl Marx e Friedrich
Engels. Il loro attacco contro la congenita natura sfruttatoria del
capitalismo, e il quadro delineato dalla loro propaganda di una nuova
società basata sull’eguaglianza e sull’equa distribuzione della ricchezza,
avevano un’ovvia e crescente attrattiva agli occhi di gran parte della
povera e immiserita classe operaia industriale. I tentativi delle élites
dominanti di mettere al bando o sopprimere i partiti operai e i sindacati
in via d’espansione erano falliti. Adesso gli operai erano in grado di
organizzare la difesa dei loro interessi meglio di quanto fosse mai stato
possibile in passato. La rapida crescita dei sindacati era un effetto di questa
situazione. Nel 1914 in Gran Bretagna i sindacati contavano oltre quattro
milioni di iscritti, in Germania più di 2,5 milioni e in Francia circa un
milione.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :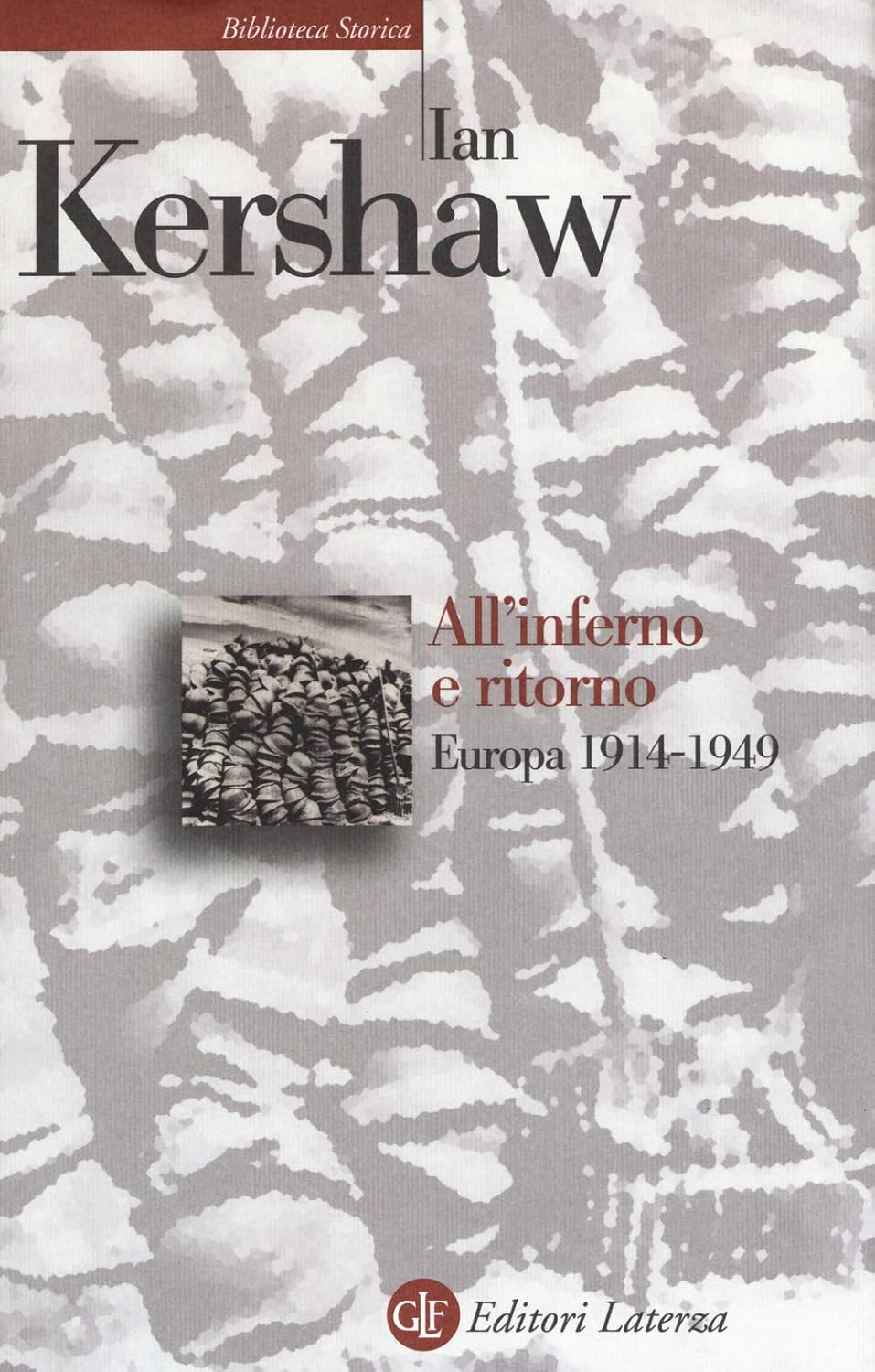






Commento all'articolo