A piedi scalzi nel kibbutz – Masal Pas Bagdadi
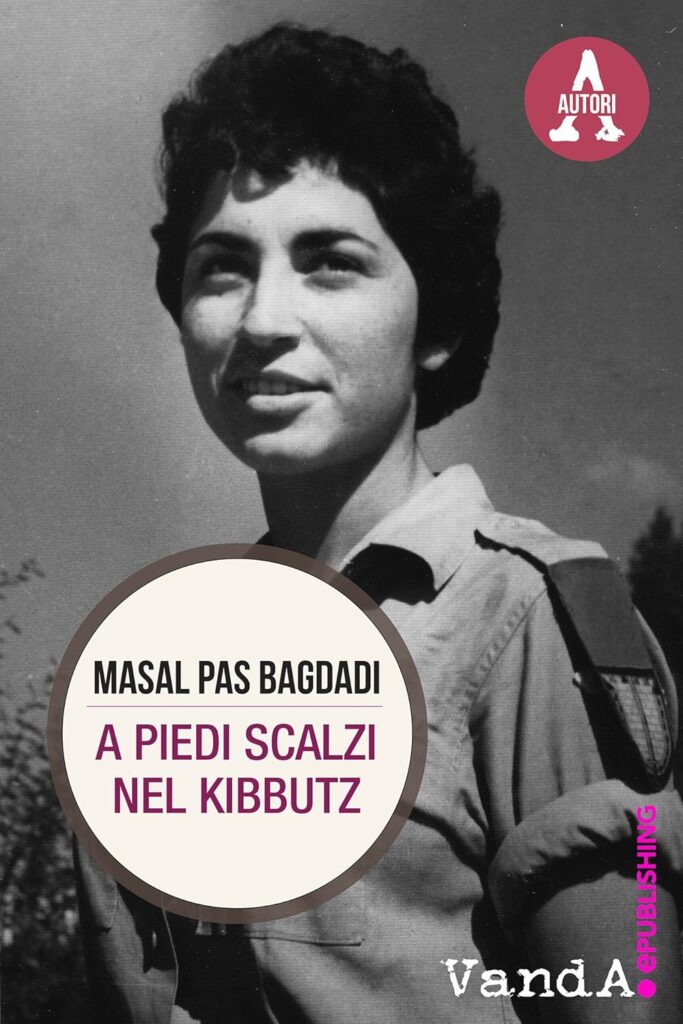
SINTESI DEL LIBRO:
Sono nata nel ghetto di Damasco, in Siria, nel giorno di Tisha be
av, tempo di digiuno, di pianto e di lutto per il popolo ebraico che in
quella data ricorda la distruzione del Beth ha-mikdash, il Tempio di
Gerusalemme, compiuta dalle legioni romane del futuro imperatore
Tito. Secondo il credo popolare, sarà proprio quello il giorno in cui
avverrà la speranza millenaria del nostro popolo e arriverà il Messia.
Le emozioni che segnano tale ricorrenza, il lutto e la speranza,
sono profondamente impresse nella mia personalità che da sempre
rivela una sorta di doppia natura, motivo per cui vivo fino in fondo
dolori e tristezze, gioie e felicità.
Da piccola ero allegra e sorridente e attiravo la benevolenza
degli altri, familiari o estranei che fossero, ma allo stesso tempo
piangevo con una tale facilità che mia madre mi aveva
soprannominata eikhah, colei che piange, alludendo alla mia data di
nascita e al legame con il libro di Eikhah, scritto dal profeta Geremia
per esprimere il suo strazio dopo la distruzione del Tempio.
Il quartiere di Damasco in cui sono nata si chiamava Haret il
Yeud, la strada degli ebrei, da quando, sul finire dell’Ottocento, questi
ultimi furono costretti a trasferirsi in una zona periferica della città,
staccandosi bruscamente dalle loro antiche abitudini. In Siria, fino ad
allora, la convivenza secolare tra arabi ed ebrei era stata piuttosto
civile, anche se non erano mancati momenti difficili ed episodi crudeli,
segnali di un antisemitismo assai radicato che il propagarsi del
nazionalismo arabo riprendeva a infiammare, provocando
aggressioni via via più frequenti e violente. Intorno agli anni Venti, il
fanatismo scatenò un odio antiebraico feroce, così, nel giro di pochi
anni, gli ebrei siriani vennero spogliati di gran parte dei loro beni,
costretti ad abbandonare case e fiorenti attività commerciali,
ritrovandosi sempre più poveri e isolati.
Haret il Yeud era dunque un ghetto, relegato ai margini della città
e circondato da quartieri arabi altrettanto poveri, i cui abitanti
sfogavano contro i discendenti di David la rabbia della loro miseria,
abbandonandosi a una violenza primitiva. Se nei primi anni del
Novecento le incursioni erano episodi sporadici, con il passare del
tempo divennero frequenti e sanguinose, veri e propri pogrom che
costringevano la nostra comunità a vivere nel terrore, in uno spazio
chiuso, separato dal resto della città, anche se non vi erano né mura
né porte a circoscrivere il quartiere. La vita, soprattutto per le donne e
i bambini, si svolgeva all’interno di questo universo, salvo rare
eccezioni. Per me, la piccola Tune – ero stata chiamata così, con lo
stesso nome di una zia, morta di parto –, il mondo fuori dal ghetto
appariva lontano e irreale come una fiaba, anche se potevo scorgerlo
al di là della strada: guardavo passare il tramvai, sul quale non sarei
mai salita, osservavo gli uomini seduti nei caffè intenti a giocare a
sheish besh – una specie di dama –, seguivo con gli occhi i miei
coetanei arabi che correvano liberi sui marciapiedi. La mia esistenza,
invece, era limitata al quartiere, tra i membri della comunità, in un
ambiente compatto e rassicurante, dove si seguivano
scrupolosamente i precetti dell’ebraismo: tutti erano religiosi, tutti
mangiavano kasher, tutti osservavano lo shabbat, il sabato ebraico.
Le strade erano in terra battuta, con case piccole, basse, fatte di
argilla e mattoni. Noi abitavamo in un edificio che nel passato doveva
essere stato utilizzato come stalla o come magazzino: un grande
cortile, lastricato di pietra, sul quale si aprivano più di dieci stanzoni e,
nell’angolo più nascosto, un unico gabinetto, stretto e scuro, che
consisteva in un buco scavato per terra, chiuso da una sgangherata
porta di legno che cigolava sui cardini con un rumore stridulo e
spaventoso: era il terrore dei bambini che temevano di esservi
rinchiusi in punizione. Quel luogo buio, dove si diceva che si
moltiplicassero i topi, era davvero quanto di più terribile si potesse
immaginare e io stessa, impaurita, mi tenevo il più possibile lontana
dai guai e da quel posto.
Ogni stanzone ospitava un’intera famiglia, ma la vita si svolgeva
soprattutto all’aperto, intorno alla piccola fontana collocata al centro
del cortile. Quest’ultimo brulicava di persone sempre in movimento ed
echeggiava di un continuo vociare di grandi e piccoli, un’ininterrotta
colonna sonora che orchestrava liti, chiacchiere e scherzi. Le donne
animavano quella variegata esistenza, lavando e stendendo il bucato,
cucinando su piccoli fornelli a petrolio, cucendo e riparando i pochi
abiti che possedevano. Anche la sarta Rivcha, una giovane donna
con i capelli neri e ricci, lavorava all’aperto, cantando malinconiche
melodie ebraiche che riempivano l’aria insieme all’odore del carbone
con cui alimentava il suo ferro da stiro.
La casa dove abitavo con i miei era formata da un’unica stanza,
divisa in due da un gradino di dislivello sul pavimento. Nella parte
rialzata era stato sistemato un baule e, appoggiati a una parete, l’uno
sull’altro, i materassi e i tappeti che di sera venivano stesi a terra per
dormire. Nella zona più bassa c’era l’unico vero mobile in nostro
possesso: un grande armadio con lo specchio. Quello specchio mi
permetteva di giocare con la mia immagine. Talvolta, facendo finta di
dormire, lo fissavo per spiare i grandi, cercando di carpirne i segreti.
All’epoca il mio nucleo familiare era composto da cinque figli,
oltre a mia madre e a mio padre: Noemi era la maggiore, e si
prendeva cura di me con particolare tenerezza, poi venivano Moshe
ed Eli, i miei fratelli grandi, molto uniti tra loro e protettivi con noi
piccoli, poi ancora Shifra e infine io. Avevo quattro anni quando
nacque mio fratello, Rafi, e più tardi, dopo che la famiglia si trasferì in
Israele, arrivò l’ultima figlia, Simi.
La nascita di Rafi turbò la mia infanzia, imprimendosi nella mia
mente in ogni particolare. Una mattina, all’improvviso, mi cacciarono
fuori dal cortile, in strada, perché non fossi d’impiccio. Le donne
trafficavano, l’acqua fu messa a bollire sul fuoco e Noemi uscì di
corsa per andare a chiamare la levatrice. Verso mezzogiorno sentii
mia madre urlare; io mi attaccai alle sbarre della finestra e cominciai
anch’io a gridare, chiamandola con tutte le mie forze. Ero arrabbiata
e disperata allo stesso tempo, finché mi giunse il pianto di un
neonato. Di lì a poco qualcuno si ricordò di me, mi prese in braccio e
mi portò in casa, annunciandomi che avevo un nuovo fratello.
Quando mi fu mostrato, sollevando un lembo delle fasce che lo
coprivano con la delicatezza che accompagna una rivelazione
preziosa, osservai bene il suo viso e ogni mio timore si dileguò, in un
istante.
A poca distanza da noi abitavano i nonni materni che
completavano il nostro nucleo familiare. Il nonno Mussa era alto, con
gli occhi chiari, la bocca carnosa e un bel naso semitico che dava
forza al suo viso incorniciato dalla barba e dai peot, i lunghi riccioli
delle tempie. Aveva sempre il capo coperto da una kipah, un piccolo
copricapo, per rispetto e timore di Dio, ed era la vera guida della
famiglia, un solido punto di riferimento per tutti noi, bambini e adulti.
Le vicende dolorose della vita non avevano inasprito la sua anima,
ma piuttosto ne avevano rafforzato il fascino e la saggezza, tanto che
veniva chiamato Rabbi Mussa.
Come molti ebrei siriani che avevano presagito l’avvicinarsi della
catastrofe, il nonno aveva tentato la via dell’emigrazione e nel 1905
era partito per l’Argentina, raggiungendo i suoi fratelli che si erano già
stabiliti in quel paese. Ma, una volta tornato a Damasco per radunare
la famiglia e portarla con sé in Sud America, aveva trovato una
situazione drammatica: durante il lungo periodo di assenza, la figlia
maggiore era morta e sua moglie era diventata cieca, per il pianto
ininterrotto, si diceva.
Rabbi Mussa, con la disperazione nel cuore, tentò in ogni modo
di curare la nonna: l’oro portato dal Sud America, che doveva servire
per pagare le spese del viaggio di ritorno, fu speso tra medici,
guaritori e personaggi di ogni risma, chiunque promettesse di poterle
rendere la vista. I nonni, perseguitati dal destino avverso, poco dopo
persero anche la secondogenita, quella zia Tune, morta di parto,
dalla quale io avrei ereditato il nome. Era rimasta loro soltanto la figlia
più piccola, Miriam, mia madre, e quando ebbe diciassette anni la
diedero in sposa a un giovane ebreo di Baghdad.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :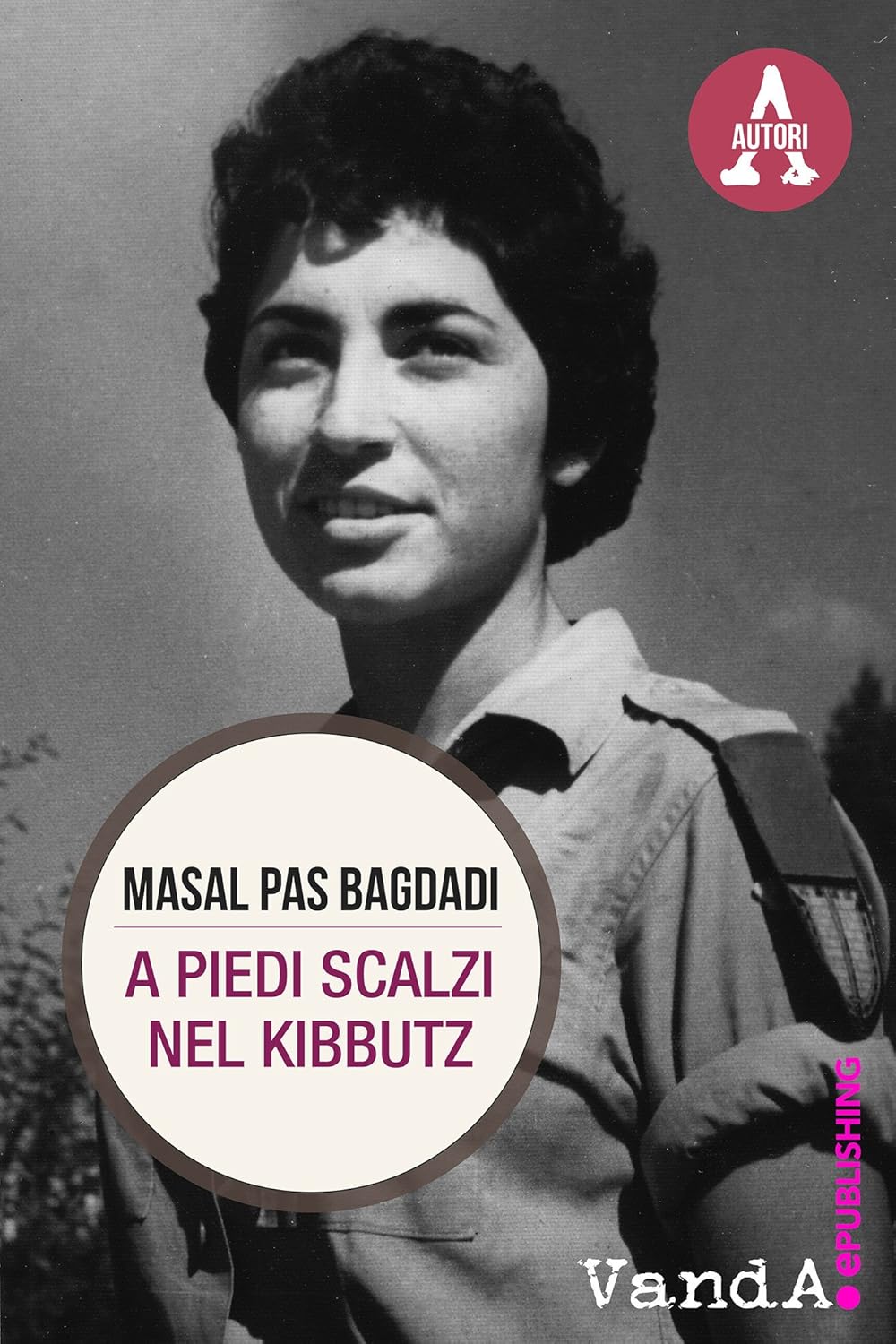






Commento all'articolo