70 d. C. La conquista di Gerusalemme – Giovanni Brizzi
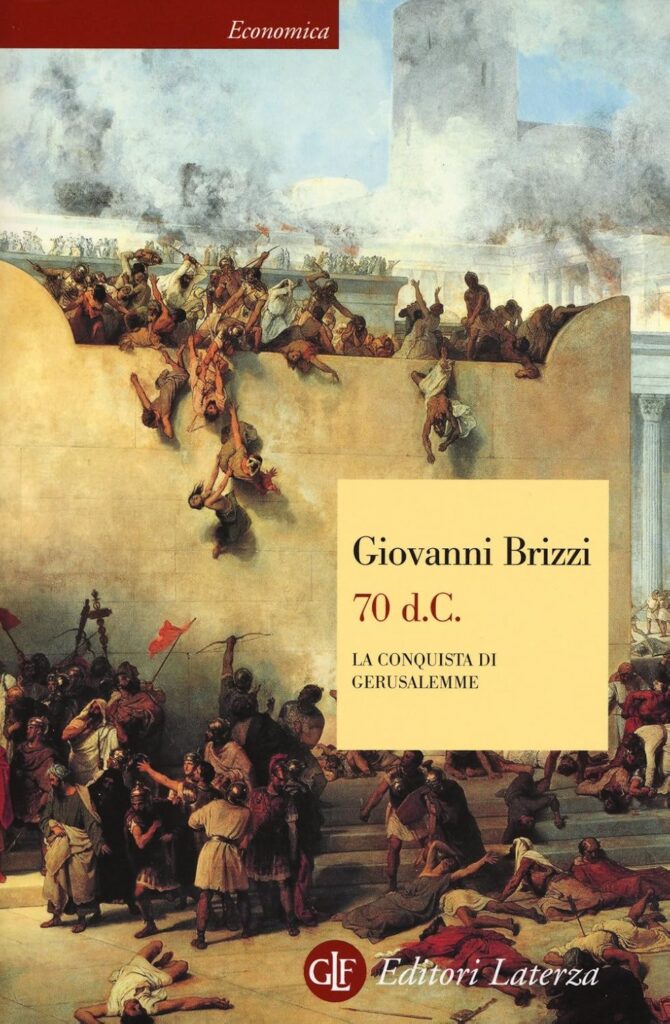
SINTESI DEL LIBRO:
Quando nel 66 d.C. scoppiò la grande rivolta che condusse alla
distruzione di Gerusalemme e del Tempio, il legame tra Roma e gli
Ebrei esisteva ormai da molti anni, dal 161 a.C. almeno: da quando,
cioè, col proposito di creare difficoltà interne al regno di Siria che
tentava di intraprendere il cammino di una difficile ripresa, il senato
della res publica aveva deciso di concedere agli insorti giudaici,
guidati dai fratelli Maccabei, la propria amicizia e di stipulare un
trattato. Questa mossa, pur non traducendosi in un intervento diretto
nella lotta dei ribelli contro il potere seleucide, aveva tuttavia ottenuto
che il pensiero ebraico percepisse al primo contatto la Potenza
italica come uno Stato forte e sostanzialmente virtuoso, pronto a
soccorrere chi ne chiedesse l’aiuto. Era stato anche grazie
all’amicizia di Roma che Simone Maccabeo – il terzo dei fratelli,
assurto a Sommo Sacerdote (142/1-134 a.C.) – aveva potuto
avviare la fortuna di Israele: «E riposò la terra, nei giorni di Simone, il
quale procurava il bene alla sua gente. E piacque loro sempre la sua
signoria e la sua autorità, ... e coltivarono la loro terra in pace, e la
terra dava le sue messi e gli alberi i loro frutti; i vecchi sedevano
nelle piazze ragionando degli affari e i giovani vestivano bene e si
esercitavano nelle armi... Dette al paese la pace, e il paese godé di
grande prosperità, e ognuno sedeva sotto la sua pergola e il suo
fico, e non vi era chi li atterrisse»1.
Neppure un secolo dopo, tuttavia, il rapporto era drasticamente
mutato: al termine della terza guerra mitridatica (64 a.C.), il regno
frattanto costruito a spese dei Seleucidi dalla dinastia degli Asmonei
(che del movimento maccabaico rappresentava l’evoluzione) era
entrato definitivamente nell’orbita di Roma. Occupato da Pompeo,
che aveva osato penetrare nel Tempio di Gerusalemme e violare il
Santo dei Santi, e privato di gran parte delle appendici territoriali
acquisite in circa un secolo di guerre, prima di liberazione e poi di
conquista, il territorio della Giudea aveva conosciuto vicende alterne:
affidato inizialmente al Gran Sacerdote Ircano II (63-40 a.C.), era poi
passato – dopo la parentesi del nipote e rivale Antigono, sostenuto
dai Parti – ad Erode, che fu detto ‘il Grande’.
Figlio di una principessa araba e dell’Idumeo Antipatro, un oriundo
delle terre meridionali di conversione recente, già consigliere di
Ircano, Erode aveva saputo conquistarsi la fiducia prima di Antonio e
poi di Ottaviano. Al di là delle eccezionali qualità di cui era
indubbiamente dotato, quest’uomo disponeva, agli occhi dei Romani,
di un requisito assolutamente unico: una devozione assoluta,
benché interessata.
Erode si era trovato così, grazie alle loro concessioni, alla testa di
domini la cui estensione era prossima a quella massima del regno
asmoneo. Circa un decennio dopo la morte dell’energico sovrano
che aveva cercato di mantenere il rispetto formale delle tradizioni
religiose giudaiche e aveva costruito un nuovo splendido Tempio, ma
aveva governato come un principe ellenistico –, la Giudea era stata
infine sottratta da Augusto al figlio maggiore di lui, il debole e crudele
Archelao (6 d.C.), e mutata in provincia romana di secondo ordine
sotto un praefectus di rango equestre. Successivamente assorbite
sarebbero state anche le tetrarchie, i minuscoli domini affidati agli
altri figli di Erode, Erode Antipa e Filippo. Dopo alcuni esperimenti di
breve durata con Caligola e Claudio, sarebbe stata questa, infine, la
soluzione prescelta: la peggiore, poiché la dinastia indigena
costituiva un prezioso diaframma tra l’ombroso popolo ebraico e quei
Romani il cui dominio neppure le mille cautele anche religiose da
essi adottate riuscivano a rendere tollerabile.
Per capire le ragioni di un rifiuto nei confronti di Roma che, nelle
proporzioni almeno, rimase unico per tutta l’antichità (e che, come
vedremo, provocò una reazione altrettanto estrema da parte
dell’impero) è utile ripercorrere per sommi capi la parabola storica e
ideale del popolo ebraico, dal collasso di quello che si ipotizza
essere stato il mitico impero di Davide (1000-960 a.C.) fino ai primi
decenni dell’era nostra. Esteso a comprendere quasi tutta la
Palestina (escluse ne erano rimaste solo le città filistee e fenicie,
lungo la costa), questo organismo – la cui esistenza, attestata
esclusivamente dalla Bibbia, è oggi revocata in dubbio dagli
archeologi – si sarebbe comunque diviso in più entità già una
generazione dopo la morte del fondatore, e i rapporti tra le diverse
Case regnanti nate da esso sarebbero stati messi in crisi dalla
crescita costante di alcuni caratteri nazionali che, qui più che altrove,
erano pienamente coscienti e avevano cominciato a identificarsi con
la componente religiosa. La tradizione afferma che a Yahveh si
sarebbe reso, da Davide in poi, un culto di Stato a Gerusalemme,
dove – secondo una caratteristica comune alla grande maggioranza
delle civiltà vicino-orientali, inclusa quella egizia – il dio era sentito
come una presenza fisica reale all’interno del Tempio a lui dedicato:
dove, cioè, si manifestava una forma di enoteismo, inteso come
culto di una divinità specifica, tutelare di un singolo popolo, ma
senza pretese universalistiche. Nel suo nome divamparono così
autentiche guerre sante contro nemici che, a loro volta, si
riconoscevano in divinità nazionali (come Kemosh per i Moabiti o
Dagon per i Filistei).
Anche all’interno della compagine ebraica, tuttavia, si produsse
una frattura netta, che coincise con lo scindersi del regno dopo
Salomone. In proposito le fonti, sia quelle mesopotamiche sia la
Bibbia, che parla dei due rami di uno stesso popolo chiamandoli
«figli di Israele», sono concordi; e l’archeologia conferma che – sia
pure con qualche variante – cultura, lingua e religione erano le
stesse. La monarchia di Israele, a nord, comprendeva le regioni che
andavano da Bethel a Dan, vicino al monte Hermon. Qui la pur forte
devozione yahvistica (i nomi teoforici israelitici fanno, comunque,
riferimento ad una divinità soltanto) non impediva la pratica di altri
culti (tra cui, popolarissimo presso la base cananea, quello per la
coppia Baal-Astarte), con un’apertura e una tolleranza che solo la
tradizione successiva avrebbe poi condannato, dividendo secondo il
loro atteggiamento i re in buoni o cattivi. La parte meridionale del
paese, occupata dal regno di Giuda, che inglobava Gerusalemme e
il
Tempio giungendo fino al Negev, rimase invece solidamente
legata, nel più rigoroso esclusivismo, all’autentica tradizione religiosa
nazionale.
Anche se taluni caratteri della religione mutarono profondamente, il
processo di identificazione tra realtà ebraica e yahvismo finì con
l’accentuarsi ulteriormente con l’esperienza del duplice Esilio,
durante il dominio esercitato su Israele e Giuda dagli imperi assiro
prima, neobabilonese poi. Cadde prima Israele, nel 722/21 a.C., e
successivamente Giuda, nel 587/86 a.C. L’ultima età di questo
secondo regno vide l’accentrarsi del culto nazionale, la
proclamazione dell’unicità del Tempio, la distruzione dei luoghi sacri
ad altre divinità e la persecuzione dei loro sacerdoti e dei loro fedeli,
il rifiuto infine di quegli atteggiamenti sincretistici ch’erano stati
talvolta tollerati in passato; e vide altresì la prima sistemazione
organica della Legge (nel Deuteronomio, ovvero «Seconda Legge»).
Espressione del Patto – o Alleanza – con Dio, questa divenne la
base stessa della vita per il popolo ebraico, che finì per maturare la
convinzione che solo il pieno rispetto di essa gli avrebbe garantito la
protezione di Yahveh, pronto altrimenti ad abbandonarlo nelle mani
dei suoi nemici.
Da simili premesse avrebbe preso in seguito l’avvio sia una rilettura
in chiave attuale dei trascorsi religiosi del popolo ebraico, sia una
rivisitazione retrospettiva della sua storia. Da un lato, si invertì la
reale parabola dello yahvismo: per una fede che inizialmente era
aperta a forme sincretistiche e si era poi via via irrigidita e ripiegata
su sé stessa si immaginò, viceversa, un’originaria purezza solo in
seguito contaminata dai contatti con il mondo esterno; e si postulò
che Israele avesse avuto fino dalle origini un dio unico, il quale
aveva orientato ogni fase della sua storia passata. Dall’altro lato, si
vollero rileggere sempre più le vicende della storia ebraica nell’ottica
esclusiva del rapporto con Yahveh, il cui intervento – premiando il
rispetto della Legge o punendone le violazioni – ne aveva
costantemente determinato trionfi e catastrofi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :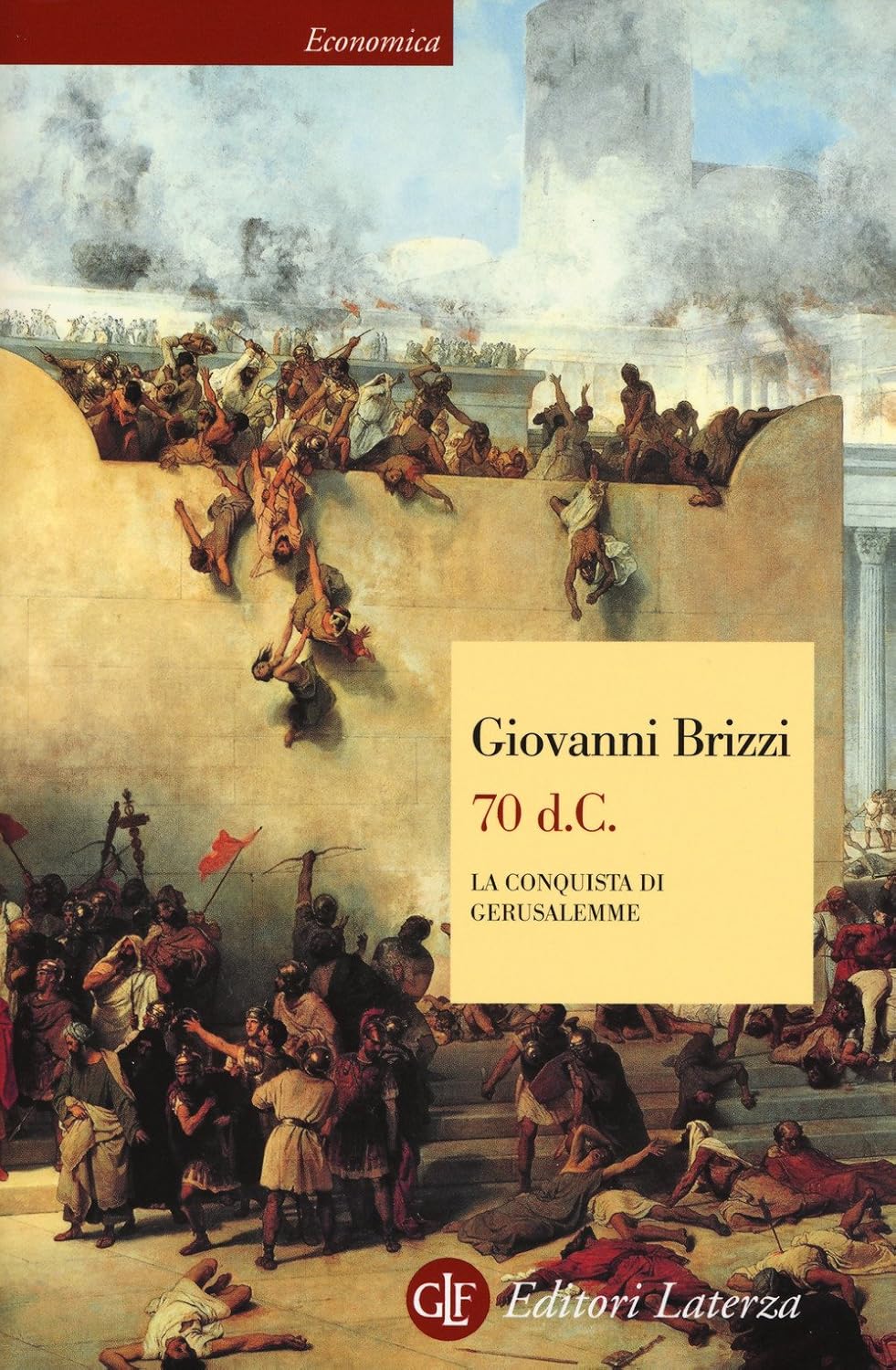






Commento all'articolo