25 luglio 1943 – Emilio Gentile
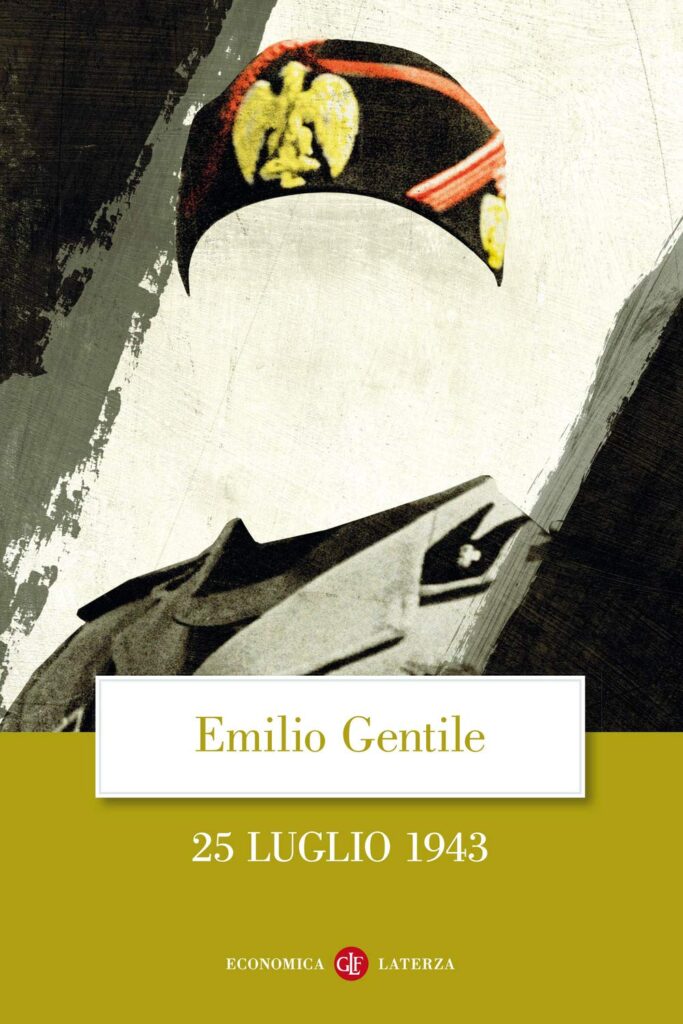
SINTESI DEL LIBRO:
Perché non c’è il verbale
La principale difficoltà nel cercare di ricostruire storicamente come sono
andate veramente le cose dipende dalla mancanza di un verbale ufficiale
della seduta, redatto e approvato da tutti i presenti. Dino Alfieri, che fu
membro del Gran Consiglio dal luglio 1925 al dicembre 1929, poi dal
giugno 1936 all’ottobre 1939, e infine dal maggio 1942 al 25 luglio, ha
scritto nel 1948:
La seduta ebbe luogo nella penultima sala precedente a quella del «Mappamondo», dove il Duce
lavorava. La sala, prospiciente a Piazza Venezia, aveva un aspetto austero e solenne che la
tappezzeria di velluto blu scuro ed i quadri d’autore rendevano più grave.
Una serie di ampi tavoli accostati fra di loro erano allineati a rettangolo, attorno erano disposte le
sedie di foggia antica.
Di solito, al centro era situato un piccolo tavolo per lo stenografo incaricato di stendere il verbale
della seduta. Ma questa volta, si disse per ragioni di segretezza, non vi era stenografo; così come
non prestavano servizio i Moschettieri del Duce normalmente dislocati lungo i corridori ed ai lati
di ogni porta o passaggio, allo stesso modo, per non attirare l’attenzione del pubblico, le
automobili, anziché sostare – come di consueto – davanti all’entrata principale di Palazzo Venezia,
erano state fatte entrare nel cortile-giardino del palazzo attraverso il portone di via degli Astalli,
quella da cui passavano il Duce, i più alti gerarchi ed i personaggi stranieri che si recavano in
udienza da lui27.
La richiesta di uno stenografo per verbalizzare la seduta era stata fatta
qualche giorno prima da Grandi a Scorza, ma gli fu risposto che il duce
non voleva. Quando il 10 aprile 1966 la rivista «Epoca» pubblicò alcuni
documenti riguardanti la seduta del Gran Consiglio, fra i quali l’ordine
del giorno Grandi con le firme dei gerarchi che lo avevano votato, Grandi
fu intervistato per garantirne l’autenticità, come egli fece. Poi, alla
domanda del giornalista se esisteva un verbale della riunione, rispose:
Prima della riunione fui io a domandare esplicitamente al segretario del partito che fosse
ammesso uno stenografo alla riunione. Mussolini si oppose. Al termine della riunione durata 11
ore, dalle 17 del giorno 24 alle 4 del giorno 25, domandai di nuovo al segretario del partito che
fosse redatto un comunicato. Dopo aver interpellato Mussolini, egli mi rispose che il comunicato
sarebbe stato fatto dopo l’incontro che il Capo del Governo avrebbe avuto col Re 28.
Sulla presenza abituale di uno stenografo durante le riunioni del Gran
Consiglio ci sono testimonianze contrastanti. Luigi Federzoni, che fu
membro del Gran Consiglio ininterrottamente dal marzo 1923 al 25
luglio, affermò nelle sue memorie pubblicate nel 1967 che «dei dibattiti di
quel consesso, non resta alcuna documentazione ufficiale»:
Processi verbali non ne furono mai redatti. Nei primissimi tempi assistevano alle sedute due
segretari stenografi, del cui lavoro non si conobbero mai i risultati; e Mussolini, per evitare che nel
mondo trapelassero le discordie e le beghe del Regime, non tardò a dispensare quei funzionari
dalle loro prestazioni. Quanto ai brevi resoconti pubblicati di volta in volta dalla Stefani, essi
diedero costantemente, oltre il testo delle deliberazioni, soltanto i nomi di coloro che avevano
partecipato alle discussioni; e non di rado con intenzionali dimenticanze.
Insomma, Mussolini aveva creato il «supremo organo della Rivoluzione», ma non voleva che
fosse e nemmeno che apparisse libero di esprimere opinioni in contrasto con la volontà del
dittatore29.
Giacomo Acerbo, che fu membro del Gran Consiglio dalla prima
riunione del 1923 fino al giugno 1924, poi di nuovo dal dicembre del
1929 al gennaio 1935, e infine dall’ottobre 1935 al 25 luglio, ha affermato
che le sedute del Gran Consiglio «non sono mai state stenografate né mai
si è usato stenderne una relazione o processo verbale di una certa
ampiezza; veniva unicamente compilato un nudo comunicato per la
stampa sugli argomenti trattati e le decisioni prese»30. Lo stesso ha
affermato Tullio Cianetti, che fu membro del Gran Consiglio dal gennaio
1934 all’agosto 1939 e di nuovo dall’aprile al luglio 1943: «Non è facile
ricostruire tutte le fasi dell’ultima seduta del Gran Consiglio. Per
tradizione non si facevano verbali ed era rigorosamente proibito prendere
appunti. (Di questa proibizione però non tenne alcun conto il Ministro
Biggini che sedeva alla mia destra e che per dieci ore annotò regolarmente
quanto dissero i Membri del Gran Consiglio)»31.
Nulla si sa delle note prese da Biggini, e nulla lui ne scrisse nel suo
diario, dove, alla data del 30 luglio 1943, annotava: «Continuo ad avere
davanti agli occhi e alla mente, nei più minuti particolari, i visi e gli
atteggiamenti, i gesti e le parole dei componenti del Gran Consiglio: mi
sono presenti tutte le fasi di questa lunga e storica seduta»32. Tuttavia,
nella sua testimonianza al processo di Verona, Biggini, ministro
dell’Educazione nazionale nella Repubblica sociale, non fu in grado di
precisare la successione degli interventi. E non risulta che abbia redatto
un resoconto della seduta.
Un decennio più tardi, Gaetano Polverelli, membro del Gran Consiglio
dal maggio 1943, rievocando l’ultima seduta scrisse: «Per la seduta del 24
luglio, Mussolini non volle stenografi. Fui solo io a prendere appunti su
un taccuino, che conservai»33.
In verità, Biggini e Polverelli non furono i soli a prendere appunti
durante l’ultima seduta del Gran Consiglio. Lo fecero anche Bottai,
Galbiati, Federzoni e De Marsico, che nei loro libri di memorie diedero
la loro versione su quanto era stato detto nella notte del Gran Consiglio,
con citazioni più o meno ampie degli interventi dei vari oratori, a
cominciare da quello del duce34.
Anche il duce prese appunti
Il 1° luglio 1944 fu pubblicato sul «Corriere della Sera» un articolo di
Mussolini che raccontava in terza persona la riunione del Gran Consiglio,
iniziando col citare parti della sua esposizione, dopo aver premesso che i
punti essenziali «furono raccolti da uno degli astanti», ma senza precisare
di chi si trattasse. Si può presumere che fosse Scorza, il quale, in quanto
segretario del partito fascista, era di diritto il segretario del Gran
Consiglio35.
Infatti, nel libro La notte del Gran Consiglio, pubblicato nel 1968, Scorza
racconta che il duce, prima di recarsi nella sala dove era riunito il Gran
Consiglio, gli disse: «Sono le cinque. Andiamo. Come vi ho detto
stamani: attenzione a tutti, ma soprattutto molta calma. Prenderete gli
appunti sulle varie relazioni; poi li completeremo domattina insieme». E
sorridendo aggiunse: «Ho ancora una memoria di ferro»36. Dopo la
seduta, Scorza racconta di aver accompagnato il duce a Villa Torlonia
dove gli consegnò gli appunti che aveva preso durante la seduta.
Il duce stesso aveva preso appunti, se la mattina del 25 luglio, a Palazzo
Venezia, disse a Scorza, secondo quanto questi riferisce nel suo libro:
«Eccovi i vostri appunti sulla seduta. Coincidono quasi in tutto con i
miei. Vi do anche questi: completate il tutto, con ciò che riguarda anche
gli altri membri»37. E Scorza continua affermando di aver provveduto nel
corso della tarda mattinata del 25 luglio:
Ripresi il mio lavoro sulla seduta del Gran Consiglio preoccupandomi soprattutto di fissare i vari
interventi del Duce. Gli appunti che egli mi aveva fornito coincidevano coi miei e li completavano.
Erano fissati in certi mezzi fogli protocollo tagliati per il lungo, con una grafia da non dirsi. Nel
pomeriggio speravo di presentargli un riassunto quasi completo38.
Che fine abbiano fatti gli appunti di Scorza e del duce, nulla si sa,
almeno finora. Nel libro sulla «notte del Gran Consiglio», e nel successivo
libro di memorie pubblicato nel 1983 Mussolini tradito, Scorza non ha dato
alcun ragguaglio sulla provenienza del materiale documentario citato nei
suoi libri e sulla sorte degli appunti del duce e suoi. Il magistrato
Vincenzo Cersosimo, giudice istruttore del Tribunale straordinario
speciale che processò per tradimento i firmatari dell’ordine del giorno
Grandi, nel suo libro sul processo di Verona, scritto nel 1949 ma
pubblicato nel 1961, ha raccontato che all’inizio la sua attività istruttoria si
preoccupò di recuperare la documentazione sull’ultima seduta del Gran
Consiglio:
Mia prima cura fu di ricercare affannosamente gli atti, gli appunti, i documenti, il verbale della
famosa seduta del Gran Consiglio onde poter illuminare il Tribunale su circostanze di fatto e di
diritto sì da metterlo in grado di poter, con sicura coscienza, affermare od escludere la
responsabilità dei giudicabili: non riuscii a trovare niente. Volli avere un colloquio con Scorza,
allora detenuto nelle carceri di Padova: mi dichiarò che tutti i documenti e note della seduta erano
stati portati via personalmente da Mussolini a Villa Torlonia. Nessuno era in grado di dirmi dove
erano andati a finire. Mi rivolsi a Buffarini, e questi mi assicurò che tutte le carte erano state
distrutte nel pomeriggio del 25 luglio quando si cominciarono a nutrire serie preoccupazioni per il
mancato ritorno di Mussolini dall’udienza reale39.
Tuttavia, pur «essendo stati distrutti gli atti inerenti alla seduta»,
Cersosimo cercò di ricostruire «in tutte le loro fasi gli eventi che hanno
determinato la convocazione del Gran Consiglio, il modo come si è svolta
la seduta, la votazione dell’ordine del giorno Grandi». E lo fece
avvalendosi delle deposizioni che nel corso del processo avevano rilasciato
sia gli imputati Ciano, Marinelli, Cianetti, Pareschi, Gottardi e De Bono;
sia i testimoni Buffarini Guidi, Galbiati, Biggini, Frattari, Scorza, Suardo
e Farinacci. Cersosimo si avvalse anche dei memoriali che, dopo la
liberazione di Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso e la costituzione
della Repubblica sociale, Alfieri e Bastianini avevano inviato al duce, e
quello che Bignardi aveva fatto pervenire al segretario del partito fascista
repubblicano Alessandro Pavolini, per discolparsi dall’accusa di
tradimento.
Le deposizioni degli imputati e dei testimoni, come pure i memoriali
degli altri tre ex membri del Gran Consiglio, contenevano un racconto
sommario su come si era svolta l’ultima seduta, anche se ogni racconto
era svolto per giustificare il personale contegno da loro avuto in Gran
Consiglio e il motivo del loro voto. Il proposito della giustificazione era
ovviamente più marcato nei racconti degli imputati, i quali cercarono
tutti di dimostrare che il loro voto a favore dell’ordine del giorno Grandi
non mirava a estromettere il duce del potere e a provocare il crollo del
regime, ma che tutti votarono convinti che Mussolini stesso, in fondo, lo
approvasse, perché durante l’intera seduta non manifestò mai la sua
opposizione né si mostrò risoluto a contrastarlo, persuadendo gli incerti e
gli indecisi a non votarlo. Il fatto che avesse deciso di porre in votazione
per primo l’ordine del giorno Grandi, invece che quello del segretario del
partito, era la prova, per gli imputati di Verona, che il duce non lo
considerava affatto un grave pericolo per il regime.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :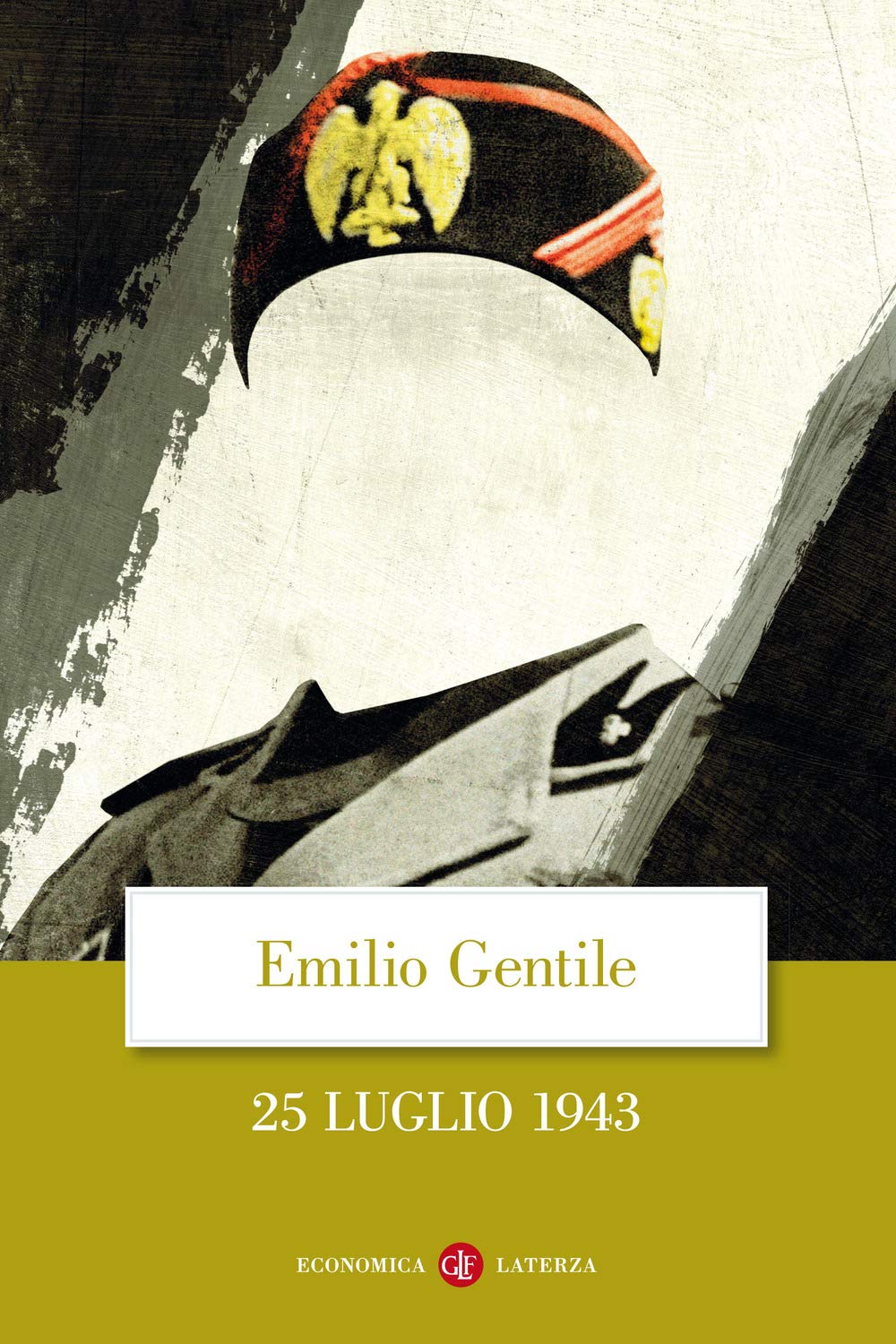






Commento all'articolo