Verità sepolte – Allen Eskens
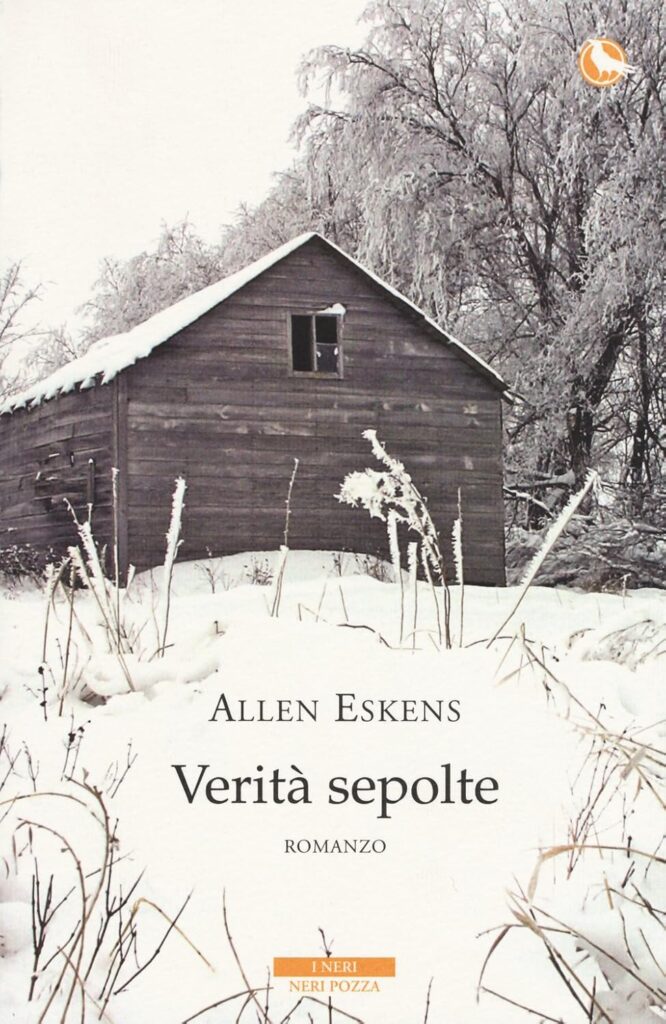
SINTESI DEL LIBRO:
Ricordo che quel giorno, mentre mi avviavo verso l’auto, fui assalito da un
senso di timore, da un presagio che, come un’onda, mi turbinava in testa
prima di infrangersi in piccole increspature nell’aria serale. Certa gente
non esiterebbe a parlare di premonizione, di un avvertimento lanciato da
un terzo occhio interiore capace di vedere oltre la curva del tempo. Io non
ci ho mai creduto. Confesso, però, che certe volte ripenso a quel giorno e
mi chiedo: se il fato mi avesse davvero parlato all’orecchio – se avessi
saputo quante cose avrebbe cambiato quel viaggio in auto – avrei scelto
un tragio più sicuro? Avrei girato a destra invece che a sinistra? O avrei
imboccato ugualmente la strada che mi avrebbe condoo da Carl Iverson?
ella fredda sera di seembre, i miei Minnesota Twins avrebbero
sfidato i Cleveland Indians, una partita in cui si giocavano il primo posto
nella Central Division. Entro breve le luci del Target Field avrebbero
inondato l’orizzonte occidentale di Minneapolis, squarciando il cielo come
raggi di gloria, ma io non avrei assistito allo speacolo. Uno dei tanti
piaceri che il mio modesto budget di studente universitario mi precludeva.
Avrei invece lavorato all’ingresso del Molly’s Pub, cercando di carpire
qualche immagine della partita dal televisore sopra il bar mentre
controllavo i documenti di identità e calmavo i litigi tra ubriachi; non era
il lavoro dei miei sogni, ma mi consentiva di pagare l’affio.
Chissà perché, la consulente di orientamento del mio liceo non aveva
mai pronunciato la parola «università» nel corso dei nostri incontri. Forse
sentiva l’odore dell’assenza di prospeive che emanava dai miei vestiti di
seconda mano. Forse aveva saputo che avevo iniziato a lavorare in una
beola chiamata Piedmont Club il giorno dopo il mio dicioesimo
compleanno. Oppure – e ci scommeerei che la ragione era questa
sapeva chi era mia madre e aveva deciso che buon sangue non mente.
Deo questo, non me la presi se non vide in me alcuna possibilità di
raggiungere la laurea. Era vero che mi sentivo più a mio agio nello
squallore di un bar che nelle aule col pavimento di marmo dell’ateneo,
dove inciampavo come se mi fossi infilato le scarpe nel piede sbagliato.
el giorno salii in macchina – una Honda Accord arrugginita vecchia
di vent’anni – ingranai la marcia e uscii dal campus verso sud, infilandomi
nel traffico dell’ora di punta sulla I-35 e ascoltando Alicia Keys dagli
altoparlanti giapponesi ormai allo stremo. Arrivando a Crosstown,
allungai la mano a destra, mi misi a frugare nello zaino sul sedile del
passeggero e ne estrassi il foglieo con l’indirizzo dell’ospizio. «Non
chiamarlo ospizio» mi redarguii borboando. «È una casa di riposo, una
residenza per anziani o qualcosa del genere».
Percorsi, rischiando di perdermi, le strade del sobborgo di Richfield, e
trovai infine il cartello all’entrata di Hillview Manor, la mia destinazione. Il
nome pareva uno scherzo: la “tenuta affacciata sulle colline”, come
sembrava suggerire la denominazione, non offriva alcun panorama su
alcuna collina, e anche la maestosità della “tenuta” era del tuo assente.
Dalla facciata dell’edificio si poteva invece ammirare il traffico intenso di
un viale a quaro corsie, mentre il retro offriva uno scorcio su un vecchio
condominio in rovina. el nome assurdo, però, doveva essere stato
l’aspeo più allegro di Hillview Manor, considerando le sue pareti di
maoni grigi striate di muschio verde, gli arbusti morenti che nessuno
curava e la muffa color verderame sul riquadro di ogni finestra a
ghiglioina. La struura premeva, solida e compaa, sulle fondamenta
come un giocatore di football che placca un avversario, e sembrava
altreanto poderosa.
Non appena varcai la soglia fui assalito da un’ondata di aria stantia,
dall’odore acre di crema antiseica e urina, che mi fece venire le lacrime
agli occhi. Una vecchia con una parrucca di traverso sedeva su una sedia a
rotelle, lo sguardo fisso su un punto alle mie spalle; sembrava aspeare
che un corteggiatore del passato emergesse dal parcheggio per portarla via
con sé. Sorrise al mio passaggio, ma non a me. Non esistevo nel suo
mondo, proprio come i fantasmi della sua memoria non esistevano nel
mio.
Mi fermai un aimo prima di avvicinarmi alla reception, ascoltando per
l’ultima volta quei ripensamenti che mi ronzavano nelle orecchie, pensieri
petulanti che suggerivano di mollare il corso di inglese prima che fosse
troppo tardi, e di sostituirlo con qualcosa di più utile, come geologia o
storia.
Un mese prima me n’ero andato dalla mia casa di Austin, in Minnesota,
defilandomi come un ragazzino che scappa per unirsi a un circo. Nessuna
discussione con mia madre, nessuna speranza, per lei, di farmi cambiare
idea. Avevo fao i bagagli, deo a mio fratello minore che me ne andavo, e
lasciato un biglieo per la mamma. ando mi ero presentato in
segreteria, all’università, tui i migliori corsi di inglese erano già al
completo, così mi ero iscrio a un corso dedicato alle biografie, per il
quale avrei dovuto intervistare una persona a me sconosciuta. Sapevo
bene, in realtà, che il sudore freddo che mi imperlava le tempie mentre
aspeavo nell’atrio veniva da quel compito troppo a lungo rimandato. Lo
sapevo, lo sentivo che sarebbe stato un incubo.
La receptionist di Hillview, una donna dal viso quadrato con la
mascella prominente, i capelli tirati indietro e gli occhi infossati che la
facevano sembrare la direrice di un gulag, si sporse da dietro il banco e
chiese: «Posso aiutarla?»
«Sì» risposi. «Lo spero, almeno. C’è l’amministratore?»
«Non acceiamo proposte commerciali» mise subito in chiaro la
donna, adoando un’espressione fredda e osservandomi meglio.
«Proposte commerciali?» Feci una risatina forzata e tesi le mani in un
gesto implorante. «Signora» le feci notare. «Non riuscirei a vendere
neanche il fuoco a un cavernicolo».
«Non abita qui, non è un visitatore e non lavora certo da queste parti.
Cos’altro rimane?»
«Mi chiamo Joe Talbert. Sono uno studente all’università del
Minnesota».
«E allora?»
Lanciai un’occhiata alla sua targhea col nome. «Ecco… Janet… vorrei
parlare con l’amministratore per un mio progeo».
«Non abbiamo un amministratore» disse Janet, continuando a
guardarmi storto. «C’è una direrice, la signora Lorngren».
«Oh, mi scusi» dissi, cercando di conservare la mia facciata gradevole.
«Posso parlare con la direrice, allora?»
«La signora Lorngren è molto impegnata, ed è ora di cena».
«Ci vorrà solo un minuto».
«Perché non parla a me del suo progeo, così vedo se è il caso di
disturbarla?»
«Si traa di un compito che mi è stato assegnato per un corso di
inglese» spiegai. «Devo intervistare un vecchio, una persona anziana
intendevo dire, e scrivere la sua biografia. Sa, raccontare tue le difficoltà
che ha incontrato, le scelte che lo hanno portato a diventare la persona
che è oggi».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :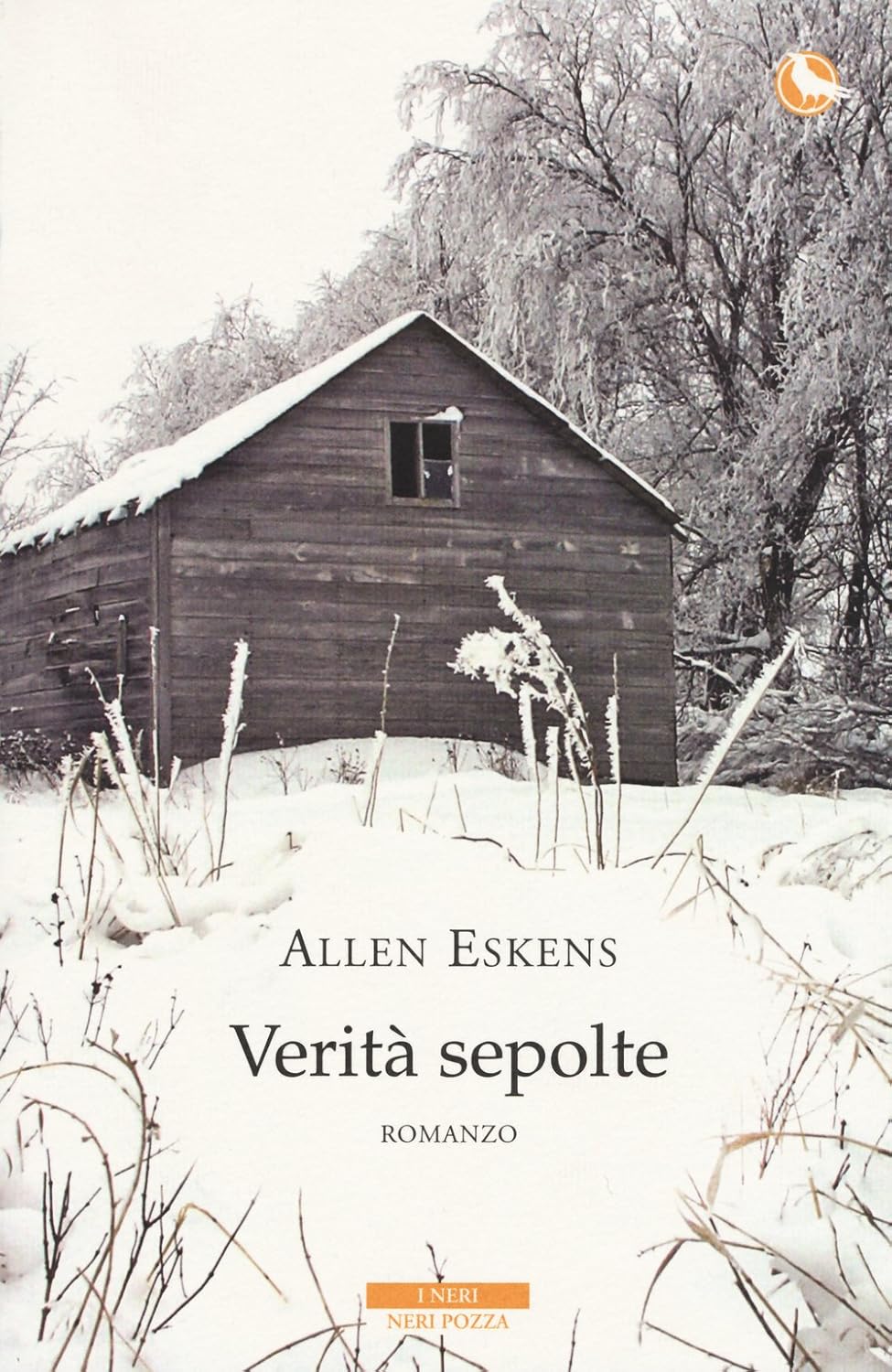






Commento all'articolo