Un’estate con Omero – Sylvain Tesson
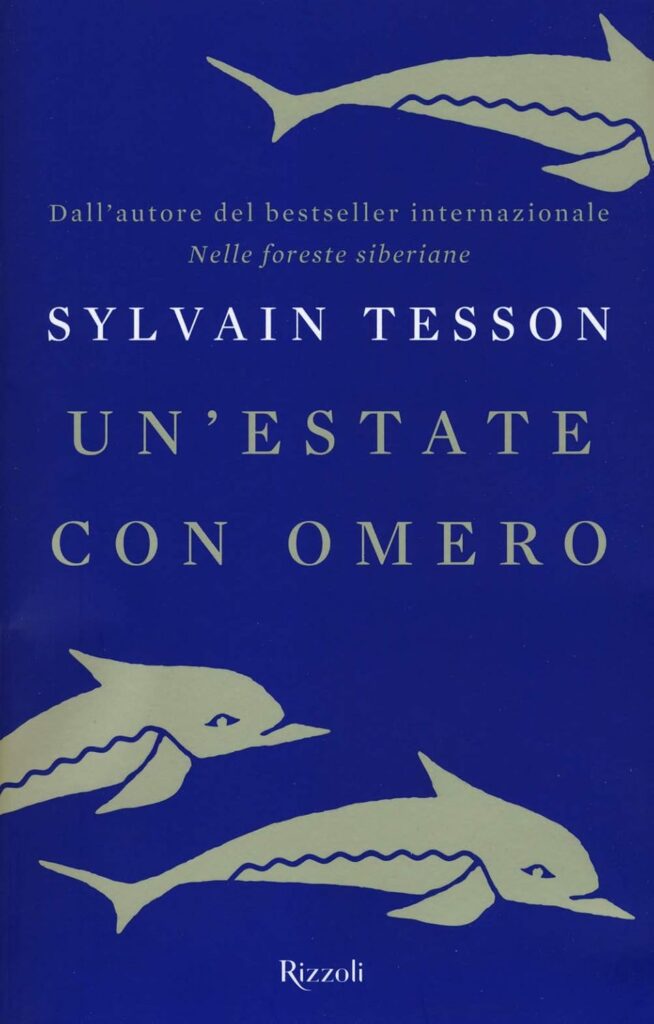
SINTESI DEL LIBRO:
L’Iliade è il racconto della guerra di Troia, l’Odissea del ritorno di Ulisse
nel suo regno, a Itaca. L’una descrive l’imperversare della battaglia, l’altra
la restaurazione dell’ordine. Entrambe tratteggiano, con incredibile
precisione, la condizione umana. A Troia, l’assalto delle masse inferocite,
plagiate dagli dei. Nell’Odissea, Ulisse che, navigando tra le isole, trova
infine la via di fuga. Tra i due poemi c’è una violenta oscillazione: da un
lato, la maledizione della guerra, dall’altro, l’agognato ritorno a casa;
l’epopea eroica contro l’avventura interiore.
Questi testi hanno cristallizzato miti che venivano trasmessi dagli aedi
ai popoli dei regni micenei e della Grecia arcaica oltre duemila anni fa. A
noi sembrano strani, spaventosi persino. Sono popolati di creature
terrificanti, maghe dal fascino letale, eserciti sgominati, amicizie
indissolubili, spose sacrificali e guerrieri adirati. Le tempeste infuriano, le
mura crollano, gli dei fanno l’amore, le regine si sciolgono in singhiozzi, i
soldati si asciugano le lacrime sulle tuniche insanguinate, gli uomini si
massacrano. Poi una scena tenera mette fine all’abominio: le carezze
fermano la sete di vendetta.
Prepariamoci: attraverseremo mari e campi di battaglia. Saremo gettati
nella mischia, invitati a presenziare all’assemblea degli dei. Saremo travolti
da tempeste e fasci di luce, sprofonderemo nella nebbia, penetreremo nelle
alcove, approderemo sulle isole, ci inerpicheremo sulle scogliere.
Tanti uomini morderanno la terra e moriranno. Altri si salveranno. Tutto
sotto lo sguardo degli dei. Il sole splenderà sempre per illuminare la
bellezza mischiata alla tragedia. I protagonisti si affanneranno per portare a
termine le imprese, ma dietro ognuno di loro ci sarà un dio che muove le
proprie pedine. L’uomo sceglierà liberamente il suo destino o dovrà
sottostare al fato? È solo un burattino o una creatura sovrana?
Isole, promontori e regni sono la cornice di questi poemi. Negli anni
Venti il geografo Victor Bérard ne ha effettuato una precisa localizzazione.
Dal mare nostrum è sgorgata una delle sorgenti della nostra Europa, figlia
di Atene quanto di Gerusalemme.
Da dove vengono questi canti, emersi dagli abissi e proiettati verso
l’eterno? Perché, alle nostre orecchie, suonano ben noti? Come si spiega
che un racconto antico di svariati secoli abbia conservato una luce tanto
vivida, come lo scintillio di una calanca? Perché questi versi immortali sono
ancora in grado di svelarci l’enigma del nostro domani?
Perché gli dei e gli eroi che li popolano ci sembrano così affini?
I protagonisti dei canti omerici vivono ancora in noi. Il loro coraggio ci
affascina. Le loro passioni ci sono familiari. Le loro avventure hanno
coniato espressioni che ancora utilizziamo. Atena, Achille, Aiace, Ettore,
Ulisse ed Elena sono nostri fratelli e sorelle che si sono guadagnati
l’eternità. Le loro epopee hanno generato noi europei, il nostro comune
pensare e sentire. «I Greci hanno civilizzato il mondo» scriveva
Chateaubriand. Omero ci aiuta a vivere.
Possiamo formulare due ipotesi per spiegare il mistero delle sue opere.
O gli dei sono veramente esistiti e hanno insufflato in lui una sorta di
prescienza, ispirandogli le proprie agiografie. I suoi versi premonitori
sarebbero stati dunque destinati ad arrivare fino a noi. Oppure i temi che
attraversano i poemi omerici – la guerra e la gloria, la grandezza e la
dolcezza, la paura e la bellezza, la memoria e la morte – sono il
combustibile del braciere dell’eterno ritorno.
Io credo in questo: nell’immutabilità dell’uomo. I sociologi moderni
sono persuasi che l’uomo sia «perfettibile», che il progresso lo faccia
avanzare, che la scienza lo migliori. Sciocchezze: i poemi omerici sono
immarcescibili perché l’uomo, pur cambiando nell’aspetto e nelle vesti,
resta sempre lo stesso: è ugualmente miserabile o grandioso, mediocre o
sublime, sia che indossi l’elmo sulla piana di Troia o che aspetti l’autobus
sul marciapiede di una città del Ventunesimo secolo.
All’istante
Vi ricordate quando, da adolescenti, ci obbligavano a leggere questi testi
antichi? I poemi omerici erano parte del programma sui banchi di scuola. A
quell’età, però, a noi piaceva correre all’aperto. Durante le lezioni ci
annoiavamo e passavamo il tempo a guardare fuori dalla finestra, fissando
un cielo nel quale il Carro non appariva mai. Perché non eravamo capaci di
lasciarci travolgere da quei poemi dorati, eterni proprio perché primigeni,
da quel canto potente e fragoroso, carico di insegnamenti e di una bellezza
così dolorosa che ancora oggi ci commuove nel profondo?
Un consiglio dadaista: abbandoniamo le nostre futili preoccupazioni!
Rimandiamo a domani i piatti da lavare, spegniamo computer e cellulari,
lasciamo piangere i bambini e apriamo senza indugio l’Iliade e l’Odissea
per leggerne qualche passaggio ad alta voce, seduti di fronte al mare,
davanti a una finestra, in cima a una montagna. Lasciamo entrare in noi i
loro canti sublimi e sovrumani: ci aiuteranno a diradare la nebbia del nostro
tempo.
Secoli orribili si annunciano. Tra non molto, i droni sorveglieranno un
cielo saturo di biossido, sistemi automatizzati controlleranno le nostre
identità biometriche e sarà proibito rivendicare una propria specificità
culturale. Dieci miliardi di esseri umani connessi gli uni agli altri potranno
spiarsi a vicenda in ogni momento. Lucrando sulla chirurgia genetica, le
multinazionali del settore ci offriranno la possibilità di vivere qualche
decennio in più.
Omero, vecchio compagno dell’oggi, può scacciare questo incubo
postumanista. Ci mostra una possibile condotta: quella di un uomo che si
muove in una realtà mutevole e non «aumentata», anzi su un pianeta
rimpicciolito.
Omero, nostro padre
Quindicimila versi l’Iliade, dodicimila l’Odissea: ha davvero senso scrivere
ancora?
Così come le pitture parietali delle grotte di Lascaux avrebbero potuto
mettere il punto alla produzione pittorica, l’Iliade e l’Odissea avrebbero
dovuto porre fine alla creazione letteraria. I due poemi omerici inaugurano
l’età della letteratura e concludono il ciclo della modernità.
Nei loro esametri c’è tutto: la magnificenza e la meschinità, il peso
dell’essere, i grandi temi del destino e della libertà, il dilemma tra una vita
pacifica e la gloria eterna, tra la misura e l’eccesso, la dolcezza della natura,
la forza dell’immaginazione, la grandezza della virtù e la fragilità della
vita...
E l’uomo che ha sganciato queste «bombe» poetiche è ancora avvolto
dal mistero.
Chi era Omero? Come ha potuto un solo uomo produrre un ordigno
simile? La domanda ha appassionato Nietzsche e gli studiosi ne dibattono
ancora. La questione è molto sentita al giorno d’oggi, in cui ci si appassiona
facilmente alle vite dei personaggi noti. Ogni epoca, del resto, riconduce i
capolavori del genio alla propria ottica e alla propria visione del mondo e il
nostro secolo egualitarista è profondamente interessato alle rivendicazioni
dell’ego.
Ma è Omero stesso a spazzare via ogni dubbio. Fin dall’esordio
dell’Odissea invoca la «Musa», la dea della memoria che racconterà la
storia, mentre lui, il poeta, si limiterà a raccogliere il nettare della sua
melodia. A che pro dunque indagare sullo scriba, se i suoi versi nascono
dalla bocca di una divinità?
Dell’uomo, dimmi o Musa, molto versatile, che molte volte
fu sbattuto fuori rotta, dopo che di Troia la sacra rocca distrusse,
e di molti uomini le città vide e l’intendimento conobbe
e molti patimenti, lui, sul mare ebbe a soffrire nell’animo suo,
cercando salvezza di vita e il ritorno per sé e per i compagni;
ma anche così i compagni non li salvò, pur desiderandolo.
Fu per le loro stesse scelleratezze che essi perirono,
puerilmente stolti, essi che le vacche del Sole Iperione
mangiarono, e quello allora tolse loro il giorno del ritorno.
Di ciò, iniziando da qualche punto, dea figlia di Zeus, di’ anche a noi.
(Odissea, I, 1-10)
Omero sarebbe vissuto nell’Ottavo secolo a.C. «Quattrocento anni prima di
me» sosteneva Erodoto. La sua, dunque, non è una testimonianza diretta
della guerra di Troia, di cui narra l’Iliade, che ebbe luogo intorno al 1200
a.C. Queste datazioni sono desunte dagli scavi effettuati nelle steppe
dell’Asia Minore da un bizzarro archeologo tedesco che ha ispirato
l’Indiana Jones di Steven Spielberg: Heinrich Schliemann. La civiltà
micenea si era sviluppata dal 1600 al 1200 a.C., poi era scomparsa.
Sarebbero intercorsi dunque quattrocento anni di trasmissione orale, di
ricordi, leggende ed epopee prima che un tale di nome Omero prendesse
l’iniziativa di ricomporre quei materiali in un poema. Vi sono tre ipotesi al
riguardo.
La prima è che un puro genio, un uomo barbuto e cieco, si sia inventato
tutto ex nihilo, quattrocento anni dopo la guerra di Troia. Questo creatore
ineguagliabile, demiurgo e al tempo stesso creatura mitologica, avrebbe
«scoperto» la letteratura proprio come è stato scoperto il fuoco.
Nella seconda ipotesi, Omero sarebbe il nome dato a un gruppo di
rapsodi, bardi e poeti. Questo genere di narratori, capaci di improvvisare
lunghi poemi epici, ha percorso fino a tempi relativamente recenti le rive
dell’Egeo e i Balcani. Oggi li definiremmo un «collettivo di artisti». Nel
corso dei secoli avrebbero riunito numerose tradizioni in un testo,
arricchendolo di dettagli e vezzi letterari. L’Iliade e l’Odissea sarebbero il
risultato di questo mosaico, il frutto della sistemazione del patrimonio orale.
Le svariate aggiunte proverrebbero dalle interpolazioni degli autori.
Infine – ed è questa la tesi della filologa e scrittrice francese
naturalizzata greca Jacqueline de Romilly – la verità potrebbe trovarsi nel
mezzo. Omero sarebbe stato il grande «rammendatore»: avrebbe catturato i
racconti della tradizione nella propria rete e poi li avrebbe messi insieme in
uno stile unico e personale. Pensiamo, per analogia, a Brahms, che
ricompone le danze popolari magiare armonizzandole con il patrimonio
classico. Omero sarebbe stato l’alchimista che raccoglie in un unico
calderone molteplici fonti. E non avrebbe esitato a mescolare fatti ed
episodi anche di epoche tra loro differenti. Cos’è in fondo l’ispirazione se
non questo?
Che la fonte sia stata una o più d’una, il testo sarebbe nato nell’epoca in
cui i Greci si ispirarono all’alfabeto fenicio e recuperarono l’uso della
scrittura, scomparsa durante i «secoli bui» che seguirono il crollo di
Micene. Gli studiosi dibattono ancora per stabilire se l’Iliade e l’Odissea
siano figlie dell’epoca micenea oppure dell’età oscura, durante la quale i
popoli indoeuropei si sparpagliarono sugli arcipelaghi del Mar Egeo.
Sottigliezze: Omero è innanzitutto il nome del miracolo che ha concesso
all’umanità di fissarsi nella memoria una riflessione sulla propria
condizione.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :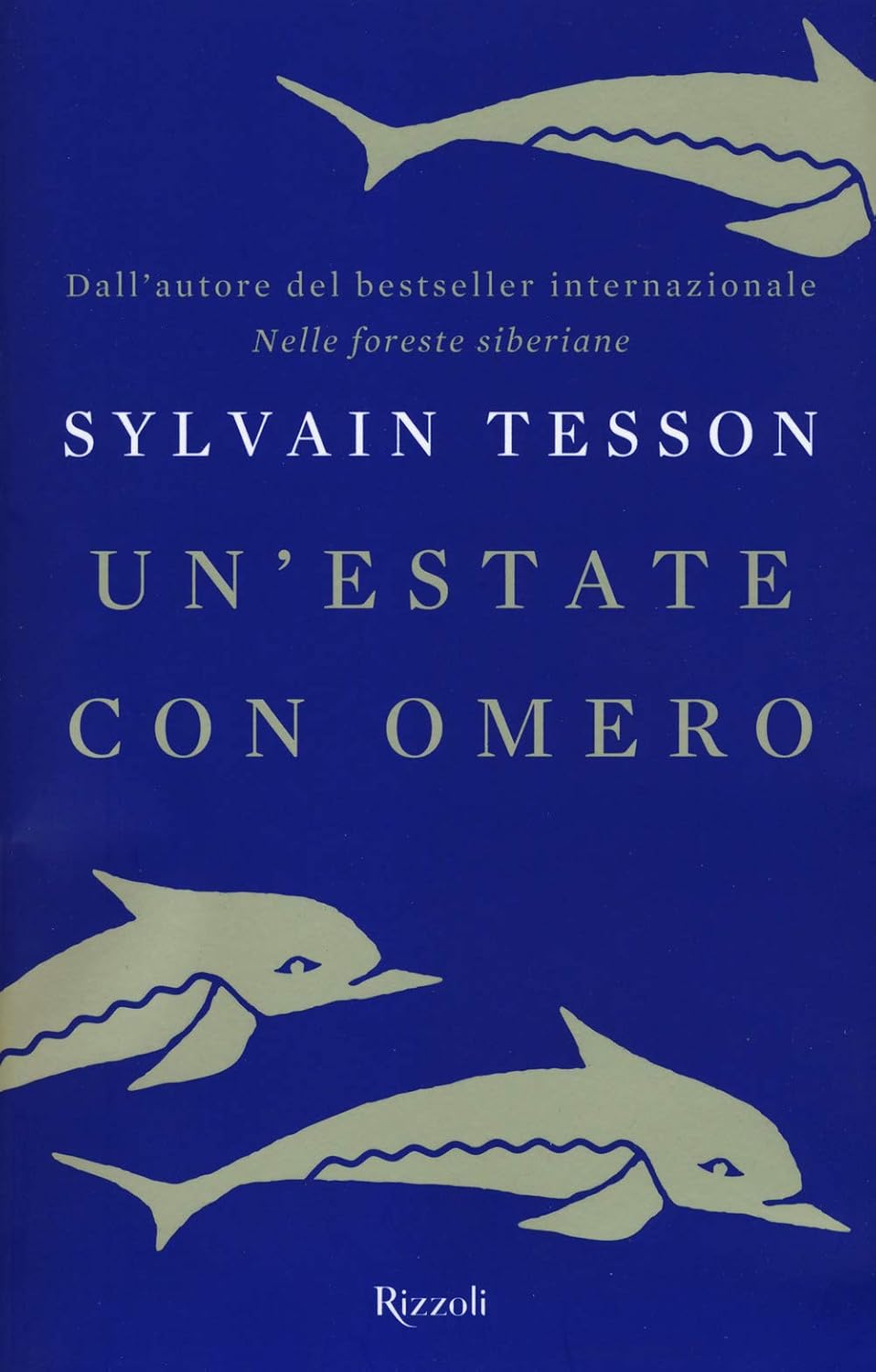






Commento all'articolo