Una donna – Sibilla Aleramo

SINTESI DEL LIBRO:
La mia fanciullezza fu libera e gagliarda. Risuscitarla nel ricordo,
farla riscintillare dinanzi alla mia coscienza, è un vano sforzo. Rivedo
la bambina ch’io ero a sei, a dieci anni, ma come se l’avessi
sognata. Un sogno bello, che il menomo richiamo della realtà
presente può far dileguare. Una musica, fors’anche: un’armonia
delicata e vibrante, e una luce che l’avvolge, e la gioia ancora
grande nel ricordo.
Per tanto tempo, nell’epoca buia della mia vita, ho guardato a quella
mia alba come a qualcosa di perfetto, come alla vera felicità. Ora,
cogli occhi meno ansiosi, distinguo anche ne’ primissimi anni
qualche ombra vaga e sento che già da bimba non dovetti mai
credermi interamente felice. Non mai disgraziata, neppure; libera e
forte, sì, questo dovevo sentirlo. Ero la figliola maggiore, esercitavo
senza timori la mia prepotenza sulle due sorelline e sul fratello: mio
padre dimostrava di preferirmi, e capivo il suo proposito di crescermi
sempre migliore. Io avevo salute, grazia, intelligenza — mi si diceva
— e giocattoli, dolci, libri, e un pezzetto di giardino mio. La mamma
non si opponeva mai a’ miei desideri. Perfino le amiche mi erano
soggette spontaneamente.
L’amore per mio padre mi dominava unico. Alla mamma volevo
bene, ma per il babbo avevo un’adorazione illimitata; e di questa
differenza mi rendevo conto, senza osar di cercarne le cause. Era lui
il
luminoso esemplare per la mia piccola individualità, lui che mi
rappresentava la bellezza della vita: un istinto mi faceva ritenere
provvidenziale il suo fascino. Nessuno gli somigliava: egli sapeva
tutto e aveva sempre ragione. Accanto a lui, la mia mano nella sua
per ore e ore, noi due soli camminando per la città o fuori le mura, mi
sentivo lieve, come al di sopra di tutto. Egli mi parlava dei nonni,
morti poco dopo la mia nascita, della sua infanzia, delle sue imprese
fanciullesche meravigliose, e dei soldati francesi ch’egli, a otto anni,
aveva visto arrivare nella sua Torino, “quando l’Italia non c’era
ancora.” Un tale passato aveva del fantastico. Ed egli m’era accanto,
con l’alta figura snella, dai movimenti rapidi, la testa fiera ed eretta, il
sorriso trionfante di giovinezza. In quei momenti il domani mi
appariva pieno di promesse avventurose.
Il babbo dirigeva i miei studi e le mie letture, senza esigere da me
molti sforzi. Le maestre, quando venivano a trovarci a casa, lo
ascoltavano con meraviglia e talvolta, mi pareva, con profonda
deferenza. A scuola ero tra le prime, e spesso avevo il dubbio
d’avere un privilegio. Sin dalle classi inferiori, notando la differenza
dei vestiti e delle refezioni, m’ero potuto formare un concetto di quel
che dovevano essere molte famiglie delle mie compagne: famiglie
d’operai gravate dalla fatica, o di bottegai grossolani. Rientrando in
casa guardavo sull’uscio la targhetta lucente ove il nome di mio
padre era preceduto da un titolo. Non avevo che cinque anni
allorché il babbo, che insegnava scienze nella cittaduzza ov’ero
nata, s’era dimesso in un giorno d’irritazione e s’era unito con un
cognato di Milano, proprietario d’una grossa casa commerciale. Io
capivo che egli non doveva sentirsi troppo contento della sua nuova
situazione. Quando lo vedevo, in qualche pomeriggio libero, entrare
nello stanzino ov’erano raccolti un poco in disordine alcuni
apparecchi per esperienze di fisica e di chimica, comprendevo che là
soltanto si trovava a suo agio. E quante cose mi avrebbe insegnato il
babbo!
Senz’essere impaziente, la mia curiosità dava un sapore acuto
all’esistenza. Non m’annoiavo mai. Spesso rifiutavo d’accompagnar
la mamma a qualche visita e restavo a casa, sprofondata in un gran
seggiolone, a leggere i libri più disparati, sovente incomprensibili per
me, ma dei quali alcuni mi procuravano una specie d’ebbrezza
dell’immaginazione e mi astraevano completamente da me stessa.
Se m’interrompevo, era per formular pensieri confusi; e lo facevo
talora a voce sommessa, come scandendo dei versi che una voce
interiore mi suggerisse. Arrossivo; come arrossivo di certe pose
languide che assumevo nella stessa poltrona, quando mi accadeva
per un attimo di trasportarmi colla fantasia nei panni d’una bella
dama piena di seduzioni. Potevo distinguere tra affettazione e
spontaneità? Mio padre giudicava con una indifferenza un poco
sprezzante ogni manifestazione di pura poesia: diceva di non
capirla: la mamma, sì, ripeteva ogni tanto qualche strofa carezzevole
e nostalgica, o modulava colla voce appassionata spunti di vecchie
romanze; ma sempre quando il babbo non c’era. E sempre io ero
disposta a credere che mio padre avesse ragione più di lei.
Ciò anche quando egli prorompeva in una di quelle crisi di collera
che ci facevan tremar tutti e mi piombavano in uno stato d’angoscia,
rapido, ma indicibile. La mamma reprimeva le lagrime, si rifugiava in
camera. Sovente, dinanzi al babbo, ella aveva un’espressione
umiliata, leggermente sbigottita: e non solo per me, ma anche pei
bambini, tutta l’idea d’autorità si concentrava nella persona paterna.
Diverbi gravi tuttavia non avvenivano fra loro due in nostra presenza:
qualche parola acre, qualche rimprovero secco, qualche recisa
ingiunzione; al più il babbo si abbandonava al proprio temperamento
di fuoco per qualche disavvedutezza delle persone di servizio, per
qualche capriccio nostro: ma di tutto appariva responsabile la
mamma, che reclinava il capo come se fosse colpita all’improvviso
da una grande stanchezza, o sorrideva, d’un certo sorriso che non
potevo sostenere, perché deformava la bella bocca rassegnata.
Si rivolgeva ella in quel punto a visioni del passato?
Non rievocava quasi mai davanti a me la sua fanciullezza, la sua
gioventù; dal poco che avevo sentito, però, avevo potuto
formarmene una visione assai meno interessante di quella suscitata
dai ricordi di mio padre. Ella era nata in un ambiente modestissimo
d’impiegati, e, come la mia nonna paterna, sua madre aveva avuto
molti figliuoli, di cui la maggior parte viveva sparsa pel mondo.
Doveva esser cresciuta fra le strettezze, poco amata. Cenerentola
della casa. A vent’anni, ad una festicciuola da ballo, s’era incontrata
col babbo. Ella mi mostrava il ritratto del giovinetto imberbe che mio
padre era stato allora: fattezze ancor da fanciullo, dolci, regolari, fra
cui gli occhi soli esprimevano già un’energia ferrea: egli faceva il
penultimo anno di Università. Appena prese la laurea, aveva
ottenuto una cattedra e s’erano sposati.
Quand’io ero nata, l’anno non era ancor compiuto dal dì delle nozze.
La mamma s’illuminava nel volto bianco e puro le rarissime volte che
accennava alle due stanzine coi mobili a nolo dei primi mesi di vita
coniugale. Perché non era sempre così animata? Perché era così
facile al pianto, mentre mio padre non poteva sopportare la vista
delle lacrime, e perché mostrava opinioni diverse tanto spesso da
quelle di lui, quando osava esprimerle? Perché, anche, era così
poco temuta da noi bambini, e così poco ubbidita? Come il babbo,
anch’ella cedeva talvolta a momenti di collera; ma sembrava, allora,
che rompesse in un singhiozzo troppo a lungo frenato… Io avevo la
sensazione che lo sfogo, anche eccessivo, di mio padre, fosse
naturale sempre, inerente al suo temperamento; nella mamma
invece gli scoppi di malumore contro i figliuoli o le cameriere
contrastavano dolorosamente colla sua natura dolce; si palesavano
come un eccesso spasmodico di cui ella stessa aveva coscienza,
nell’atto, e rimorso.
Quante volte ho visto brillare per una lagrima trattenuta i begli occhi
profondi e bruni di mia madre! Saliva in me un disagio invincibile,
che non era pietà, non era dolore neppure, e neppure reale
umiliazione, ma piuttosto un oscuro rancore contro l’impossibilità di
reagire, di far che non avvenisse ciò che avveniva. Che cosa? Non
sapevo bene. Verso gli otto anni avevo come lo strano timore di non
possedere una mamma “vera,” una di quelle mamme, dicevano i
miei libri di lettura, che versano sulle figliuolette, col loro amore, una
gioia ineffabile, la certezza della protezione costante. Due, tre anni
dopo, a questo timore succedeva in me la coscienza di non riuscire
ad amar mia madre come il mio cuore avrebbe desiderato. Era
questo, certo, che m’impediva d’indovinare la vera cagione per cui
nella nostra casa si proiettava, perenne, un’ombra indefinibile ad
impedire così spesso la libera fioritura del sorriso. Oh, poter gettarmi
una volta al suo collo con abbandono assoluto, sentirmi capita da lei,
anche prometterle il mio appoggio per quando sarei grande;
stringere un patto di tenerezza, come avevo fatto tacitamente col
babbo da tempo immemorabile!
Ella mi ammirava in silenzio, riportando su me un poco dell’orgoglio
già provato per la balda energia dello sposo; ma non approvava il
metodo d’educazione a cui mi assoggettavo con tanto fervore;
temeva per me, immaginando certo che io crescessi senza
sentimento, ch’io fossi destinata a vivere col solo cervello; e non
aveva il coraggio di contrastare l’opera del babbo.
Ma neppure il babbo cercava di conoscermi per intero. Certe volte
mi sentivo proprio sola. M’avvolgeva allora uno di quegli stupori
meditativi che costituivano il secreto valore della mia esistenza.
Spuntava il pudore dell'anima. Accanto, parallela alla vita esteriore,
una vita occulta a tutti si approfondiva. Ed io avvertivo questo
dualismo. Fin dal primo anno di scuola mi aveva preoccupata il fatto
di due diversi aspetti del mio essere: a scuola tutti mi trovavano
angelica, ed io buona ed esemplare infatti, col visino tranquillo ove
errava sempre un sorriso timido e vivido insieme; appena fuori, nella
strada, sembrava ch’io aprissi tutta l’aria intorno, mi mettevo a
saltare, a parlare a vanvera, e in casa entrava con me il terremoto: i
fratellini cessavano dai loro giuochi placidi, pronti a’ miei cenni
d’autocrate ostinata.
Sopraggiunta l’ora di preparar compiti e lezioni, mi ritiravo nella mia
stanzetta o in un angolo del giardino, e di nuovo non esistevo più per
gli altri, di nuovo afferrata dal gusto dell’applicazione intellettuale, pur
senza alcuna brama di emular compagne o di meritarmi premi. Poi,
la sera, dopo che la mamma m’aveva fatto recitare nel nostro caro
dialetto due parole di preghiera: “Signore, fatemi diventare grande e
brava, a consolazione dei miei genitori” e m’aveva lasciata al buio
nel letto ove mia sorella già dormiva, io provavo una sensazione di
riposo, di benessere, non soltanto fisico, come se in quel momento,
costretta all’oscurità, al silenzio e alla immobilità, fossi più libera che
durante tutta la giornata.
Mi piaceva guardar nelle tenebre; non ne avevo paura, perché il
babbo m’aveva assicurata sin da quando ero piccina che gli orchi e
le streghe delle favole non sono mai esistiti, come non era mai
esistito il “diavolo.” Riandavo con la mente i piccoli casi del giorno:
rivedevo il sorriso seduttore del babbo, un gesto di sconforto delle
mani materne, riprovavo qualche stizza per certe goffaggini de’ miei
minori, mi soffermavo alquanto sulle prospettive del domani: esito
d’esami, viaggetti, libri e giuochi nuovi, amiche e maestre da
conquistare…
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




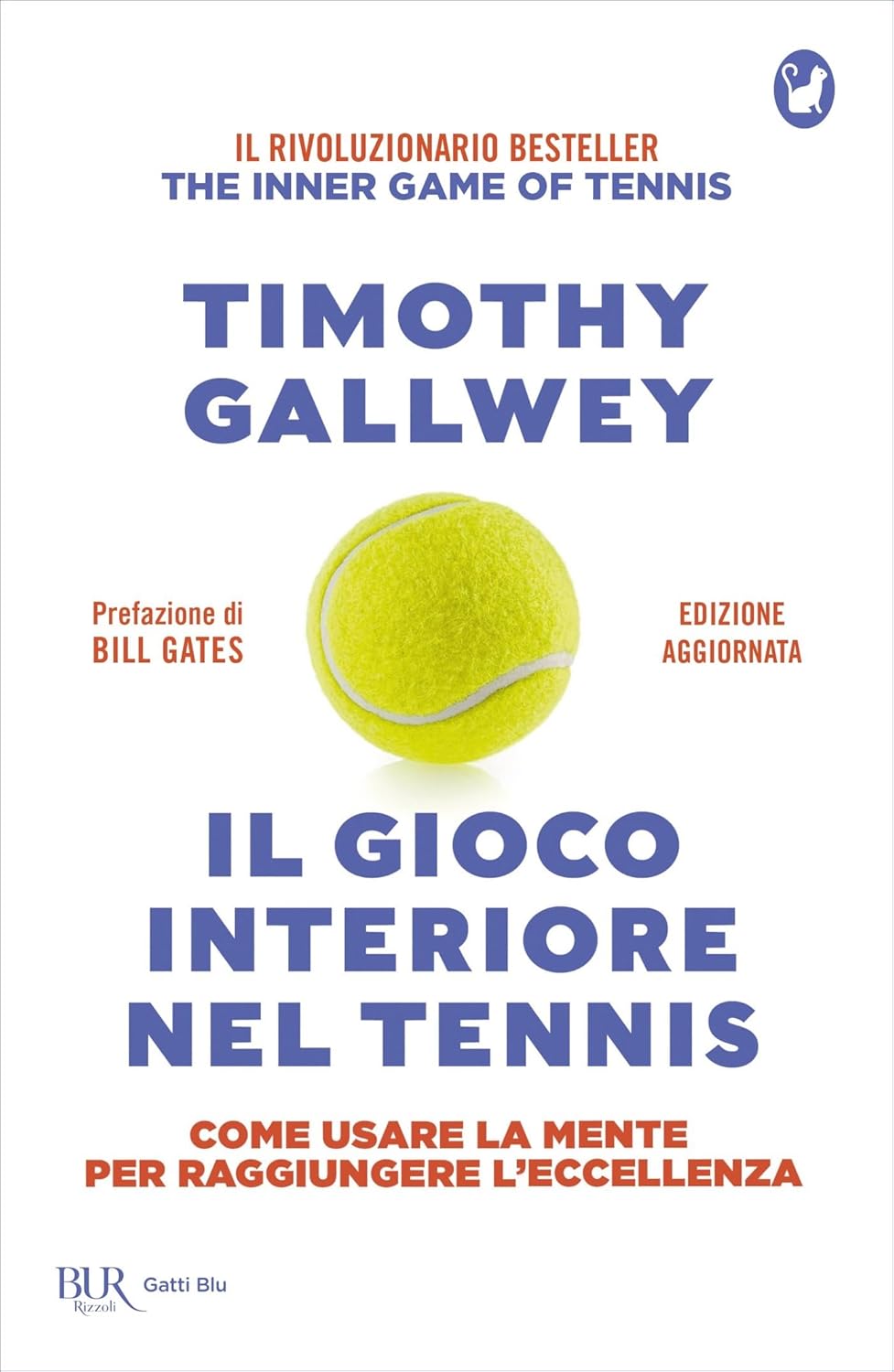

Commento all'articolo