Umani – La nostra storia – Adam Rutherford
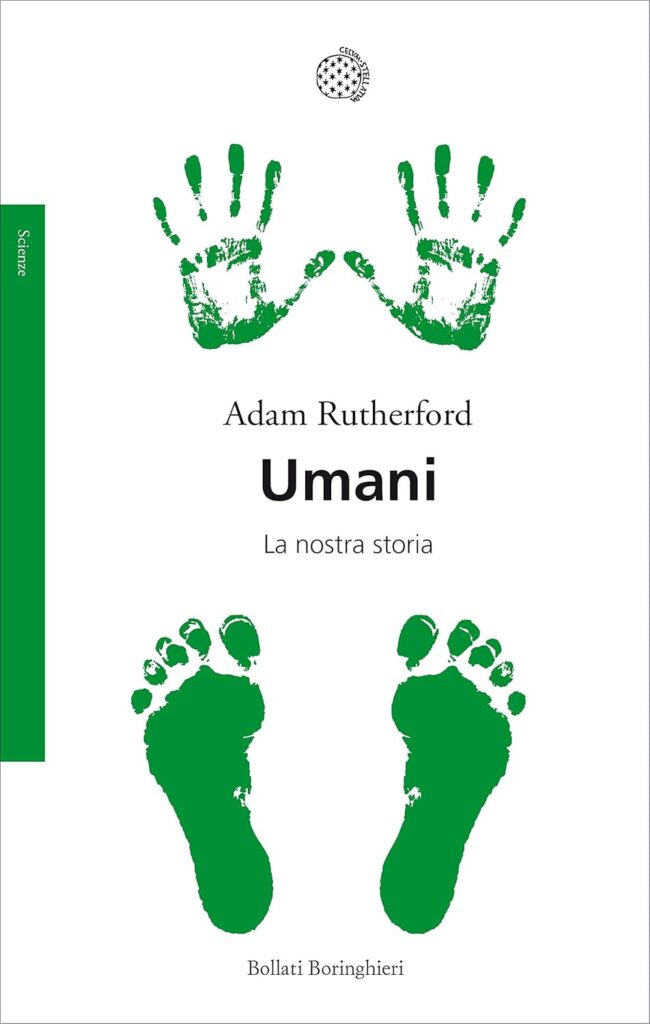
SINTESI DEL LIBRO:
Gli esseri umani sono creature pervase dalla tecnologia. Tecnologia è un
termine che ha assunto un preciso significato nell’era contemporanea. Scrivo
queste parole al computer, con un browser in background che è connesso a
internet tramite wi-fi. Siamo propensi a pensare che queste tipologie di
strumenti e servizi elettronici oggi siano l’incarnazione stessa della
tecnologia. Lo scrittore di fantascienza Douglas Adams aveva elaborato tre
regole riguardo la nostra interazione con la tecnologia:
1. Qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo, ci pare normale e
usuale e riteniamo che appartenga per natura al funzionamento dell’Universo.
2. Qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercorso tra i nostri
quindici e i nostri trentacinque anni è nuova ed entusiasmante e
rivoluzionaria e forse rappresenta un campo in cui possiamo far carriera.
3. Qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto
trentacinque anni va contro l’ordine naturale delle cose.
Certo, sembra che nei media ci sia una costante diffidenza verso le nuove
tecnologie, soprattutto da parte delle persone più anziane che si dicono
preoccupate per i giovani: ma nessuno pensa ai bambini?
Le cose sono come sono sempre state. Nel V secolo a.E.V. Socrate si
scagliava contro i pericoli di una nuova tecnologia perturbatrice, temendo che
nei giovani uomini potesse ingenerare «oblio nelle anime di chi l[a] imparerà
[...] Potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno
d’essere dottissimi, mentre per la maggior parte non sapranno nulla; con loro
sarà una sofferenza discorrere, imbottiti di opinioni invece che sapienti».
La tecnologia che aveva suscitato le ire di Socrate era la scrittura. Duemila
anni dopo, un erudito, filologo e scienziato svizzero del Cinquecento, Conrad
Gessner, esprimeva un’angoscia analoga per le potenzialità di un’altra
innovazione delle tecnologie dell’informazione: la stampa.
Più le cose cambiano... L’attuale disagio culturale antitecnologico nasce
dal tempo che passiamo a interagire con gli schermi. Nei media, sia sulla
stampa che su internet, è un costante preoccuparsi per il troppo tempo che
trascorriamo di fronte agli schermi e per i danni potenziali che questo
potrebbe causare. In anni recenti, al tempo eccessivo trascorso davanti allo
schermo è stato attribuito di tutto, dalla microcriminalità, agli episodi di furia
omicida, all’autismo e alla schizofrenia. In generale si tratta di discussioni
pseudoscientifiche deprimenti, perché i termini del problema sono vaghi e
mal delineati. Passare cinque ore in solitudine immersi in un videogioco ha lo
stesso impatto di cinque ore assorbiti dalla lettura di un libro su un
dispositivo elettronico? Conta qualcosa che il videogioco sia violento o un
gioco di rompicapi o entrambe le cose, oppure che il libro inciti alla violenza
o alla fabbricazione di armi? Guardare un film al cinema è la stessa cosa che
giocare a un videogioco insieme ai familiari?
Non sono ancora disponibili dati, e gli studi condotti sinora non hanno
prodotto conclusioni certe, oppure in un modo o nell’altro si sono rivelati
inattendibili. Comunque sia, parte del discorso è che passiamo troppo tempo
davanti ai dispositivi elettronici quando invece dovremmo fare cose più
creative o culturali, o esprimerci senza affidarci alla tecnologia.
Naturalmente, anche un pennello è uno strumento tecnologico, come lo è una
matita, un bastoncino appuntito o un acceleratore di particelle. Praticamente
nulla di ciò che facciamo di artistico, creativo o più banalmente scientifico,
potrebbe esistere senza il sostegno della tecnologia. Il canto, la danza, persino
alcune forme di atletica e di nuoto, funzionano senza dipendere direttamente
da una tecnologia esterna, ma quando guardo mia figlia sistemarsi i capelli in
uno chignon e poi fissarli con la lacca, tagliarsi le unghie martoriate dei piedi
e indossare le sue scarpette prima di un balletto, non posso fare a meno di
pensare che siamo un animale la cui intera cultura ed esistenza dipendono
totalmente da strumenti e utensili.
Ma che cos’è uno strumento? Esistono varie definizioni. Eccone una tratta
da un testo fondamentale sul comportamento animale:
L’impiego esterno di un oggetto libero o vincolato all’ambiente ma manipolabile per
modificare in modo più efficace la forma, la posizione o lo stato di un altro oggetto, di
un altro organismo o del soggetto stesso che lo sta utilizzando, quando quest’ultimo
tiene stretto e manipola direttamente lo strumento durante o prima dell’uso ed è
responsabile del giusto ed efficace orientamento del medesimo.1
Definizione un po’ verbosa, ma sostanzialmente esauriente. In alcune
definizioni si distingue tra uso di un oggetto rinvenuto e uso di un oggetto
modificato, fatto che lo qualificherebbe come tecnologia. L’idea chiave è che
uno strumento sia un oggetto esterno al corpo dell’animale che viene
utilizzato per esercitare un’azione fisica che permetta all’animale di ampliare
i propri poteri.
Gli strumenti sono parte integrante della nostra cultura. Talvolta si parla di
evoluzione culturale in contrapposizione all’evoluzione biologica, dove la
prima viene insegnata e trasmessa socialmente e la seconda è codificata nel
nostro DNA. Ma la verità è che le due cose sono intrinsecamente legate ed è
più corretto concepirle come una coevoluzione geni-cultura: l’una stimola
l’altra, e la trasmissione culturale delle idee e delle abilità richiede una
capacità biologicamente codificata in tal senso. La biologia rende possibile la
cultura, la cultura cambia la biologia.
Milioni di anni prima dell’invenzione dell’orologio digitale, avevamo una
cultura tecnologica obbligata. Il nostro vincolo verso la tecnologia lo
abbiamo persino riconosciuto nella nomenclatura scientifica. Tra i nostri più
antichi cugini di genere – e probabili antenati – ce n’è uno chiamato Homo
habilis: letteralmente, l’uomo abile o manipolatore. Si tratta di una
popolazione vissuta in Africa orientale 2,1-1,5 milioni di anni fa. Sono pochi
gli esemplari classificati come habilis: in genere hanno volti più piatti dei più
antichi austrolopitecini di circa 3 milioni di anni fa, ma conservano lunghe
braccia e teste piccole (il loro cervello era tipicamente la metà del nostro per
dimensioni). Alla vista, Homo habilis sarebbe sembrato più un uomo
scimmia che una scimmia-uomo. Probabilmente era l’antenato del più gracile
Homo erectus, anche se per un periodo le due specie sono coesistite, il che
forse sta a indicare per Homo habilis un fenomeno di divergenza
intraspecifica.
La loro reputazione di uomini dalle abilità manuali è dovuta in gran parte
alla scoperta di esemplari circondati da evidenze di industria litica – cioè,
oggetti fatti di pietra. Secondo alcuni studiosi la presenza di utensili
rappresenterebbe la linea di demarcazione tra il genere Homo e ciò che lo
aveva preceduto, intendendo con questo che in effetti l’essere umano è
definito dall’utilizzo di strumenti. Le collezioni più nutrite associate
all’Homo habilis vengono dalla gola di Olduvai, in Tanzania, e per riferirsi a
questo tipo di tecnologia si usa l’espressione «industria olduvaiana». Sono
numerosi i termini del gergo tecnico utilizzati nella descrizione di questo
insieme di oggetti e del loro funzionamento: uno è «riduzione litica», che in
sostanza significa scheggiatura delle pietre – spesso quarzo, basalto o
ossidiana – per dar loro una forma o renderle affilate. Molti indizi
archeologici sono sotto forma di scaglie litiche, i resti derivanti dalla
lavorazione di una pietra per ricavarne un utensile, quando l’utensile in sé è
andato perso nel corso del tempo. L’ossidiana è una roccia magmatica, un
tipo di vetro vulcanico,2
ottimo materiale per costruire strumenti taglienti:
genera infatti bordi così affilati che oggi alcuni chirurghi la preferiscono ai
bisturi in acciaio.
Tali azioni implicano un’abilità cognitiva che consenta la selezione delle
pietre più adatte e una pianificazione. Servono una pietra da usare come
percussore, una superficie su cui lavorare e un’incudine su cui scheggiare il
materiale grezzo. Battere per spaccare è un’attività intenzionale e che
richiede abilità, e lo strumentario necessario è composto da vari arnesi.
Alcuni sono robusti, come per esempio il chopper olduvaiano, che si ritiene
fosse utilizzato come testa d’ascia. Altri sono più leggeri: raschietti per
staccare la carne dalle pelli, pietre simili a scalpelli chiamate bulini e altri
utensili per intagliare il legno. Anche in questo caso, la varietà di attrezzi
presuppone la capacità cognitiva di distinguere gli strumenti adatti alle
differenti attività.
Homo habilis è tra i più antichi membri del lignaggio che abbiamo deciso
essere «umano» e l’utilizzo di utensili fa parte della definizione. Tuttavia, la
storia scientifica non avvalora questa linea di demarcazione artificiale:
l’Habilis non è stato il primo a diventare abile nella manipolazione. Un
migliaio di chilometri a nord di Olduvai, sulla riva occidentale del lago
Turkana, si trova Lomekwi, altra area cruciale del vivaio dei primi umani.
Nel 1998 qui è stato scoperto un esemplare ribattezzato Kenyanthropus
platyops, che più o meno significa «Uomo del Kenya dal volto piatto».3
La
sua appartenenza al gruppo delle prime grandi scimmie è piuttosto
controversa, e secondo alcuni è morfologicamente abbastanza simile
all’Australopithecus da far pensare che non si tratti di una specie distinta.
Non sono sicuro che la cosa importi poi così tanto, visto che le nostre
definizioni tassonomiche diventano confuse di fronte a queste arbitrarie linee
di demarcazione, e molte supposizioni vanno formulate sulla base del fatto
che gli esemplari sono rari: sono stati trovati frammenti di oltre 300 individui
austrolopitecini, ma un solo Kenyanthropus.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :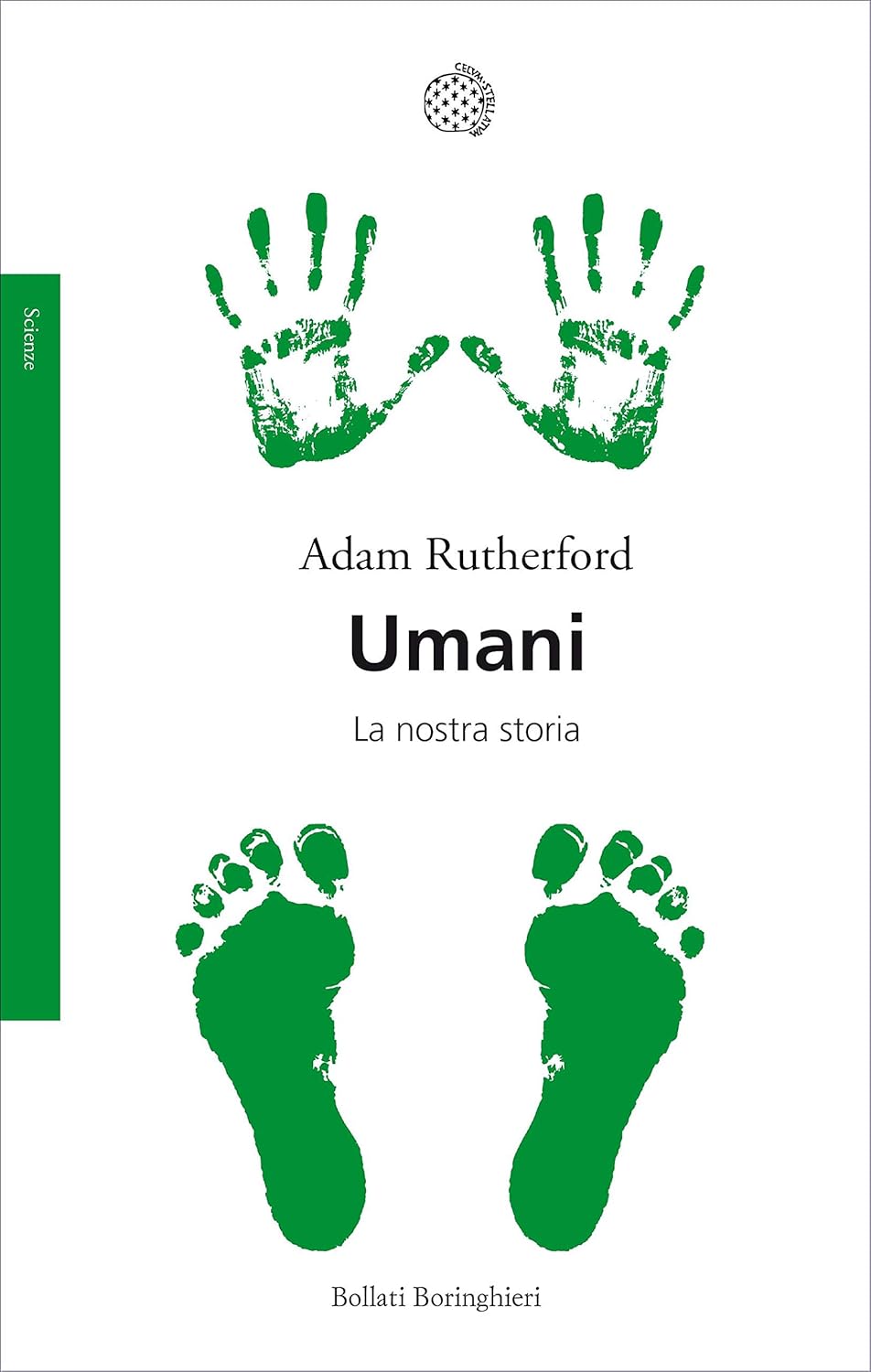






Commento all'articolo