Un bosco di pecore e acciaio – Miyashita Natsu
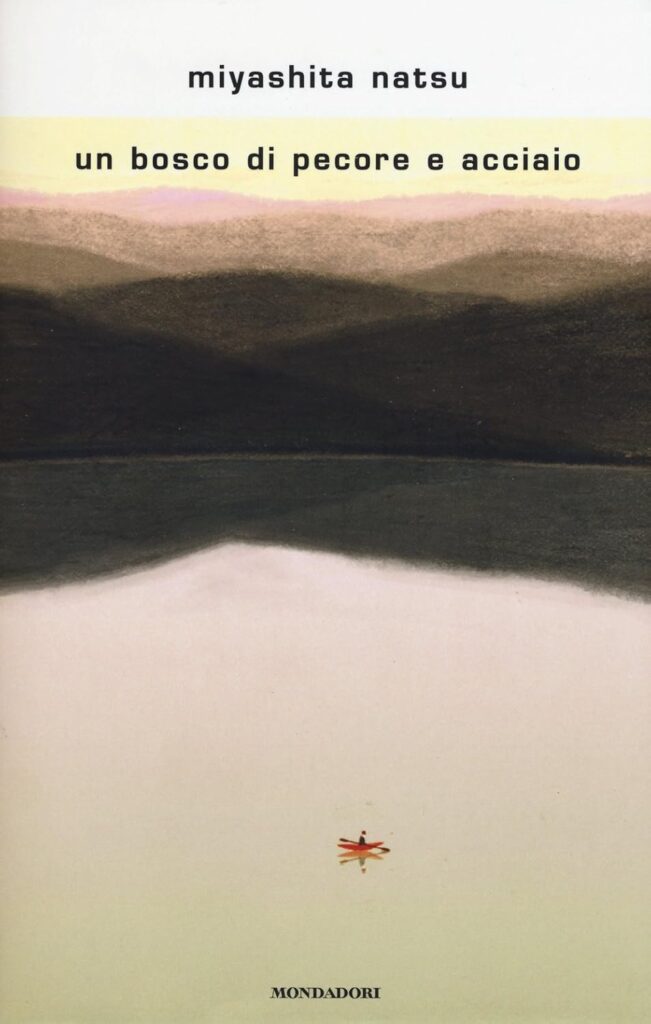
SINTESI DEL LIBRO:
Sentii odore di bosco. Un bosco autunnale, verso sera. Il vento faceva
fremere gli alberi e si udivano le fronde stormire. Odore di bosco, sul
far della sera.
Il problema è che non c’erano boschi nei paraggi. Percepivo il
sentore asciu o dell’autunno, avevo perfino la sensazione del
dilagare della penombra, ma mi trovavo in un angolo della palestra
della scuola. Ero in piedi, solo, nella palestra deserta, in orario
extrascolastico: un allievo con il semplice incarico di accogliere un
visitatore.
Davanti a me, un grande pianoforte nero. O almeno, avrebbe
dovuto essere un grande pianoforte nero. Il coperchio era aperto, e
un uomo stava in piedi al suo fianco. Io non riuscivo a dire una
parola, lui mi guardò di sfuggita. Quando toccò alcuni tasti, dal
bosco con il coperchio aperto arrivò di nuovo il profumo del fremere
degli alberi. La sera avanzò un po’. Avevo diciasse e anni.
L’insegnante responsabile della classe aveva chiesto a me di
accogliere l’ospite solo perché in quel momento mi trovavo ancora in
aula. Era il secondo trimestre del secondo anno di liceo, nel periodo
delle prove intermedie, e le a ività pomeridiane erano già sospese:
noi studenti uscivamo presto da scuola. Stavo proprio pensando di
andare a studiare in biblioteca, perché non avevo voglia di tornare
prima di sera nella camera in affio dove vivevo da solo.
“Scusami, Tomura” aveva aggiunto il professore, “ma abbiamo un
consiglio docenti. Arriva alle qua ro. Basta che lo accompagni in
palestra.”
Risposi di sì. Mi capitava spesso che mi domandassero favori.
Forse parevo uno a cui le cose si potevano chiedere tranquillamente,
p
p
q
o uno che non poteva rifiutare. Magari davo anche l’impressione di
non avere molto da fare. In effe i, avevo tempo da perdere. Non mi
veniva in mente niente che dovessi fare, né che volessi fare. Mi
bastava proseguire la scuola in qualche modo fino al diploma,
trovare un lavoro qualsiasi, e continuare a vivere. La pensavo così.
Mi domandavano spesso favori, ma non erano mai cose
importanti. Le cose importanti le fanno quelli importanti; le cose
irrilevanti le fanno quelli irrilevanti. Pensai che anche l’ospite di quel
giorno dovesse essere irrilevante.
Mi resi conto che il professore mi aveva chiesto di accompagnarlo
in palestra, senza spiegarmi di chi si tra asse.
“Chi è?”
Stava per uscire dall’aula, si girò e mi disse che era l’accordatore.
Non ricordavo di aver mai sentito prima quel termine. Veniva ad
aggiustare l’aria condizionata? Allora perché in palestra? Anche
quello, però, era irrilevante.
Passai circa un’ora in aula a leggere il libro di storia, per
prepararmi al test del giorno successivo. Quando, un po’ prima delle
qua ro, raggiunsi l’ingresso per il personale, l’uomo era già lì: se ne
stava ri o in piedi oltre la porta a vetri, con indosso una giacca
marrone e al fianco una borsa squadrata.
«È qui per il condizionatore?» chiesi, mentre gli aprivo la porta.
«Sono Itadori, di “Etō strumenti musicali”.»
Strumenti musicali? Allora, forse l’anziano signore non era il
visitatore che dovevo accogliere. Avrei dovuto chiederne il nome
all’insegnante.
«Ho saputo dal professor Kubota che per oggi è stato fissato un
consiglio docenti. È sufficiente che ci sia il pianoforte» disse l’uomo.
Kubota era il professore che mi aveva affidato l’incarico.
«Mi hanno de o di accompagnarla... in palestra» dissi, con tono
interrogativo, mentre gli offrivo un paio di pantofole color marrone.
«Sì, oggi mi occupo del pianoforte della palestra.»
Che cosa avrebbe fa o al piano?, mi domandai, ma la mia
curiosità non si spingeva oltre.
«Da questa parte.»
Mi avviai, e l’uomo mi seguì. La borsa appariva pesante. Avevo
intenzione di accompagnarlo allo strumento e di andarmene.
Arrivato davanti al pianoforte, l’uomo posò sul pavimento la
valige a e mi rivolse un cenno con il capo. Pensai volesse dire che
non gli serviva altro. Mi inchinai anch’io, e mi girai per andarmene.
La palestra, di solito chiassosa per le a ività di basket o danza, era
immersa nel silenzio. Dalle alte finestre entravano i raggi del sole
pomeridiano.
Stavo per uscire nel corridoio quando alle mie spalle si udì il
suono del pianoforte. Capii che era il piano solo nel momento in cui
mi girai e lo vidi. Non mi era sembrato il suono prodo o da uno
strumento musicale, quanto piu osto da un ogge o più pratico, era
un suono enigmatico, ma molto bello, che esprimeva qualcosa di
terribilmente nostalgico. È ciò che mi parve di udire.
Mi girai a guardarlo, ma l’uomo non mi badò, e continuò a trarre
suoni dal piano. Non suonava: produceva alcuni suoni, come se li
verificasse. Io rimasi per un po’ lì dov’ero, poi tornai verso lo
strumento.
Anche quando gli fui di nuovo vicino, lui m’ignorò. Lasciò la sua
posizione davanti alla tastiera, per spostarsi di lato, e aprire il
coperchio... a me parve un’ala. L’uomo sollevò la grande ala nera,
mise una stecca di sostegno per impedire che si richiudesse e toccò
di nuovo la tastiera.
Si sentì odore di bosco: la soglia del bosco, sul far della sera. Stavo
per entrarci, ma mi fermai. Perché il bosco è pericoloso, dopo il
tramonto. Un tempo mi raccontavano spesso di bambini che si erano
persi nel bosco e non erano più tornati. Non bisogna entrare nel
bosco, sul far della sera. Il sole cala molto più rapidamente di quanto
paia durante il giorno.
Mi accorsi che l’uomo aveva aperto la borsa squadrata posata sul
pavimento. Conteneva diversi strumenti che non avevo mai visto
prima. Chissà cosa avrebbe fa o al piano, con quegli strumenti. Cosa
avrebbe fa o con il piano? Pensai che non potevo chiederglielo.
L’a o di chiedere comporta una responsabilità. Mi sembrava che se
avessi posto la domanda e lui mi avesse risposto poi avrei dovuto
dire qualcosa a mia volta. La domanda mi ronzava in testa, senza
prendere forma. Forse perché non sapevo cosa dire dopo.
“Cosa fa al piano?” “Cosa vuole fare al piano?” O forse: “Cosa fa
con il piano?”. In quel momento non sapevo cosa mi premesse
domandare in particolare. Ancora adesso non lo so. Probabilmente
avrei fa o bene a chiedere. Quella volta, avrei fa o bene a provarci,
a lanciare la domanda così com’era nata dentro di me anche se non
aveva una forma definita. Ci ripenso spesso: se quella volta avessi
potuto pronunciare quelle parole, non avrei più avuto bisogno di
continuare a cercare la risposta. Se udita la risposta ne fossi rimasto
soddisfa o.
Senza chiedere niente, restai lì a osservare in silenzio, per non
disturbare.
Anche nella piccola scuola elementare e nella scuola media che
avevo frequentato doveva esserci un pianoforte. Non erano
pianoforti a coda come quello che avevo davanti, ma ne conoscevo il
suono, e diverse volte avevo anche cantato con l’accompagnamento
del piano.
Eppure, ebbi l’impressione di vedere quel grande strumento nero
per la prima volta. Quantomeno, era la prima volta che ne vedevo le
viscere, a raverso quell’ala aperta. È evidente che fu anche la prima
volta in cui avvertii sulla pelle il tocco del suono che nasceva da
quelle viscere.
Sentii odore di bosco. Un bosco autunnale, di sera. Posata la
cartella sul pavimento, dalla mia posizione laterale osservavo i suoni
del piano cambiare via via. Persi la cognizione del tempo, forse per
più di due ore.
Lo spazio temporale di quella sera d’autunno si definì meglio: era
se embre, nei primi dieci giorni; ed era ancora l’imbrunire, verso le
sei di una serata serena, non umida. In ci à alle sei del pomeriggio
c’è luce, ma in un villaggio di montagna gli ultimi raggi del sole non
arrivano, perché il bosco li ostacola. Mi parve di sentire creature
montane nascoste lì vicino, pronte a iniziare le proprie a ività non
appena fosse sopraggiunta la no e. Un suono che aveva una
tranquilla, calda profondità: era un suono così, quello che sgorgava
dal pianoforte.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo