Tratti – Perché gli individui non esistono – Paolo Godani
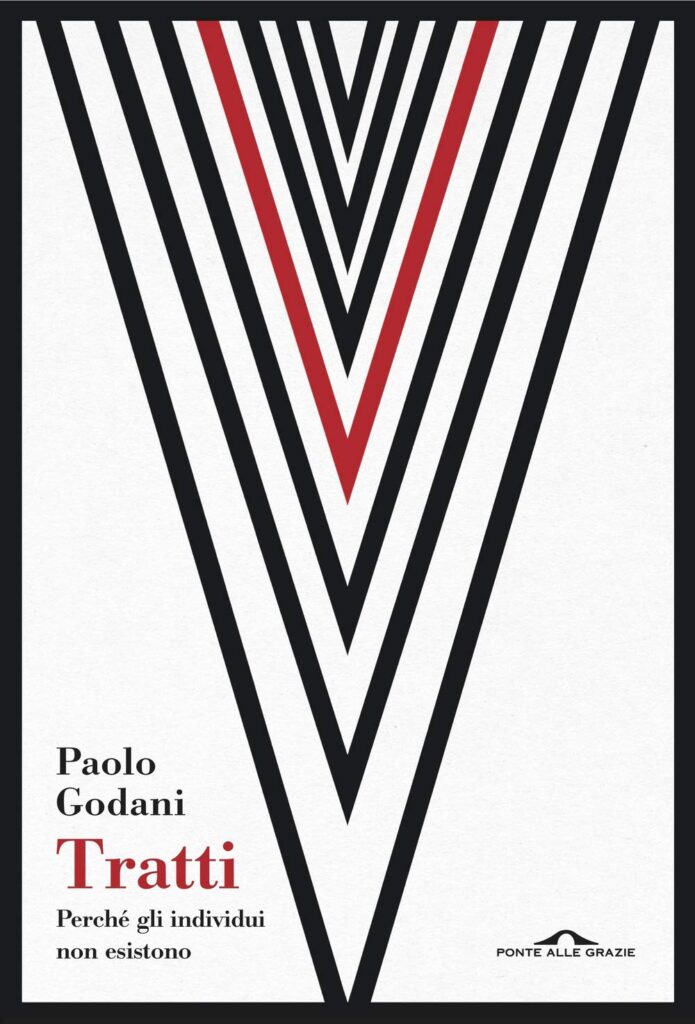
SINTESI DEL LIBRO:
Per l’individuo adulto (e in special modo per il maschio adulto),
l’infanzia, come per altri versi la vecchiaia, è una sorta di periferia
inquietante e barbarica che va tenuta rigorosamente separata dai
quartieri lucidi, efficienti, razionali della maturità. L’ordine delle nostre
esistenze e delle nostre società, ma anche l’organizzazione del
nostro pensiero, la nostra logica e la nostra gnoseologia, trattano
l’infanzia come fosse una vita indipendente e subordinata. Il
bambino deve essere educato, affinché acquisisca le posture e le
tecniche che gli consentano di divenire un adulto funzionale (come
l’anziano dev’essere accudito e curato, perché non è più in grado di
svolgere i compiti richiesti a un individuo nel pieno delle sue facoltà).
Il bambino è trattato come un non ancora adulto, come un essere
non ancora pienamente individuato (e l’anziano come un non più
adulto, come un essere non più pienamente individuato), mentre
l’adulto rappresenta l’individuazione compiuta, un individuo che è
solo e perfettamente individuo. In questo senso, per individuo si
intende un essere interamente padrone di sé stesso e,
conseguentemente, responsabile di ciò che è e di ciò che fa. Ma
l’adulto è precisamente colui che, per essere padrone di sé, deve
essere in grado di mettere a tacere la propria infanzia – che dunque
non è forse così lontana e inoffensiva come si vorrebbe credere.
Forse, se l’adulto è caratterizzato dal dominio di sé e dalla
responsabilità, è in ragione del fatto che il sé che egli è ora capace
di dominare, il sé di cui ora (e sino alla liberazione della vecchiaia) è
chiamato a rispondere, è un sé disobbediente come quello del
bambino.
Anche la nostra logica e la nostra gnoseologia sono propriamente
adulte, in quanto hanno espulso fuori da loro stesse la riottosità,
l’intrattabilità, la confusione, la sofferenza, l’impotenza, il balbettio, il
grido e la dolcezza che caratterizzano l’infanzia (quanto la
vecchiaia). L’organizzazione del nostro pensiero, come l’ordine delle
nostre esistenze e delle nostre società, si fonda innanzitutto sulla
capacità di essere persone perfettamente individuate, cioè sulla
capacità di distinguersi da tutto ciò che non si è, di distinguere ciò
che sta fuori da ciò che sta dentro, dimenticando così quell’età della
vita infante nella quale l’anarchia affettiva non consentiva né di
identificarsi come individuo autonomo e indipendente, né di separare
ciò che riguarda il soggetto da ciò che concerne invece il mondo
esterno. L’intera nostra logica risulta sospesa alla capacità di dire
«Io», come la gnoseologia dipende dalla capacità di identificare un
oggetto in quanto tale. Ma il bambino è, alla lettera, privo di giudizio,
essendo splendidamente incapace di isolare gli oggetti per dire
«questo è quello», «S è P», così com’è incapace di dire «Io».
Proprio all’inizio dell’Antropologia dal punto di vista pragmatico, Kant– condensando le acquisizioni della psicologia settecentesca e
suggerendo già alcune delle vie che nel secolo seguente saranno
battute dalla psicologia sperimentale – formula quattro osservazioni
decisive sull’infanzia, nei suoi rapporti con l’identità individuale, la
sensazione, la percezione, la memoria. «È degno di nota – scrive
che il bambino, anche quando è già abbastanza in grado di parlare
in modo compiuto, incominci comunque piuttosto tardi (forse dopo
un anno) a usare la parola ‘Io’, mentre fino a quel momento ha
parlato di sé in terza persona» (Kant 2010, § 1); «fino a quel
momento si limitava a sentire sé stesso; ora pensa sé stesso»
(ibidem); nei primi mesi di vita, il bambino si mette «a seguire con gli
occhi gli oggetti luccicanti che gli vengono messi dinnanzi» (ibidem)
e questa forma di attenzione costituisce «l’ingenuo inizio di quel
progresso per cui le percezioni (apprensione della rappresentazione
sensibile) si estendono alla conoscenza degli oggetti dei sensi, cioè
all’esperienza» (ibidem). Infine e conseguentemente: «Il ricordo degli
anni della propria infanzia si estende [...] a quel periodo solo in
piccola parte; perché quello non era il tempo delle esperienze, bensì
di mere percezioni sparse, non ancora riunificate sotto il concetto
dell’oggetto» (ibidem).
Come si può vedere, le prime due notazioni kantiane sono riferite
alla coscienza di sé, mentre le seconde due sono piuttosto riferite
alla coscienza dell’oggetto. Ma altrettanto chiaramente le seconde
sono subordinate alle prime, dato che non si dà percezione (e
dunque memoria) senza che vi sia esperienza, e l’esperienza
necessita sempre di un «Io» che ne sia il soggetto d’inerenza. Il
bambino ha sensazioni, sente che qualcosa c’è o accade, ma
ancora non distingue se ciò che c’è o accade accada dentro o fuori
di lui; il bambino non solo, come dice Kant, parla di sé in terza
persona («Carlo vuole mangiare»), ma confonde in un’unica
sensazione sé stesso e il mondo circostante, come su una sorta di
campo neutro, sul quale, non essendo ancora la sensazione
biforcata in affezione e percezione (ovvero in sensazione soggettiva,
interna, e sensazione oggettiva, esterna), non è dato distinguere l’Io
e il Non-Io. Se si deve trovare da qualche parte un esempio effettivo
di ciò che Sartre (nella Trascendenza dell’Ego) ha chiamato «campo
trascendentale senza soggetto» è proprio qui, nell’infanzia, che lo si
potrà reperire allo stato puro.
Di questa che, nonostante Kant, potremmo chiamare esperienza
impersonale, la memoria non recherà alcuna traccia. La ragione di
questa mancanza, secondo Kant, sta nel fatto che le percezioni
sparse di quella «esperienza» ancora non sono riunite sotto il
concetto dell’oggetto – il rosso non è il rosso della mela, i riflessi non
sono quelli della collana di perle, i miagolii non sono prodotti dal
gatto. Ma si potrebbe ugualmente dire che di quelle esperienze non
vi è memoria perché non sono mai state mie esperienze, non sono
mai state esperienze del soggetto empirico che io ora sono. Dal che
consegue che l’esperienza impersonale dell’infanzia non mi
appartiene. In un certo senso, io non sono stato il bambino che pure,
per altri versi, sono certamente stato. Infine, ed è una decisione in
stile tipicamente kantiano, l’esperienza sensibile e impersonale
dell’infanzia va considerata solo ed esclusivamente come un
«ingenuo inizio» del progresso che conduce all’esperienza
propriamente detta. Rispetto a questo, verrebbe da chiedersi in che
senso un’esperienza non personale né oggettiva, un’esperienza di
cui pertanto l’adulto non reca alcuna traccia mnestica, possa essere
però l’inizio di un progresso capace di condurre a un’esperienza
personale e oggettiva; in che senso, cioè, quella fase della nostra
vita che, rigorosamente parlando, non ci appartiene, nondimeno sia
per noi a tal punto fondamentale da costituire la condizione iniziale di
ciò che siamo diventati. Forse, portati come siamo di solito a
espellere l’infanzia fuori dai confini della razionalità adulta, non ci
accorgiamo che quello stato impersonale, puramente sensibile e non
oggettivo dell’esperienza infantile, lungi dall’essere abbandonato
dopo i primi mesi di vita, ci accompagna costantemente, e
accompagna costantemente l’orizzonte della nostra esperienza
come una frangia d’indeterminazione.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :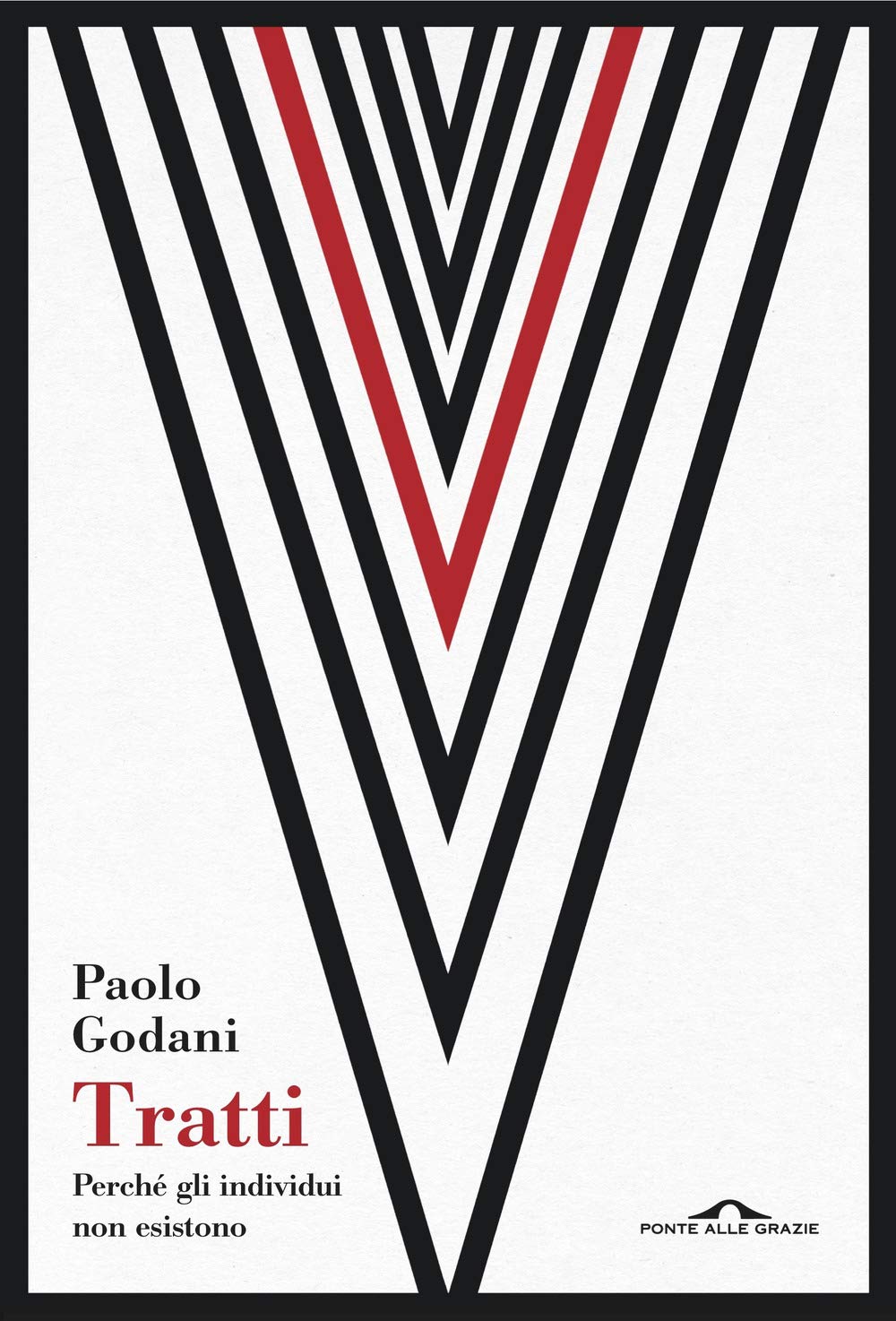






1 commento