Tutte le cose della nostra vita – Sok-Yong Hwang
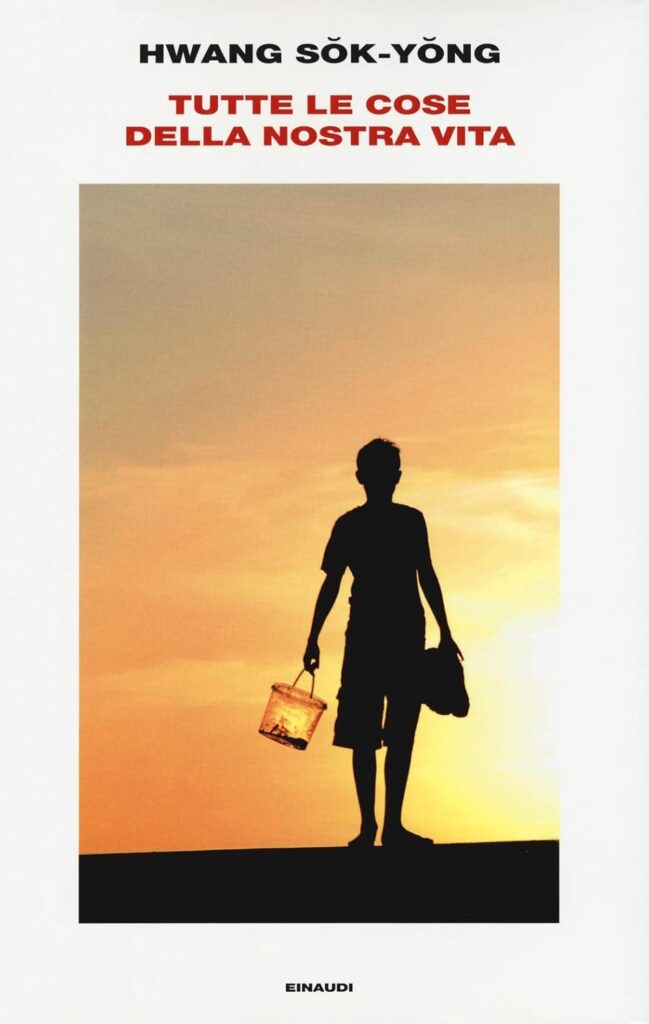
SINTESI DEL LIBRO:
Il sole stava tramontando sul limitare del campo, al di là del fiume.
Bastò distogliere per un attimo lo sguardo e, come per magia, quel
gigantesco cerchio di fuoco si era già eclissato alle spalle del
paesaggio. Dopo aver attraversato la periferia della città, un camion
prese a percorrere una strada che fiancheggiava il fiume. Giunto in
un punto da cui si scorgeva un ponte, cominciò a fermarsi a piú
riprese, procedendo a passo d’uomo.
Un ragazzo era avvinghiato alla colonnina in ferro dello scomparto
posteriore, appena dietro il sedile del guidatore. Era in piedi e aveva
lo sguardo rivolto in avanti, cosí da poter osservare il lungofiume e il
panorama che si dispiegava davanti ai suoi occhi. Proveniva dal
rione orientale della città ed era montato su quel camion carico di
rifiuti insieme alla mamma. D’un tratto le vetture si arrestarono in
coda e poi ripresero timidamente il cammino a scatti, deviando dal
lungofiume. Si addentrarono in un sentiero non asfaltato che
costeggiava un modesto affluente grande poco piú d’un ruscello. A
illuminare il cielo erano ormai rimasti soltanto gli stanchi bagliori del
crepuscolo, mentre il paesaggio intorno un po’ alla volta sfumava nel
buio.
A ridosso di una collina, piú a nord, oltre il fiume, era appollaiato
un piccolo villaggio, dalle cui abitazioni brillavano in lontananza delle
lucine minuscole. Chissà, forse in mezzo a tutte quelle case ve n’era
una pronta a ospitarlo insieme alla mamma. Quel paesaggio
incorniciato dagli alti fusti di miscanto che tremavano al vento
sembrava appartenere a un altro mondo. Appena accese i fari, il
camion fu inghiottito da un banco di polvere. A quel punto si avviò
per un sentiero in salita che curvava nella direzione opposta rispetto
alle diafane luci del villaggio. Nell’oscurità qualcosa urtava contro il
viso, forse erano dei semi di grano trascinati dal vento. Insieme al
ragazzo e alla mamma, su quel cumulo d’immondizie caricato sul
camion dalla discarica del rione orientale, viaggiavano anche tre
uomini e due donne. Alcuni si erano accomodati su un telo di
plastica steso a terra, mentre le donne, con la gonna avvitata intorno
alla cintola, si tenevano aggrappate alle grate di ferro.
Erano seduti nel bel mezzo di quell’immondizia sin dall’inizio del
loro viaggio, e ormai nemmeno piú avvertivano il fetore che
emanava. Quando il camion, dopo essersi arrampicato sul sentiero
in salita, parcheggiò su uno spiazzo, quel lezzo era diventato ormai
irrespirabile. Un misto di escrementi, putridume, cibo avariato,
stufato di fagioli e salsa di soia: qualcosa di davvero nauseabondo.
All’interno di quel buio, nugoli di mosche si appiccicavano senza
sosta al viso, alle braccia e ai lembi dei vestiti dei passeggeri; senza
farsi alcuno scrupolo si posavano intorno alle labbra o agli occhi e lí
sgranchivano le loro zampette fredde e collose.
Quel ragazzo non rivelava mai agli altri il suo nome. Il cognome,
in particolare. Eppure fino alle scuole elementari, i ragazzini erano
soliti chiamarsi l’un l’altro ad alta voce e pronunciando per esteso i
loro nomi. Aveva quattordici anni, ma nei vicoletti del suo quartiere
se ne faceva dare due in piú. Una volta era capitato che dei
compagni piú grandi volessero calargli le brache per vedergli i peli
pubici, per capire meglio la sua età, ma lui aveva reagito con la
forza, colpendone uno e spaccandogli i denti anteriori. Per ripicca gli
altri gli avevano rotto a suon di botte il naso e probabilmente gli
avevano spezzato anche una costola, perché ogni volta che
respirava sentiva delle fitte acute in tutta la gabbia toracica. Eppure
in quel modo era almeno riuscito a difendere la sua dignità. Nei vicoli
gli
amici lo chiamavano con nomignoli come «Cavalletta»,
«Cicogna» oppure «Occhiapalla». Il nome «Cavalletta» gliel’aveva
dato il professore di quarta perché aveva braccia e gambe lunghe e
correva come una scheggia; anche se era meno altisonante di
«Airone» o di «Gru», «Cicogna» era un modo generico per indicare
un uccello con le gambe e il collo lunghi. A quei due soprannomi che
non lo esaltavano affatto preferiva piuttosto «Occhiapalla».
Gliel’aveva assegnato un poliziotto di ronda nel suo quartiere. Lui e
altri ragazzetti avevano ridotto in frantumi i vetri della guardiola della
polizia e mentre cercavano di scappare alcuni di loro erano stati
catturati dalle guardie: fu una di queste ad apostrofarlo con quel
nome, mentre lo percuoteva in testa decine di volte con un rotolo di
documenti.– Brutto bastardo, che hai da guardare con questi occhioni a
palla!
Da quel momento in poi, quando gli amici lo chiamavano con gli
altri nomignoli, lui reagiva rifilando loro degli scapaccioni, mentre
tollerava che lo chiamassero «Occhiapalla»: in quel caso tutt’al piú si
limitava a non rispondere. Un po’ alla volta finí lui stesso per
presentarsi con quel nome quando incontrava dei suoi coetanei. Se
dapprima se l’era assegnato per distinguersi dai ragazzi piú
benestanti, a un certo punto cominciò a farsene vanto come di una
conquista, al pari delle stelle di cui si fregiano gli adulti ogni volta che
finiscono in gattabuia.
Occhiapalla aveva interrotto gli studi al primo semestre della
quinta elementare ed era solo merito della madre che lavorava come
ambulante se si erano potuti permettere di pagare l’affitto per un
bugigattolo in un rione disagiato nella periferia della città e di non
saltare nemmeno un pasto. Dopo un periodo trascorso a zonzo
insieme ad altri coetanei del suo quartiere, si era messo a seguire la
madre al mercato, finché non aveva trovato lí anche lui un impiego in
un negozio d’abbigliamento. Mentre i negozi veri e propri erano
ospitati all’interno di un imponente edificio che dava sulla strada
principale, i laboratori di sartoria erano stipati in un vicolo sperduto
sul retro. I proprietari prendevano in fitto degli androni, piazzavano al
loro interno delle macchine da cucire e assumevano cinque o sei
sarti. Occhiapalla sbrigava piccole mansioni, consegnava di corsa ai
negozi dei vestiti confezionati nei laboratori oppure ritirava materiali
come tessuti, fili e bottoni da portare ai sarti. Un giorno, quando
ormai fuori era scuro, si recò nel negozio della mamma: trovò altre
commesse che stavano riordinando la bottega, ma di lei non c’era
traccia.– Dov’è andata la mamma? – chiese.
– Boh, forse s’è trovata qualcuno, eheh! – ironizzò una delle
signore, ma un’altra che le era di fianco subito s’intromise.– Mi pare che sia venuto tuo padre a cercarla, penso sia nel
vicolo dei ristoranti.
Preso in contropiede da quella risposta, si fiondò subito a
cercarla. L’odore di pesce alla brace si sovrapponeva a quello di
zuppa di salsiccia. Occhiapalla cercò con lo sguardo all’interno dei
locali su ambo i lati del vicolo e, dopo averlo percorso su e giú, trovò
finalmente la madre seduta a un tavolo di fronte a un uomo. Dato
che era di spalle e da quell’angolatura non gli si vedeva il volto, il
ragazzo non poté capire chi fosse; indossava una giacca militare da
campo e un berretto sportivo blu.
Occhiapalla si intrufolò nel ristorante e appena la mamma lo vide
gli fece segno con la mano. Si avvicinò al tavolo e, prima ancora di
avere il tempo di verificare chi fosse, il tipo allungò la mano e fece
per accarezzarlo. Appena si accorse che non si trattava del padre, il
ragazzo scansò la testa e indietreggiò.– Cavoli, quanto sei cresciuto! – esclamò quel tipo ritraendo con
un certo imbarazzo la mano. – Sembra ieri che gattonavi per casa.– Su, salutalo – lo esortò la mamma. – È un amico del babbo.
Occhiapalla abbozzò un saluto con il capo e andò a sedersi
accanto alla madre, da dove iniziò a scrutare attentamente il
soggetto che gli era di fronte. I suoi occhioni luminosi e il suo naso
ben piazzato tutto sommato davano l’impressione di una persona
perbene, ma il volto era poi deturpato da un ematoma violaceo che
copriva quasi interamente la guancia. Aveva un che di familiare…
Mantello blu e rosso, viso per metà bianco per metà indaco… e poi
quel mento appuntito. Ma certo! Era il barone Ashura. Quel brutto
ceffo, il braccio destro del perfido dottor Inferno, che tramava
sempre contro il paladino della giustizia, Mazinga Zeta, anche se alla
fine gli andava sempre male! Preso da un impeto di collera,
Occhiapalla strinse i pugni e cominciò a guardarlo in cagnesco.
Come se nulla fosse, però, il tipo riprese il discorso da dove l’aveva
interrotto. Nel frattempo la madre rimase a guardarlo con gli occhi
che le luccicavano e annuendo con il busto prono verso di lui:
– Be’, non sarà la dimora dei tuoi sogni, ma almeno avrai una
casa tutta tua e senza dover pagare un affitto… senza togliere che
guadagnerai tre volte quello che prendi adesso. Dimmi tu dove la
trovi al giorno d’oggi un’opportunità del genere!– Non posso assicurare se e quando mio marito si farà vivo… ma
se tu prometti di assumermi, stai pur certo che noi non ci tireremo
indietro per nessun motivo al mondo, – replicò la mamma.
Dopo aver lanciato un’occhiata a Occhiapalla che, stringendo i
pugni appoggiati sul tavolo, continuava a guardarlo di traverso, il tipo
gli chiese: – E tu, quanti anni hai?
Occhiapalla non trovò il coraggio di mentire in presenza della
mamma e di spacciarsi per uno di sedici anni.– Quattordici, – intervenne lei in sua vece.
Il barone Ashura reagí con una posticcia espressione di stupore:– Ma come, sei cosí bello grosso e hai appena quattordici anni?
Stammi a sentire, io se fossi in te fingerei di averne almeno un paio
in piú.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :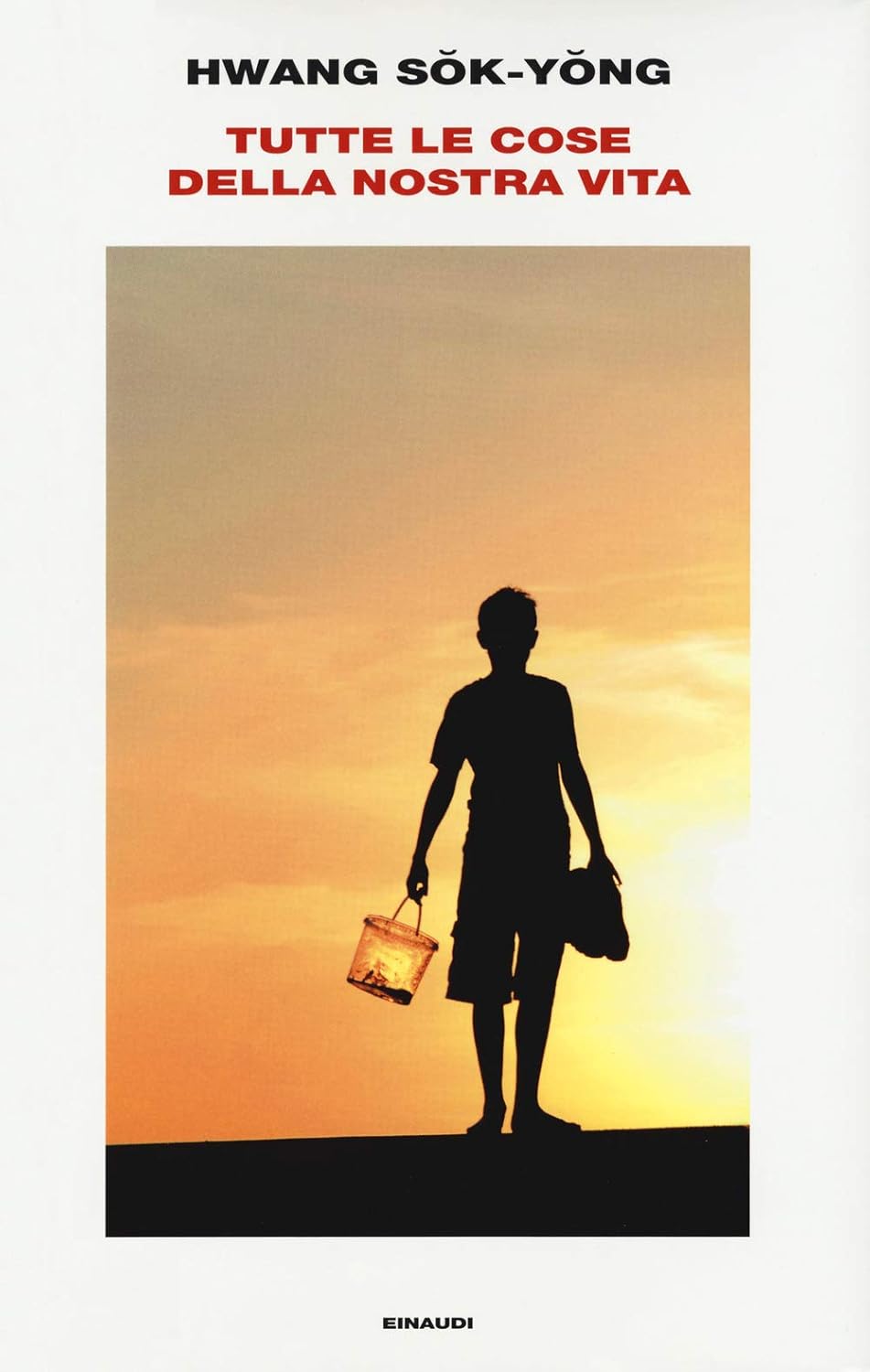






Commento all'articolo