Tragedia e filosofia – Una storia parallela – Agnes Heller
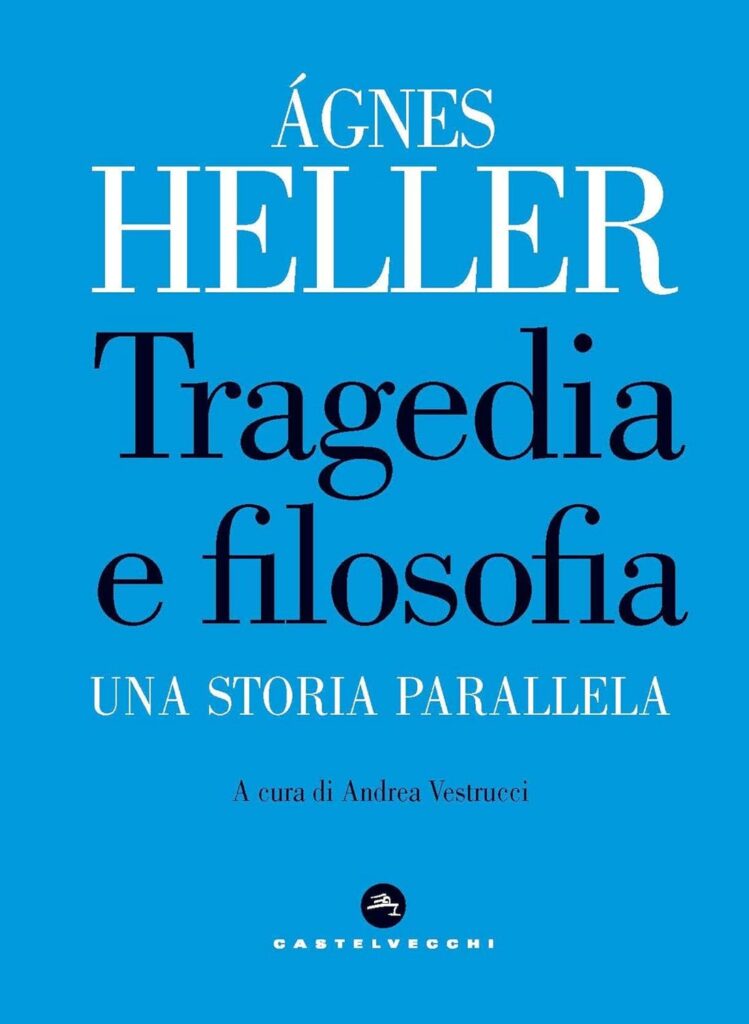
SINTESI DEL LIBRO:
Nella Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto Hegel osserva
che, come la nottola di Minerva spicca il volo sul far del crepuscolo1, così
la filosofia fiorisce quando una storia giunge alla sua conclusione. Ecco
come, e perché, la filosofia comprende la storia – inclusa la propria storia.
Si comprende una storia sempre a partire dalla sua fine. La fine di una
storia coincide con l’inizio della ricostruzione e comprensione del tutto. Il
nostro tempo – così pensava Hegel – è il compimento della storia, la sua
fine.
Quando un periodo storico fiorisce e matura, la poesia, e in particolare
la tragedia, domina la scena. Così fu ad Atene, e così è stato nell’Europa
moderna.
E proprio quando la tragedia giunse alla sua fine nelle opere di
Euripide, la filosofia nacque con Socrate e continuò a fiorire sino a
concludersi con Aristotele. Lo stesso accadde, come c’era da aspettarsi,
nella storia europea. Quasi nel momento in cui la tragedia moderna, da
Shakespeare a Racine, abbandonò la scena, la filosofia, come la nottola di
Minerva, iniziò il suo volo con Cartesio, per arrivare poi alla sua fine con
Hegel. Nuovamente, la fine della tragedia segnò il preludio della storia
della filosofia – dal suo inizio sino alla sua fine.
Resta da chiedersi se l’affermazione di Hegel sia un solido punto di
partenza per ulteriori investigazioni, o se debba essere considerata un
semplice motto arguto. Assumo che Hegel abbia detto qualcosa di
importante, e provo a sviluppare la sua osservazione come un’idea
adeguata, o almeno come un’ipotesi.
In primo luogo, devo assumere che ci sia qualcosa in comune tra
tragedia e filosofia. Quest’ultima appare quando la prima scompare, come
se la filosofia veicolasse un messaggio simile a quello della tragedia, quasi
prendendo, in un certo senso, il posto della tragedia stessa.
Prima di iniziare la mia indagine devo chiarire che in ciò che segue
parlerò della tragedia e della filosofia come generi letterari. Non mi
chiederò se si possa parlare di “tragedie della vita” o di “eventi tragici”, e
non includerò nella mia indagine i cosiddetti moralisti e le opere di
letteratura critica.
Aristotele nella Poetica aveva già identificato un’importante
somiglianza tra tragedia e filosofia: entrambe presentano allo spettatore, o
al lettore, qualcosa di essenziale sul mondo: storie di uomini e dèi, l’etica e
il destino umani, l’universo, il destino del mondo. Tragedia e filosofia,
aggiunge Aristotele, sono diverse dalla storiografia: da un lato gli storici ci
dicono come certi eventi accaddero o cosa sono questi eventi; dall’altro i
filosofi e i tragediografi ci dicono come le cose avrebbero potuto accadere
o essere, come dovrebbero accadere, o come devono essere – in modo
probabile o necessario. Nei libri di storia le contingenze giocano un ruolo
importante, mentre nella tragedia e nella filosofia le contingenze sono
soggette al destino o alla necessità, o inserite in essi.
In tutte queste variazioni (poter accadere, poter essere, dover accadere,
dover essere) l’osservazione di Aristotele si applica tanto alla filosofia
quanto alla tragedia. Tuttavia, ciò che accade in una tragedia si sviluppa in
una trama, mentre ciò che accade in una filosofia si sviluppa in argomenti
e dimostrazioni. Sia le trame che gli argomenti conducono ugualmente al
risultato finale, all’esito, ossia, entrambe sono costruite teleologicamente.
Aristotele pensava che quasi tutti i buoni scrittori di tragedia conoscono
la conclusione della loro storia prima di iniziare a scriverla. Inoltre,
suggeriva che questa conclusione deve essere davvero finale: Aristotele
non vedeva di buon occhio le tragedie in serie. Quando qualcosa si
conclude, deve finire lì, non c’è nient’altro da aggiungere. Ecco perché la
maggior parte delle tragedie devono terminare con una morte. Non
perché la morte sia tragica in sé, ma perché è finale. Le tragedie sono
mondi chiusi.
Questo vale anche per le filosofie (metafisiche). Il filosofo conosce i
risultati dei suoi argomenti o della sua dimostrazione prima di iniziare a
scrivere. Egli sa cosa siano il sommo Bene o la suprema Verità già prima di
iniziare la deduzione e arrivare a loro come conclusione di questa
deduzione.
Certo, le tre unità della tragedia (di tempo, azione e luogo)
apparentemente suggerite da Aristotele non si applicano alla filosofia.
Tuttavia, come vedremo, le unità di luogo e di tempo saranno via via
applicate sempre meno. In ogni caso, l’unità di azione si applica a
entrambe. I filosofi devono presentare un mondo che sia coerente, libero
da contraddizioni, finito. E, naturalmente, nessun filosofo riesce in questa
impresa, agli occhi del filosofo successivo.
L’unità di tempo (e forse anche di luogo) è richiesta – secondo
Aristotele – in una tragedia, come in un dramma in generale, per ragioni
di chiarezza, ossia affinché il fruitore possa memorizzare tutta la trama. Si
può citare questo o quell’episodio da Omero, senza fare riferimento al
tutto. Ma in una tragedia (e aggiungo, anche in filosofia) non ci sono
episodi indipendenti. Per capire una filosofia si devono avere sotto
controllo simultaneamente gli archài (i princìpi) e il risultato finale (la
verità). Al contrario, si può capire un capitolo di un libro di storia, per
esempio la storia di una guerra, il carattere di un re, senza
necessariamente avere in mente la storia nella sua totalità.
Sia la filosofia sia la tragedia sono generi letterari. Entrambi operano
con personaggi. I personaggi della filosofia sono chiamati categorie. I
filosofi creano le proprie storie muovendo questi personaggi come
marionette sul palcoscenico del loro mondo. Ci sono personaggi fissi in
filosofia, come sostanza, verità, ragione, opinione, anima, principio, ecc. I
filosofi creano un mondo a parte, nella maggior parte dei casi, con gli
stessi personaggi, ma in molteplici varietà. Il loro mondo è chiuso perché
tutto è correlato a tutto il resto, è un mondo coerente, proprio come il
mondo della tragedia. Anche qui la conclusione è definitiva. Certo, non
esiste sistema “definitivo” in filosofia che non sia rifiutato dal filosofo
successivo, il quale a sua volta gioca con gli stessi personaggi (o quasi) un
gioco differente.
Al contrario, le tragedie sono atomi indipendenti, non si riferiscono una
all’altra né in termini affermativi né in termini negativi. Inoltre, le radici
antropologiche della tragedia e della filosofia sono essenzialmente
differenti.
Una differenza è palese. La tragedia è, secondo Aristotele, un
sottogenere all’interno del genere dell’arte (tèchnē). La tèchnē è
mìmēsis, ossia un tipo di imitazione; secondo Aristotele, imitazione della
natura. Il concetto di “tèchnē” include non solo la poesia e il dramma, o la
pittura, ma anche oggetti di uso pratico. Aristotele fa un’osservazione
evidente per tutti: sin dalla prima infanzia noi imitiamo costantemente.
Non possiamo crescere senza imitazione.
Noi siamo tutti gettati, a caso, in un mondo che ci è estraneo, come
stranieri in questo mondo. Il nostro corredo genetico deve integrarsi
sino a un certo punto – con il mondo in cui siamo gettati. Dobbiamo
imparare il linguaggio, l’uso delle cose, i costumi, le interpretazioni
dominanti proprie del mondo in cui siamo gettati a caso2. Senza la
capacità di imitazione (mìmēsis) nessuno di noi potrebbe sopravvivere.
La tèchne (l’arte) attiva quindi una delle condizioni fondamentali
dell’essere umano.
La tragedia come dramma – sempre secondo Aristotele – “imita” la
natura, ossia le azioni. Le azioni principali in tutti i drammi sono atti
linguistici. Il dramma, le azioni, si sviluppano infatti in dialoghi, in atti
linguistici.
In modo simile, le azioni si sviluppano nella filosofia come atti
linguistici. Forse con l’eccezione dei dialoghi socratici di Platone
(menzionati anche da Aristotele), nella filosofia gli atti linguistici sono essi
stessi le azioni, ossia rappresentano se stessi, mentre nel dramma l’atto
linguistico rappresenta, introduce, o riguarda azioni della vita, azioni di
corpi, incluse le azioni che non necessitano del linguaggio. Uccidere e
morire non sono atti linguistici, e così pure fuggire, incoronarsi o essere
incoronati, sposarsi, salpare, o accecarsi. Invece nella filosofia tutto è
fornito dal linguaggio, ossia da concetti. E le cose cui ci si riferisce sono
anch’esse concetti.
Il dramma può essere tragico o comico. Dato che sia le commedie sia le
tragedie sono drammi, alcuni personaggi principali sono comuni. In
entrambi i tipi di dramma il linguaggio è il mezzo che veicola le azioni e le
scene non linguistiche, ossia le azioni del corpo.
Aristotele distingue tragedia e commedia principalmente per la
posizione sociale e personale dei personaggi. I protagonisti di una tragedia
si pongono in una posizione superiore rispetto a quella di noi spettatori,
sono migliori, più nobili di noi, mentre i personaggi della commedia sono
in una posizione inferiore alla nostra, sono volgari, brutti o, nel caso
peggiore, sono esattamente come noi.
È una questione ancora aperta se per “superiore” Aristotele si riferisse a
un ordine gerarchico (divinità, re o regine, principi o principesse) o
piuttosto alla levatura personale, alla nobiltà morale. Purtroppo, non
possiamo chiedere una risposta ad Aristotele stesso. Aristotele sottolinea
che i personaggi sono meno importanti della trama, e consigliò al poeta di
definire prima il conflitto e solo in seguito di cercare figure mitologiche
che possano adattarsi al ruolo scelto. I personaggi devono adeguarsi alla
trama e non viceversa.
Quindi, continua Aristotele, questi personaggi straordinari e di grande
levatura devono commettere un grave errore che sarà l’inizio della loro
caduta. Saranno condannati a causa di questo errore, un errore radicato
nel loro carattere (per esempio l’inclinazione alla rabbia o la presenza di
credenze irrazionali), e non risultante da intenzioni malvage. Una
condanna per intenzioni malvage non suscita la nostra empatia, e d’altro
canto la condanna senza errori è sicuramente triste, ma non tragica.
Come vedremo, questa condizione sarà messa in discussione dal
Riccardo III di Shakespeare. L’Illuminismo cambiò approccio alla
Poetica di Aristotele proprio per “autorizzare” la tragedia moderna.
Nel famoso romanzo Il nome della rosa Umberto Eco ipotizza che la
parte mancante della Poetica di Aristotele, il famoso secondo libro sulla
commedia, contenesse un messaggio altamente significativo per gli
spettatori e i lettori di ogni tempo. Questa ipotesi si inseriva bene nella
trama di quel bel romanzo; tuttavia, conoscendo Aristotele, non si può
pensare che il capitolo perduto potesse avere la stessa importanza e
rilevanza di quello sulla tragedia, per un semplice motivo: le grandi
tragedie greche erano già state scritte prima dei tempi di Aristotele,
nessuna tragedia antica significativa fu creata successivamente in tutto il
mondo antico. Inoltre, per quanto concerne la commedia, Aristotele
conosceva solo Aristofane come “lo” scrittore di commedie. Non
conosceva la “nuova commedia”, un tipo completamente nuovo di
commedia, non più volgare – un sottogenere sviluppato con successo dai
grandi scrittori di commedie romane quali Plauto e Terenzio. La
differenza consisteva nel fatto che nelle commedie di Plauto e Terenzio i
personaggi possono anche essere nobili e saggi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :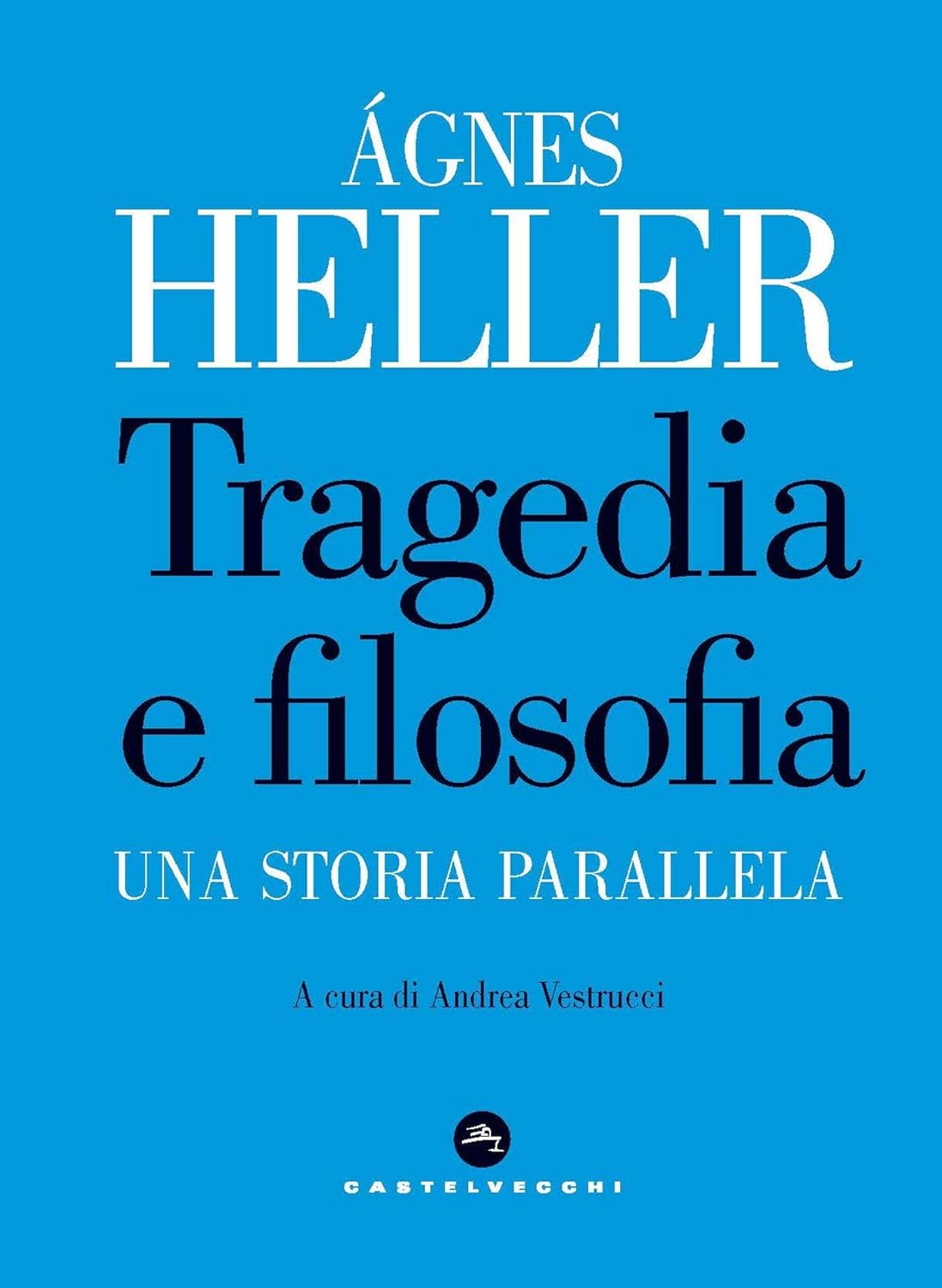





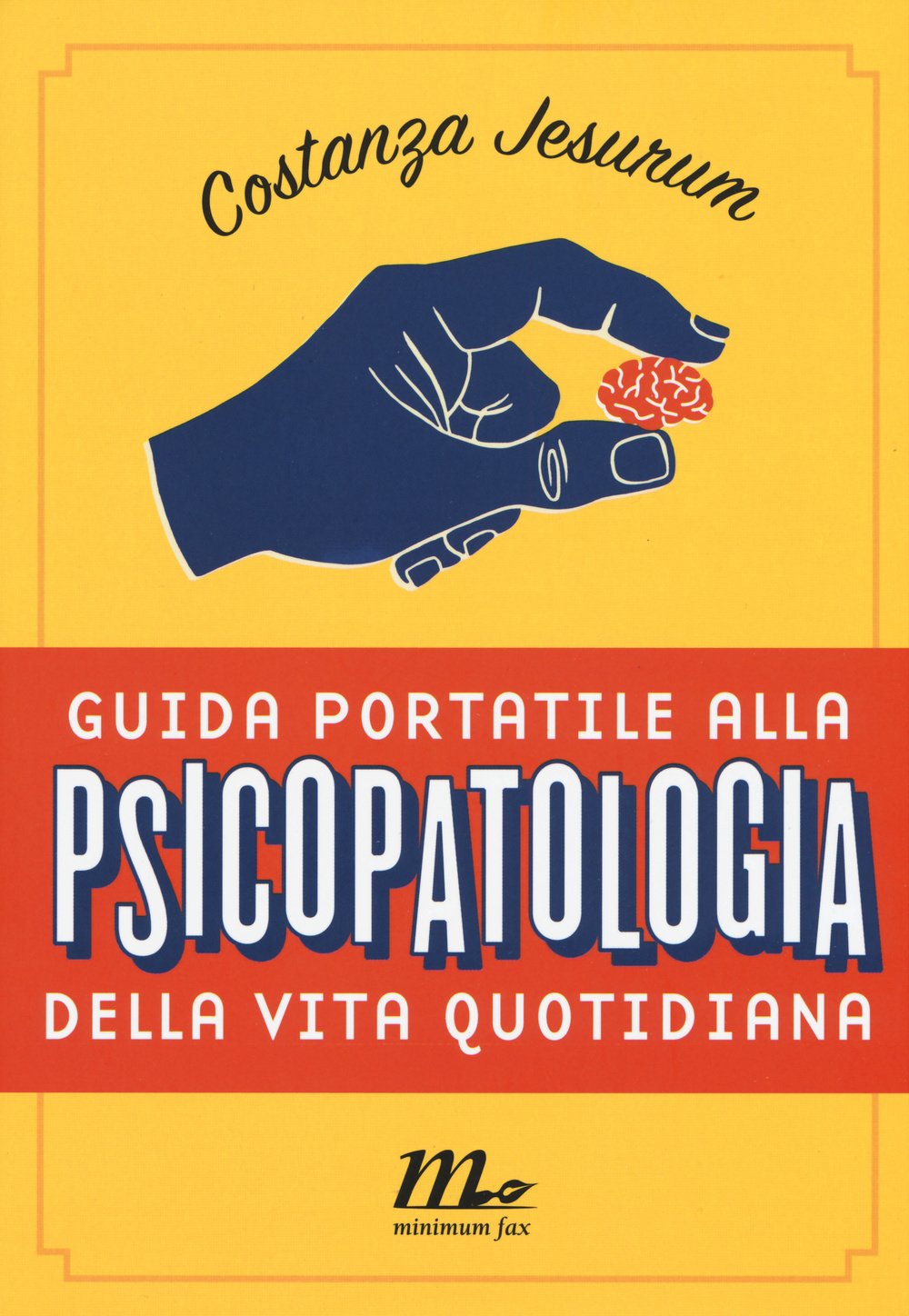
Commento all'articolo