Storia di una bomba – Cinzia Venturoli
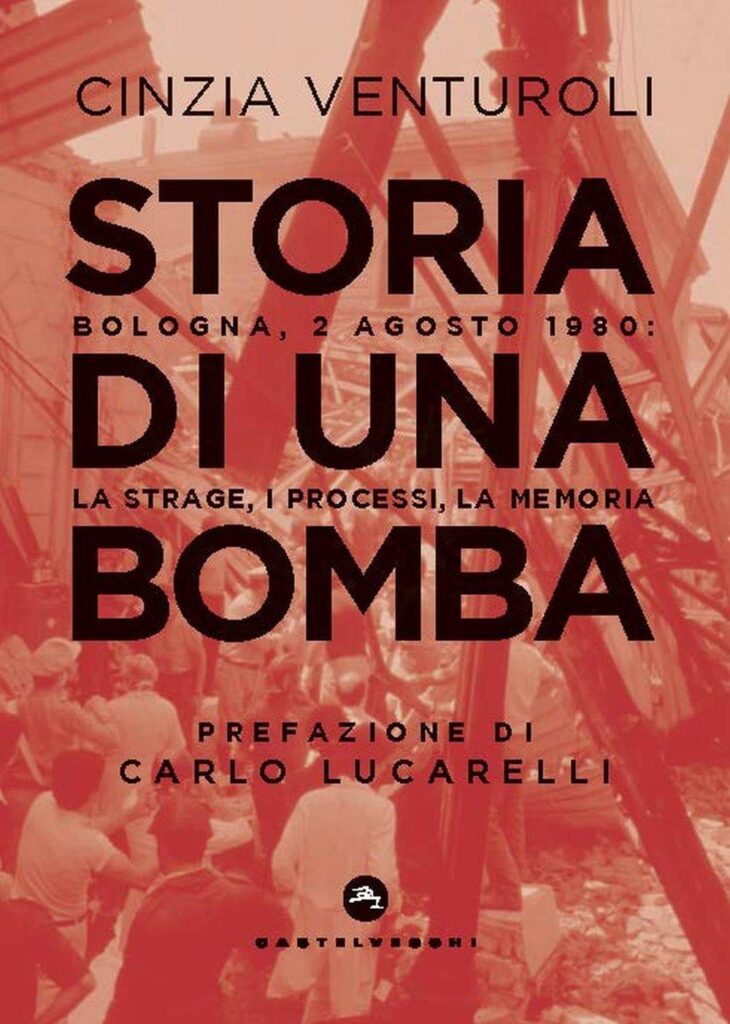
SINTESI DEL LIBRO:
Così Pier Paolo Pasolini scriveva il 14 novembre 1974 sul «Corriere della
Sera», e la strage definita di Bologna altro non era se non la strage
dell’Italicus avvenuta il 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sambro,
località in provincia di Bologna: si può affermare che il 4 agosto 1974 sia
stato l’inizio di un decennio in cui la città di Bologna fu protagonista delle
cronache italiane, e internazionali, per le vicende che la colpirono in
diverso modo: stragi, seppur di diversa matrice, e violenza politica si
susseguirono sul territorio metropolitano o sono state ad esso legate,
caratterizzando e plasmando l’identità della città che ha reagito in modi
simili e a un tempo specifici. Bologna e l’Emilia-Romagna erano state
incluse in progetti eversivi almeno fin dal 1965, quando durante il
convegno La guerra rivoluzionaria organizzato dall’Istituto di studi
militari e strategici Alberto Pollio, secondo l’analisi svolta dai magistrati
che in seguito si occuparono della strage di Bologna, si parlava di reazione
all’«infiltrazione comunista [che] ha raggiunto proporzioni allarmanti.
Una reazione [che] deve avvenire attraverso due metodi paralleli: l’azione
psicologica e il terrorismo, portata avanti senza problemi di natura
morale» attraverso «l’offensiva nelle zone controllate dal nemico come
l’Emilia e la Toscana [e avvalendosi di] gruppi permanenti che diventino
soldati clandestini e accettino la lotta nelle condizioni meno ortodosse e
con la necessaria spregiudicatezza»1.
Il 1974 fu un anno particolarmente significativo: il 12 e il 13 maggio gli
italiani si recarono alle urne per il referendum che confermò la legge sul
divorzio; il 28 maggio alle 10:12 a Brescia una bomba collocata in piazza
della Loggia scoppiò durante una manifestazione antifascista e causò otto
morti e circa cento feriti. In quell’anno finirono due delle dittature di
estrema destra presenti nell’Europa mediterranea, il 25 aprile in
Portogallo e il 24 luglio in Grecia, mentre l’anno successivo, con la morte
di Francisco Franco, anche la Spagna cambiò regime; è datato 1974 anche
il “golpe bianco”, l’ultimo dei piani per un possibile colpo di Stato in
Italia2. Nel settembre 1974 furono arrestati Renato Curcio e Alberto
Franceschini, due dei capi storici delle Brigate Rosse (BR), e,
successivamente, divenne sempre più presente il terrorismo di estrema
sinistra e le BR passarono dalla fase della cosiddetta “propaganda armata”
a quella dell’“attacco al cuore dello Stato”.
La strage dell’Italicus segnò, per molti versi, la fine di una prima fase
della strategia della tensione iniziata nel 19693: in seguito assistiamo a
mutamenti nella politica nazionale e internazionale, registriamo un
mutamento generazionale nei gruppi neofascisti e cambiamenti nelle loro
azioni4 di cui si dirà in seguito, così come accadde nelle strategie di alcune
organizzazioni strettamente legate all’eversione e alle “minacce alla
democrazia” quali la loggia massonica P2. Licio Gelli nel 1975 aveva
ricostruito la P2, Propaganda 2, loggia massonica coperta, i cui membri
cioè non erano conosciuti dagli affiliati ad altre logge, che era diventata
una forza in grado di condizionare il sistema economico e politico italiano.
La scoperta e la pubblicazione nel 1981 degli elenchi degli affiliati e del
programma dell’associazione aprirono un caso politico e giudiziario visto
che la lista includeva 962 nomi, tra cui dirigenti dei servizi segreti italiani,
parlamentari, imprenditori, finanzieri, magistrati, editori e giornalisti;
molto discussi furono anche gli ottimi rapporti che Gelli intraprese con il
generale e presidente argentino Roberto Eduardo Viola e con
l’ammiraglio Emilio Massera durante il periodo della dittatura nel Paese
sudamericano. Secondo le conclusioni della Commissione parlamentare
d’inchiesta presieduta da Tina Anselmi la P2 era una vera e propria
«organizzazione eversiva». La loggia fu sciolta con un’apposita legge nel
1982.
Negli anni successivi al 1974 cominciò una seconda fase di quella che è
stata definita la strategia della tensione, che ebbe la sua conclusione nel
1980.
Nei sei anni che precedettero il 1980 a Bologna si verificarono attentati
di diversa matrice: il 10 maggio 1974 un ordigno danneggiò un palazzo in
via Arnaud in un attentato, rivendicato da Ordine Nero, che, secondo i
periti, non causò morti solo per un caso5. Due giorni dopo la strage
dell’Italicus all’ingresso di una galleria a Calvenzano, frazione di Vergato,
in provincia di Bologna, vennero rinvenuti diciotto chilogrammi di
esplosivo che avrebbero potuto far saltare l’intero tunnel e il giorno dopo
solo l’intervento di un militare evitò l’esplosione di un ordigno nel
commissariato sezionale Due Torri in via Santo Stefano6: entrambi gli
attentati sono attribuibili all’estrema destra7. Il 10 luglio 1976
nell’abitazione di Domenico Bonfiglio, procuratore generale presso la
Corte d’appello di Bologna, venne commesso un attentato firmato Ordine
Nero8 e le Brigate Rosse rivendicarono gli attentati al presidente
dell’associazione industriali nell’aprile 1976, alle auto del cronista de «il
Resto del Carlino» Claudio Santini e a quella di Giuseppe Coliva,
segretario provinciale della Democrazia Cristiana nel gennaio 1977 e, il 31
marzo, all’auto di Antonio Trizzino, presidente del tribunale che il 4 aprile
avrebbe celebrato il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse per una
serie di rapine9. Nel 1974 durante una tentata rapina ad Argelato, in
provincia di Bologna, fu ucciso il carabiniere Lombardini per mano di
alcuni appartenenti all’estrema sinistra. Nel 1978 i Nuclei Comunisti
Armati e altri gruppi quali i Nuclei sconvolti per la sovversione urbana,
fecero attentati e sferrarono attacchi a sedi dei vigili urbani, a
commissariati di polizia e caserme dei carabinieri, a sezioni di partiti, del
PCI in specifico, a negozi e scuole, all’ospedale Sant’Orsola e
all’abitazione del sindaco Renato Zangheri10. Il 4 settembre 1978 fra le
località Vaiano e Vernio venne compiuto un gravissimo attentato
dinamitardo sulla linea ferroviaria Direttissima ai danni di un affollato
convoglio passeggeri: la strage venne evitata perché il treno era stato
deviato su binari adiacenti per consentire alcuni lavori di manutenzione11.
L’anno successivo con la sigla Gatti Selvaggi e in nome di Barbara
Azzaroni e Matteo Caggegi, militanti di Prima Linea uccisi dalla polizia in
un bar di Torino, venne rivendicato un incendio appiccato alla porta
d’ingresso della sede dell’Assostampa, a causa del quale perse la vita
Graziella Fava che lavorava al piano superiore, e furono compiuti altri
attentati contro giornalisti dell’«Avanti!» e de «il Resto del Carlino»12.
A questo breve e, inevitabilmente, incompleto elenco di eventi legati
alla violenza politica e ai terrorismi si deve aggiungere l’uccisione dello
studente di Medicina Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua,
avvenuta l’11 marzo 1977 ad opera delle forze dell’ordine e i fatti di
violenza che ne seguirono e che segnarono profondamente, e a lungo, la
storia della città13. Verso la fine degli anni ’70 si era affacciato un nuovo
movimento studentesco, quello che venne definito il ’77, considerato da
alcuni storici una sorta di conclusione di un lungo ciclo iniziato con le
mobilitazioni collettive del 1968-69. Fenomeno questo esclusivamente
italiano, si inseriva in una situazione politica particolare: al successo
elettorale del PCI nelle elezioni politiche del 1976, quando il partito
ottenne il 34,4%, una percentuale mai toccata prima, era seguita la
costruzione di un governo detto della “non sfiducia”, guidato da
Andreotti e sostenuto dall’astensione di comunisti e socialisti. Il
movimento del ’77, così come era stato per il ’68, nacque per contestare
una proposta di riforma universitaria, in questo caso quella elaborata da
Franco Maria Malfatti: nel dicembre 1976 iniziò l’occupazione
dell’Università palermitana e poi l’agitazione si estese a tutta l’Italia e
coinvolse non solo gli studenti ma anche gli studenti-lavoratori, i precari, i
marginali, i “non garantiti”. La mattina dell’11 marzo alcuni appartenenti
al movimento degli studenti avevano cercato di partecipare a una
assemblea di Comunione e Liberazione che si teneva in un’aula
dell’Istituto di Anatomia in via Irnerio, questo aveva provocato dei
tafferugli ed erano state fatte intervenire le forze dell’ordine: in via
Mascarella, lontano dalla zona in cui stavano avvenendo gli scontri,
furono sparati alcuni colpi di arma da fuoco che colpirono a morte
Lorusso mentre si stava allontanando. Un giovane carabiniere ammise di
avere fatto uso della propria arma e il caso venne definito «legittimo uso
delle armi».
All’uccisione di Francesco Lorusso seguirono tre giorni di scontri e
cortei durissimi che sconvolsero la città. In seguito, i sindacati tennero in
piazza Maggiore una partecipatissima manifestazione unitaria «contro la
violenza» e, contemporaneamente nell’adiacente via Rizzoli, circa
diecimila giovani fecero un sit-in in memoria di Francesco Lorusso dopo
che il suo funerale era stato confinato al cimitero bolognese della Certosa.
Le due dimostrazioni erano tenute separate dal servizio d’ordine dei
sindacati e da militanti del PCI che chiudevano l’ingresso della piazza. I
giovani del movimento, con un lungo corteo, si recarono poi in piazza dei
Martiri dove fece un breve intervento il fratello di Francesco Lorusso a
cui non era stato consentito di parlare in piazza Maggiore. In quei giorni
la città era stata militarizzata con l’intervento di mezzi cingolati che non
solo sgombrarono le barricate erette in zona universitaria, ma rimasero
nelle strade cittadine per qualche tempo, così come i blindati delle forze
dell’ordine. La frattura fra movimento, studenti e amministrazione – e
partito comunista – condizionarono lungamente le dinamiche politiche e
sociali di Bologna.
Il movimento del ’77 aveva posto in primo piano nuove istanze: la
dimensione del privato, la soddisfazione dei bisogni e dei desideri,
l’esaltazione dell’agire spontaneo, l’esigenza di liberare e appropriarsi di
spazi di espressione. L’azione politica divenne ironia e performance
teatrale, non solamente per quella che venne definita l’anima creativa, gli
Indiani metropolitani, ma per tutto il movimento, anche per l’area di
Autonomia, in cui potevano coesistere ironia e violenza; secondo
Grispigni «il movimento era questo, la gioia, la dissacrazione e l’ironia
attraversate dalla desolazione, dalla rabbia, dalla disperazione»14.
L’analisi di vicende così complesse come quelle legate al movimento del
’77 esula, evidentemente, da questo scritto: i cenni che se ne sono dati
servono solo a tentare di ricostruire il clima politico e sociale di quegli
anni in cui anche nell’estrema destra stavano mutando molte cose:
cambiavano i gruppi di riferimento e la loro cultura, nonché si assisteva a
un diversificarsi delle strategie e, in parte, degli obiettivi, mentre le
indagini di alcuni magistrati cominciavano a fare luce sugli attentati
avvenuti in Italia dal 1969.
È stato affermato che fino alla prima metà degli anni ’70 all’interno
della galassia di sigle e movimenti dell’estrema destra vi erano stati
sostanzialmente «tre tronconi: i movimenti filogolpisti, i movimenti
radicali con modalità di azione che oscillavano tra legalità e azioni
terroristiche [di ispirazione evoliana fra i quali spiccavano Ordine Nero e
Avanguardia Nazionale15] e i movimenti di contro-mobilitazione presenti
nelle zone di acuta tensione sociale capaci di attivare appartenenti a
diversi gruppi sociali»16. Gli scritti di Evola, le opere più esoteriche e più
legate alla mistica nazista, all’ideologia e alla vita delle SS avevano avuto
un grande successo per alcuni settori della galassia dell’estrema destra.
Furio Jesi, ponendo la sua attenzione proprio su questa parte del pensiero
neofascista, ipotizzava che alla radice di alcuni atti terroristici, soprattutto
di quelli che parevano più inspiegabili, vi fosse anche una sorta di
“iniziazione” fra l’esoterico e il politico.
Evidentemente le bombe e le stragi hanno avuto ben altra funzione nella vita politica del
paese. Ma è tutt’altro che da escludere che gente mirante a partecipare al mondo attuale
perfino nelle forme più parossistiche, avendo dinanzi agli occhi il modello delle SS e il
miraggio di una razza della Tradizione da ottenere mediante l’imposizione di compiti inutili,
sia stata armata ed adoperata da altri per fini molto meno metafisici. […] è tutt’altro che da
escludere che almeno una parte degli atti terroristici degli ultimi anni siano stati progettati
come compiti inutili da parte degli istruttori, dai didatti della Tradizione, e fatti credere
compiti di per sé utili ai neofiti. Il fatto che progettazione ed esecuzione siano state
presumibilmente favorite e strumentalizzate per altri fini avrà contribuito a suscitare quegli
atti terroristici al momento giusto17.
Nella seconda metà degli anni ’70 nell’estrema destra si andavano
perdendo i riferimenti diretti all’esperienza del fascismo del ventennio e
della Repubblica Sociale, o meglio si mostrava una insofferenza verso la
«retorica della nostalgia»18. Secondo storici e politologi si può affermare
che la nuova destra italiana sia nata nel 1977 con l’organizzazione e
l’inaugurazione l’11 giugno del Campo Hobbit19, il «primo festival di
musica, spettacolo e grafica dell’estrema destra» in cui si coniugava il
modello dei raduni pop ai Littoriali della Cultura, dove si trattava di
«magia, esoterismo, paganesimo, culto della natura e della festa,
fascinazione esercitata dai miti nordici e dall’universo fantastico di
Tolkien»20. Da un lato, una sorta di risposta a esperienze quali il parco
Lambro o il movimento degli Indiani metropolitani, che mettevano in
primo piano la contestazione del conformismo, e dall’altro, la necessità
generazionale e culturale – di rompere con gli aspetti più tradizionali
dell’estrema destra e con l’esperienza storica e fortemente distante come
era giudicata quella dei “vecchi” legati ancora al regime fascista, in un
momento particolare in cui vi furono cambiamenti di stile, di riferimenti,
cercati anche all’estero fin dall’inizio degli anni ’70 con Fuerza Nueva in
Spagna o Ordre Nouveau in Francia, per ribadire «l’appartenenza al
proprio tempo», come afferma Marco Tarchi21.
Nell’area più radicale alcuni dei gruppi storici, come Avanguardia
Nazionale, Ordine Nero, Ordine Nuovo, non esistevano più e, nel
settembre 1975, Stefano delle Chiaie, fra i fondatori di Avanguardia
Nazionale e a lungo latitante in Sud America, pensando a una
riunificazione dei vari tronconi storici di questa destra estrema, affermava
la necessità di agire per «ottenere la disarticolazione del potere colpendo
le cinghie di trasmissione del potere statale»22.
Si faceva, quindi, largo un modo un po’ diverso di vivere la militanza
nell’area neofascista e nacquero nuovi gruppi anche se i contatti, strategici
e operativi, con uomini e leader appartenenti alle precedenti
organizzazioni furono in realtà sempre piuttosto intensi, così come
restarono immutati riferimenti a certi aspetti dell’esperienza del fascismo
mussoliniano.
Proprio in quegli anni riprese corpo l’azione dell’estrema destra, e
nacquero organizzazioni come il Movimento Rivoluzionario Popolare
(MRP), i Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), Terza Posizione (TP) e
Costruiamo l’Azione (CLA)23. In molti si autodefinivano “spontaneisti” e,
secondo il giornalista Sergio Zavoli, lo spontaneismo armato fu «una sorta
di dichiarazione di guerra indiscriminata al sistema borghese con ossessivi
inni all’impegno e alla lotta, al sacrificio e alla morte»24 con una
interpretazione,
fortemente
influenzata
dall’autonarrazione
dei
protagonisti, che rischiava di mettere in ombra la loro matrice politica. Gli
stessi nomi che vennero scelti per designare i nuovi gruppi non erano più
così chiaramente riferibili all’area dell’estrema destra tradizionale, non
avevano ad esempio più riferimenti all’ordine, alla nazione, nemmeno al
colore nero, erano più simili alle sigle presenti nell’estrema sinistra e
riprendevano una tradizione “rivoluzionaria e antiborghese” del primo
fascismo, proponendo, in alcuni casi, un tentativo di rivedere la loro
ideologia andando “oltre la destra e la sinistra”, conservando sempre però
salde radici nel fascismo, nel neofascismo e nell’estrema destra25, radici da
non sottovalutare per la comprensione di quegli eventi storici.
Uno di questi nuovi gruppi, Costruiamo l’Azione, nacque nel 1977
come rivista in cui trovavano spazio diverse componenti che
rispecchiavano sostanzialmente le passate esperienze degli appartenenti al
gruppo che dalla stessa rivista prese vita. Vi erano sia tematiche legate al
passato ordinovista, sia il tentativo di «prestare maggiore attenzione ai
fermenti giovanili; e infine una terza [corrente], che finirà poi per
prevalere, che tendeva al disconoscimento totale di qualsiasi ideologia,
fascista e non»26. Terza Posizione, invece, venne fondata nel 1979 e si
proponeva come movimento rivoluzionario teso alla costruzione di uno
Stato che non fosse né marxista né capitalista, basandosi su quattro punti
principali: la tradizione, l’indipendenza nazionale, l’antimperialismo e la
militanza. Alla fine degli anni ’70 questo gruppo poteva contare su alcune
migliaia di militanti in particolare nelle scuole.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :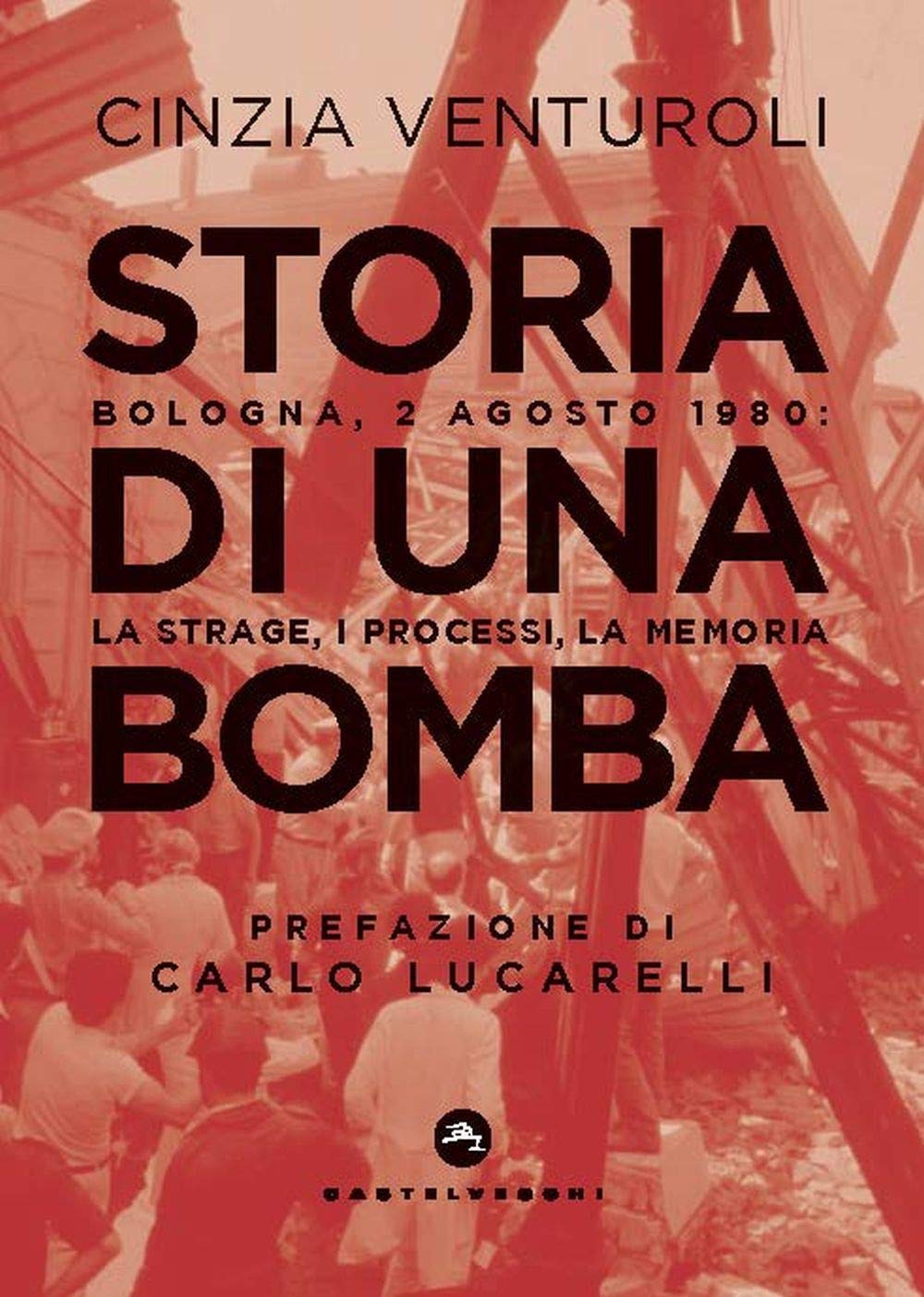






Commento all'articolo