Steve Jobs non abita più qui – Michele Masneri
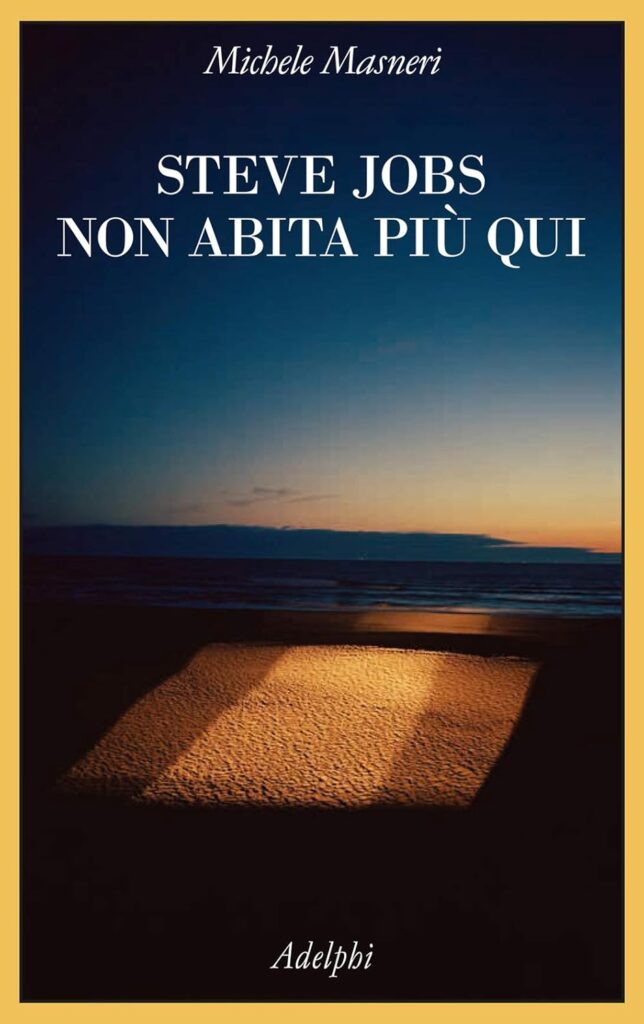
SINTESI DEL LIBRO:
«Prenda qualcosa di caldo, caro» dice una signora con
capello candido, al Whole Foods di California Avenue,
mentre mi servo un po’ di mashed potatoes il giorno dopo
l’elezione di Trump del 2016. A casa, lo psicodramma.
Avevo fatto questo esperimento sociologico, per un mese:
vivere in un co-living, moderna declinazione della comune,
ma qui di ragazzotti col sogno della startup, arrivati da
tutto il mondo per giocarsela a San Francisco; dunque
camerette minuscole a rischio agibilità vicino al Civic
Center, due bagni per dieci persone, uno studentato fuori
tempo massimo.
Nella Casa del Grande Fratello Startupparo oltre a me ci
sono A., ventenne argentina molto simpatica, che studia
diritto internazionale e sta tutto il tempo a parlare con la
f
idanzata che fa la dentista a Mar del Plata, e S., ventenne
ingegnere di Stoccarda con una passione soprattutto
turistica per la Silicon Valley: va a vedere tutti i quartier
generali, di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, non si perde
un garage, di Steve Jobs, di Google, di HP, e fa le sue
stories, soddisfattissimo (si capisce subito che uno dei
business più fruttuosi qui non è la startup, ma il turismo
della startup). Il problema è che i tedeschi la mattina si
svegliano prestissimo e cominciano a rosolare pezzi di
carne e bacon generando una nube tossica tipo Dieselgate.
Al secondo giorno scatta la solita alleanza tra PIGS, cioè
paesi di vari Sud sgangherati ma con diete mediterranee da
poveri ma belli, e con l’argentina spalanchiamo tutto e gli
facciamo il cazziatone.
Con loro, e con gli altri, che disegnano, pitchano o
sognano progetti per future app milionarie, insomma una
meglio gioventù speranzosa e globale, andiamo a vedere lo
spoglio elettorale al SoMa StrEat Food Park, una specie di
Festa dell’Unità sotto un ponte in zona ex industriale che si
sta naturalmente gentrificando a vista d’occhio. Dopo
esserci sfamati con dei dumplings ai food trucks eravamo
moderatamente ottimisti. Guardavamo le proiezioni della
CNN su un maxischermo, con gli Stati che diventavano
rossi e blu senza grandi apprensioni. Certo, c’era stato il
caso di Stephanie, ragazzona americana della Casa, partita
nei giorni precedenti per tornare dai suoi a votare nel
Midwest. Alla domanda col sorriso sulle labbra di noi
startuppari de sinistra: «E quindi voti Trump?», aveva
risposto seria: «Non so ancora», come facevano i
democristiani una volta; a noi si era gelato il sangue, e lei
però aveva spiegato che Hillary proprio no, quella «è una
bugiarda».
il
Intanto, mentre il faccione di Trump con la boccuccia
luminosa come spalmata di lucidalabbra cangiante
appariva nelle schermate della CNN sotto il pannello
altrettanto luminoso di una ditta di materassi – il materasso
è
nuovo oggetto del desiderio, tutti investono in
materassi, anche a rate –, nella nostra Festa dell’Unità
californiana tutti facevamo «boooh», ma crescevano sia
paura che umidità. Qualcuno, pratico: andiamo a comprare
della marijuana biologica (il giorno prima è passato il
referendum). Ma i più seri aspettavano il ritorno di
Stephanie, per capire. Altri presagi: a San Francisco, nei
giorni precedenti, non c’è una macchina una che abbia uno
sticker di Hillary appiccicato: brutto segno nel paese che
utilizza
l’adesivo
automobilistico come medium di
comunicazione preferenziale («Sono cattolico e voto»,
eccetera). Del resto qui è chiaramente considerata una
pericolosa fascistona, e dunque tutti i parafanghi delle
Prius rispettose dell’atmosfera sono per Sanders (ma il
quartier generale di Hillary è accanto al concessionario
Tesla, su Van Ness Avenue, arteriona che taglia in due la
città, e fa un po’ impressione il suo faccione rifratto da quei
cofani lucidi tipo auto di Topolino).
Wishful thinking: andiamo a veder vincere Hillary a mani
basse. Però, venendo da ventenni italiani di vincitori
improbabili e duraturi, ero meno fiducioso. Così poi qui, il
giorno dopo, per loro, il dramma. Day after: città devastata
e attonita. Gli startuppari ricevono messaggi dalle loro
Alma Mater, e mamme, e parenti: «Oggi il rettorato, il
servizio psicologico di facoltà, la palestra rimarranno
aperti». È il 9 novembre 2016, Trump inopinatamente ha
conquistato l’America, la California la prende come
un’offesa personale, o un malanno stagionale: tutti cercano
o offrono qualcosa di caldo. Su Van Ness, il quartier
generale abbandonato, il faccione di Hillary in attesa
d’essere rimosso è crollato a terra.
La Silicon Valley si ribella istericamente: il cofondatore di
LinkedIn, Reid Hoffman, in campagna elettorale si era
offerto di dare in beneficenza cinque milioni di dollari se
Trump si fosse deciso a presentare la sua documentazione
f
iscale. Trump è «la cosa peggiore mai successa nella mia
vita», ha detto Sam Altman, presidente del giga-incubatore
di startup Y Combinator. Dave McClure, il fondatore di 500
Startup: «Se non sei incazzato in questo momento che
problema hai?». Tutti hanno minacciato di emigrare, come
gli
intellettuali
italiani
con
Berlusconi.
Nessuno
naturalmente lo farà (come con Berlusconi, anche, arriva la
negazione: è colpa del sistema elettorale, perché Hillary ha
avuto più voti popolari. È colpa dei russi. Poi, dei social).
Paradossalmente, l’unico ad andarsene dopo un po’ è
Peter Thiel, fondatore di PayPal e colui che ha finanziato
Facebook per primo, facendo un colloquio di lavoro a Mark
Zuckerberg. È l’anima nera della Valle, l’unico ad aver
appoggiato Trump, al grido di: «Sono gay e repubblicano».
Ricompensato con una specie di ruolo di ambasciatore della
Casa Bianca nella Silicon Valley, se n’è stufato subito e ha
sbaraccato insieme al suo chef milanese, che lo nutre in
una dieta micidiale di semi e radici predisposta per farlo
arrivare a centovent’anni (ma non ha ancora trovato una
tinta di capelli efficace). Si è stufato anche della Silicon
Valley, perché dice che ormai è una bolla del pensiero
unico, e ultimamente pure di Trump, per come ha gestito il
coronavirus (è uno che si stufa facilmente).
Nella Valle rimane comunque una leggenda. «Sì, sono
stato a casa sua una volta, a una festa in piscina» mi dice
uno, ma si sa che sono tutte mitologie. Tutti a San
Francisco hanno un aneddoto su Peter Thiel, è come a
Roma «ho lavorato con Fellini, o Woody Allen, ma m’hanno
tagliato al montaggio». Mi decido a un vano tentativo, e un
venerdì sera di gennaio vado a un evento del Seasteading
Institute, la fondazione che costruisce isole artificiali e
sovrane da piazzare in acque internazionali: una delle
creazioni più fantasiose di Thiel, sfrenato libertario seguace
di Ayn Rand, la romanziera-ideologa dei siliconvallici, che
predicava un mondo rustico-primordiale in mano a
un’anarchia dei talenti, e qui da sempre spirito guida.
«Creare isole sovrane e indipendenti non è solo importante.
È assolutamente necessario» ha spiegato Thiel a una
conferenza dell’istituto nel 2009. «Più Stati ci sono, più ci
sarà libertà» ha detto allora, convinto. L’istituto per creare
isole offshore è stato per anni diretto da Patri Friedman,
nipote di Milton, aristocrazia liberista, che però poi ha
mollato ed è tornato a fare il programmatore a Google. È la
realizzazione acquatica del sogno libertario, il simmetrico
idrico dei missili spaziali di Elon Musk.
L’isola sovrana che non c’è doveva già essere pronta nel
2013, poi la cosa è andata a rilento, come talvolta accade
con le grandi opere. Ma adesso ci siamo, dunque mi imbuco
a questa presentazione importantissima: per la prima volta
dalla fondazione il Seasteading Institute firma un accordo
con un paese estero per creare un atollo artificiale. E non
solo artificiale: autosufficiente, alimentato con energia
solare, nutrito con coltivazioni idroponiche e dissetato con
dissalatori. Nello specifico, l’isolotto o atollo sorgerà nella
Polinesia francese, e sarà presente, dice l’invito, il
presidente della Polinesia. Magari, mi dico, ci sarà anche
Thiel. Parto dunque per questo palazzone di vetro, un piano
terra nel quartiere degli affari. Fuori, a fumare, c’è un
signore dall’aria esotica con un gran foulard al collo, e per
il
resto uguale a Roberto Da Crema, quello delle
televendite. Molto ossequiato dai presenti. Dev’essere il
presidente della Polinesia francese, quindi gli vado
incontro. Lui mi porge il biglietto da visita e si presenta.
Dice di essere un certo Jean-Christophe Bouissou, e non è il
presidente. Il presidente infatti non è potuto venire, perché
nella Polinesia francese è in corso un importante cambio di
governo – «Ma non importante quanto qui in America, ah,
ah!» scherza. Non sarà il presidente ma è pur sempre un
ministro, e racconta molto affabile che quando è salito
sull’aereo in Polinesia era responsabile del Turismo, e
quando è atterrato a San Francisco e ha riacceso il telefono
ha appreso di essere stato spostato alle Infrastrutture.
«Che comunque mi sembra una buona carica» riflette
adesso, serio.
Ma dentro: la sala espositiva è una via di mezzo tra un
piccolo Vinitaly e una scuola media privata, ci sono pannelli
su trespoli che spiegano i vantaggi delle isole offshore,
mentre signorine girano con bicchieri di blanc de blancs e
bordeaux. È tipo presentazione con l’autore in certe
librerie con la fissa degli eventi; passano canapè ai
gamberetti e bignè molto lucidi. C’è un pacco di targhette
adesive con la scritta: «Ciao, mi chiamo...»; ti danno anche
un pennarellone blu, tu scrivi il tuo nome sulla targhetta e
te la appiccichi al taschino. Mentre cerco inutilmente tra la
folla la frangetta color mogano di Thiel, socializzo cercando
di stanare anche gli elettori siliconvallici che nel segreto
dell’urna – sostiene Thiel – avrebbero votato in massa per
Trump. C’è uno spilungone di New York in blazer, lavora al
marketing di una startup, ha ricevuto l’invito ed è venuto.
Sei parte dell’élite liberal? «Manco per niente». Allora avrai
votato Trump. «Ma chi, quel disgraziato? Scherzi, io ho
votato Gary Johnson, il candidato libertario». Approfondisco
l’indagine. Ecco Susanna Dokupil, addetta stampa
dell’Istituto delle Isole ed ex presidente della sezione del
Partito repubblicano di Harris County, Texas. Dice: «La
gente era stufa di governi tutti uguali, Trump cambierà le
cose. Trump, in politica, è come Airbnb nel settore del
turismo». Non capisco molto bene la similitudine. Ma lei
l’ha votato? «Ehm, di questo preferirei non parlare».
Insomma, non si trova un elettore di Trump neanche a
pagarlo, però tutti si scambiano molti biglietti da visita, c’è
un signore che si occupa di tubature che si presenta a un
esperto di desalinizzazione. Dei ragazzotti stanno
aggiustando un maxischermo – «Tra poco parlerà il
presidente della Polinesia in collegamento su Skype!» mi
dice il ministro delle Infrastrutture (già del Turismo), con
cui ormai ho fatto amicizia. Ma siccome Skype non parte mi
mischio alla folla. Ecco una coppia di ingegneri, un
francese che si chiama Nicolas Germineau (leggo sulla
targhetta) e un russo che si chiama Egor Ryjikov. Sono
ingegneri dell’istituto appena tornati dalla Polinesia, dicono
che servirà un anno per «creare la legislazione», e poi
almeno tre per costruirlo, l’isolotto. Ma quanto sarà
grande? «Mah, per ora non si sa». E quanto costerà? «Non
possiamo dirlo».
Cerco allora su Google News «Polinesia francese+isola»,
ma escono solo notizie sul grave rimpasto in atto. Un golpe
esotico? Che ne sarà del mio ministro?
Intanto entrano frotte di imbucati. Sei dell’istituto?
«Quale istituto? Io sono amico di Greg. Anche tu sei amico
di Greg?». Ma chi è Greg? Un gruppo di giovani benvestiti,
managerini scesi dalle banche e dagli uffici di venture
capital qui, sono passati chiaramente a scroccare un
bicchiere. Poi ci sono le matte classiche da aperitivo. Una
signora tutta rifatta, con una tuta di pelle aderente nera,
distintivi della NASA e capelli azzurri da fata turchina, mi
avvicina e annuncia d’essere polacca, «amicissima di papa
Wojtyła e anche di Tronchetti Provera» dice con accento e
sembianze da Zsa Zsa Gabor. E poi, molto assertiva: «Senti,
caro, domani se vuoi si va a un lunch, saremo pochissimi,
ma dobbiamo farci trovare pronti a Santa Clara alle dieci di
mattina». Io non capisco, mi sembra presto per una
colazione, anche se a Santa Clara, poi mi rendo conto che
intende launch, e non lunch, e nello specifico, dice
sbrigativa, si lancia il nuovo missile di Elon Musk, l’altro
soggettone della Silicon Valley, che progetta appunto i razzi
per andare su Marte. E però glielo devo far sapere stasera
stessa se vado. Come ci va lei?, le chiedo, per prendere
tempo. Lei dice: con un piccolo Cessna, naturalmente. Poi
mi allunga un biglietto da visita, si chiama Eva Blaisdell,
CEO del California Space Center, un centro di lancio a
Malibu, c’è una sua foto molto buia forse fatta alla
macchinetta, con lei vestita da astronauta e una dicitura:
«Space is the destiny». Mi sembra di essere a un opening
romano, pieno di mitomani anche qui.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo