Spinoza per tutti – Paolo Cristofolini
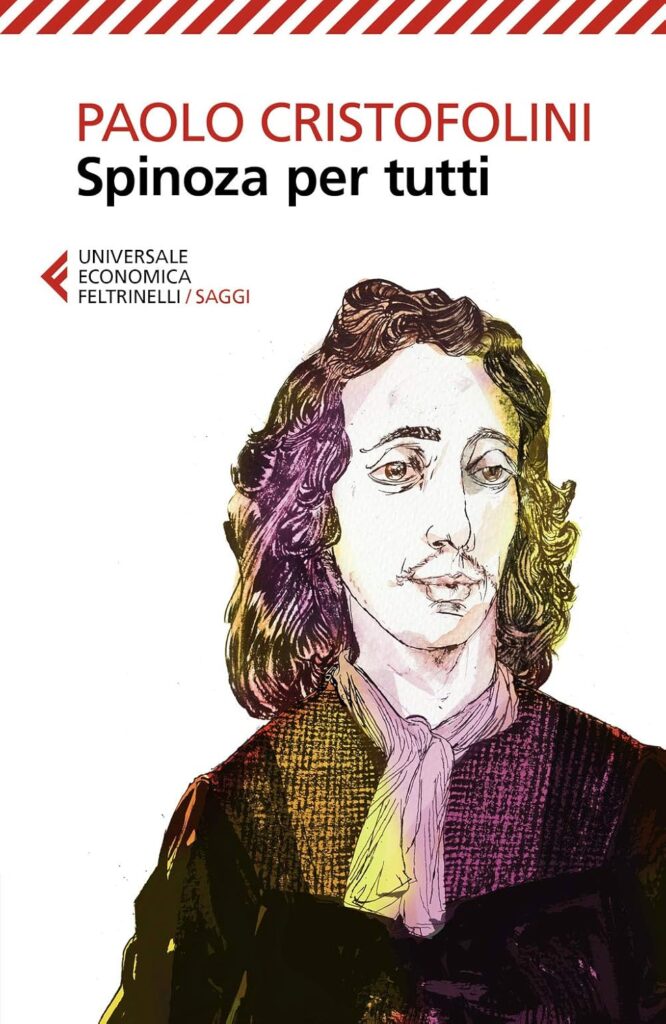
SINTESI DEL LIBRO:
Ognuna delle cinque parti dell’Etica si apre con una breve
prefazione cui seguono, per tutte le parti eccetto la quinta, delle
definizioni, seguite a loro volta da assiomi; dopo queste premesse si
passa alle proposizioni, sempre seguite da dimostrazioni e non di
rado da scoli e corollari.
Le definizioni fondamentali sono quelle fornite nella prima pagina
della parte prima, dove si comincia col definire la causa di sé come
ciò che per sua natura deve esistere. Seguono le definizioni dei
concetti portanti del sistema spinoziano: la sostanza (ciò che è in sé
e che si concepisce per mezzo di sé); l’attributo (quel che l’intelletto
percepisce della sostanza come costitutivo di essa); e il modo
(ovvero le affezioni della sostanza, la cui ragion d’essere è in altro
da sé). In questo primo blocco di definizioni rientrano quelle di finito
e infinito, di cosa libera, di eternità, e di Dio come sostanza infinita
che consta di infiniti attributi.
Questa pagina, della quale abbiamo dato ora un sunto rapido e
non chiarificatore, è la più difficile di tutta l’Etica. Nessuno può
illudersi di comprenderla per poi procedere oltre, ché anzi soltanto
progredendo entro l’intelligenza generale dell’opera si possono
trovare gli strumenti per afferrare tutto il senso di questo esordio. In
altri termini, per comprendere la ragione interna delle definizioni
occorre penetrare nell’organizzazione mentale spinoziana.
La prima domanda da porsi è questa: l’“ordine geometrico”
dell’Etica corrisponde effettivamente all’ordine di esposizione
codificato nei trattati di geometria?
Il modello obbligato di riferimento è dato dagli Elementi di Euclide
che sono nel XVII secolo (e saranno sino ai primi del XX) il testo-base
indiscusso di questa scienza. Proprio negli anni di formazione di
Spinoza un celebre scienziato e filosofo italiano di ispirazione
galileiana, Giovanni Alfonso Borelli, ha riproposto in forma organica il
metodo di Euclide in un libro pubblicato a Pisa nel 1658, Euclides
restitutus (Euclide rinnovato nella traduzione italiana del 1663). Le
sue tesi hanno risonanza europea e Spinoza si trova a discuterne
epistolarmente nel 1663 con l’amico Simon De Vries, che gli scrive
da Amsterdam a nome di tutto un circolo di spinozisti che hanno
probabilmente incontrato di persona il Borelli e propendono per le
sue idee.
La discussione, reperibile nelle lettere VIII e IX delle moderne
edizioni dell’Epistolario, si presenta come particolarmente rilevante,
perché Spinoza risulta dissentire da Borelli e discostarsi dal metodo
di Euclide su un punto essenziale, ovvero sulle definizioni. Borelli,
rigoroso nel suo restauro euclideo, non ammette distinzione fra gli
assiomi e le definizioni. Possiamo illustrare questa posizione con il
solo esempio della definizione della linea retta, che negli Elementi di
Euclide è data come la linea più breve fra due punti: appare chiaro
che questa è al tempo stesso una definizione e un assioma o
postulato. Ma Spinoza procede in maniera diversa: le sue definizioni
precedono gli assiomi e sono ben distinte da essi.
Esse inoltre non sono fra loro concatenate in modo tale da poter
costituire di per sé un corpo organico; e, d’altra parte, le definizioni
spinoziane non dicono tutto della natura della cosa definita. È questo
un fatto che sfugge a molti studiosi, e capita molte volte di leggere
che Spinoza avrebbe iniziato l’Etica col definire Dio come causa di
sé. Basta però vedere le definizioni per rendersi conto che in esse
non è istituito alcun legame necessario tra Dio e la causa di sé, né
tra la sostanza e la causa di sé, e che, stando alle sole definizioni,
non si può nemmeno affermare che Dio, o la sostanza, esistano.
L’esistenza necessaria della sostanza verrà dichiarata e dimostrata
solo alla proposizione 7, e quella di Dio alla proposizione 9: solo
dopo questi passaggi la connessione tra questi termini e quello di
causa di sé sarà da considerarsi istituita.
Ancora: le pagine definitorie delle diverse parti dell’Etica offrono le
definizioni di una parte soltanto dei concetti fondamentali dell’opera.
Vi sono concetti la cui definizione vien data incidentalmente (quella
di individuo, per esempio, è data nel corso di una trattazione
speciale della seconda parte); altri che vengono definiti in più di una
maniera, sempre incidentalmente, in parti diverse dell’opera (per
esempio l’immaginazione, di cui più oltre); altri ancora, come il
conato, o sforzo, che è un concetto-chiave dalla terza parte in poi, e
che non viene definito mai. Ci sono infine tutte le definizioni degli
affetti, che sono date come punto di arrivo di una deduzione,
piuttosto che come punto di partenza.
Si deve con questo dare ragione a quanti ritengono che il metodo
geometrico di Spinoza sia un puro ed estrinseco artificio barocco?
Il problema è ben più complesso e interessante. Noi ci troviamo di
fronte, con Spinoza, a un razionalismo che si ispira, come quello del
suo grande predecessore Cartesio, al modello di rigore e di certezza
rappresentato dalle matematiche, ma che al tempo stesso elabora in
forma nuova una propria dottrina della scienza. Con le definizioni
Spinoza si propone di fornire non il sistema organico dei postulati su
cui la scienza si costituisce, ma quella parte di nozioni comuni a tutti
da cui occorre partire per procedere alla formulazione di leggi
universali.
Si tratta di comprendere come noi arriviamo a queste nozioni
comuni, e alle loro definizioni. Non per deduzione razionale, perché
le definizioni spinoziane (fatta eccezione per le definizioni degli
affetti, come si è detto) sono premessa e non conclusione di
deduzioni. E nemmeno per quella “scienza intuitiva” che
esamineremo nel quarto tracciato, perché il risultato immediato di
questo genere di scienza è la conoscenza non dell’universale, bensì
di cose singole, mentre le definizioni di cui ci occupiamo investono
concetti generalissimi. La difficoltà della prima pagina, che non si
risolve leggendola e rileggendola, ma solo andando avanti fino nel
cuore dell’Etica, sta nella domanda: se non sono, come non sono, il
risultato di una deduzione razionale, da dove provengono alla nostra
mente i concetti che qui si definiscono?
La risposta non si ricava con immediata certezza dal contesto
delle definizioni, ma risulta chiara e semplice una volta che sia
raggiunta la visione d’insieme dell’Etica: vengono dall’intelligenza.
Dobbiamo qui prima di tutto rimandare all’appendice alla parte
quarta, che costituisce la sola zona dell’Etica dove il concetto di
intelligenza è tematizzato. E poi fare presente questa osservazione:
la maggioranza delle definizioni, e tutte le principali (ovvero quelle di
causa di sé, sostanza, attributo, modo, Dio ed eternità come identica
all’esistenza) sono rette dal verbo latino intelligo, non da est;
quest’ultimo verbo regge invece le definizioni degli affetti che,
abbiamo detto, sono di diversa natura in quanto sono risultati,
scoperte di realtà, non premesse.
Le definizioni fondamentali, dunque, sono atti mentali che
precedono il nostro rapporto con l’essere, e sono dovute alla “parte
migliore di noi”, l’intelligenza, come si dice al capitolo XXXII
dell’appendice citata. Da questa appendice ricaviamo che
l’intelligenza è il presupposto della vita vera ed è la vita stessa della
mente (cap. V); grazie a essa noi ricaviamo godimento dalle menti
degli altri uomini, e gli uomini sono, anzi, i soli esseri della cui mente
possiamo godere, stringendo rapporti di società e di amicizia (cap.
XXVI). Col dire che l’intelligenza è la vita della mente, Spinoza ce la
presenta come dimensione della quotidianità; lo scopo più alto
dell’uomo è comprendere adeguatamente tutte le cose che possono
cadere sotto la sua intelligenza (cap. IV), ovvero, al tempo stesso, i
dati dell’esperienza e le riflessioni e le idee di carattere più generale.
Ma col parlare di “cadere sotto l’intelligenza” Spinoza caratterizza
questa potenza umana come capacità di raccolta di elementi sparsi,
piuttosto che come penetrazione sistematica nel senso delle cose.
Più che un intus-legere (“leggere dentro”), l’intelligenza spinoziana
appare come un inter-legere (“scegliere tra”); qualcosa di simile dirà
Vico, con etimologia fantasiosa, per spiegare intelligere con “andar
raccogliendo”.
E così (pur senza il bisogno vichiano dell’etimologia) appare
orientato Spinoza: ciò che intelligo è una vasta raccolta di
conoscenze e pensieri che mi vengono dalla vita della mente e dalla
comunicazione con gli altri uomini, dunque da quella che più in
generale posso chiamare la cultura del mio tempo, con tutto lo
spessore della tradizione che essa incorpora. Da tutto questo mi
vengono quelle parole e i significati in cui le intendo, che danno
luogo alle definizioni.
Qui si completa il primo tracciato. Il “metodo geometrico” si
giustifica in quanto tutta l’Etica consta di una serie di dimostrazioni di
teoremi condotte secondo il principio della coerenza interna e
mediante il rimando, in ultima analisi, alle definizioni e ai postulati. Si
tratta però di un metodo geometrico eterodosso rispetto a quello
euclideo per la separazione dei postulati dalle definizioni: a monte
dei postulati e dei teoremi si raccoglie un blocco di materiali depurati
ma non organizzati, non tanto penetrati dall’intelligenza, quanto
“caduti sotto” di essa nel corso della sua vita.
Ne consegue necessariamente – ancora una volta oltre Euclide
che i concetti definiti in apertura, lungi dall’essere chiari una volta per
tutte ed esauriti nella definizione, sono soggetti a continui
arricchimenti e sovradeterminazioni, a mano a mano che la
trattazione prosegue e il materiale acquista maggiore complessità.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :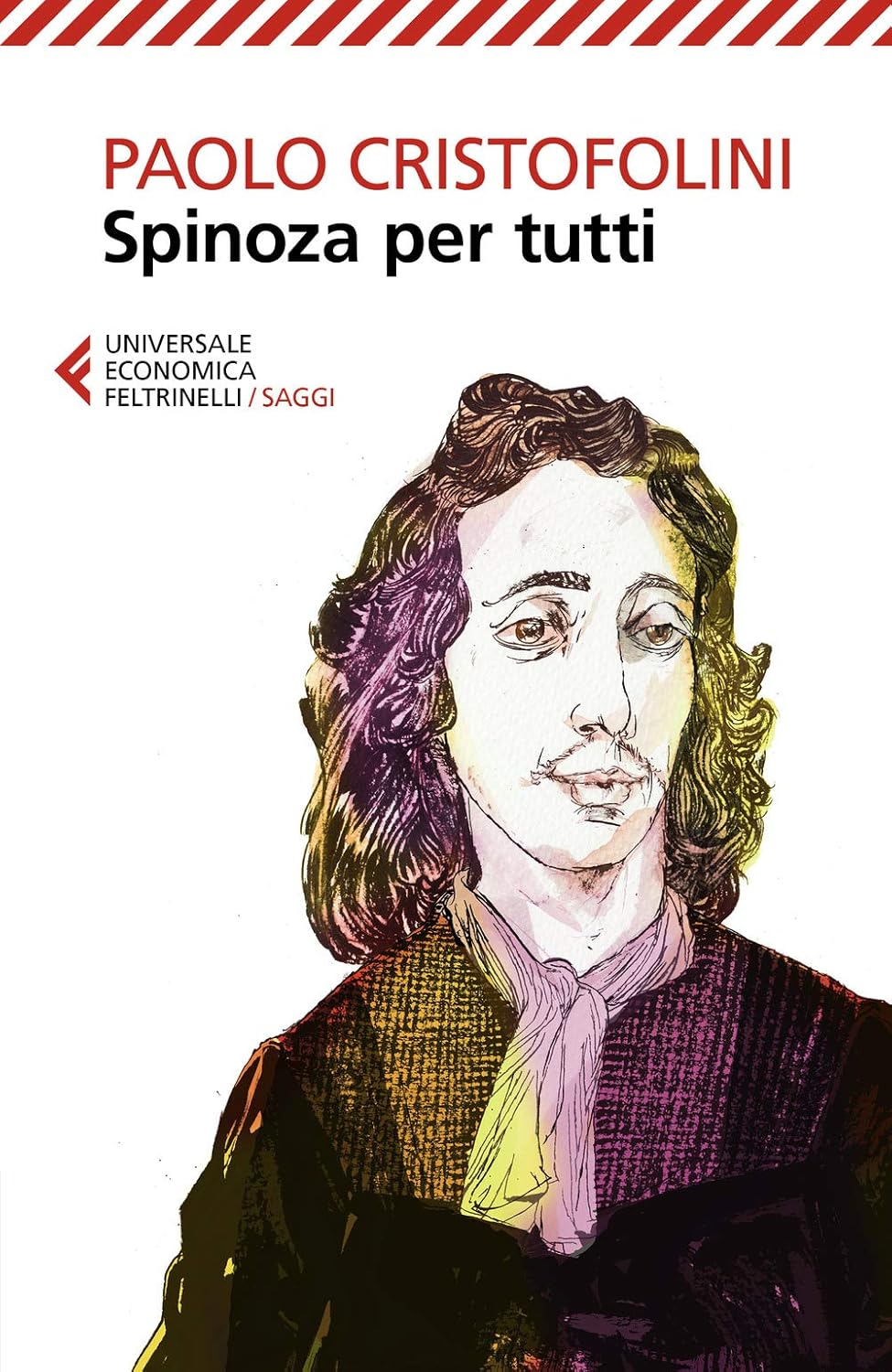






Commento all'articolo