Risacca bretone – Jean-Luc Bannalec
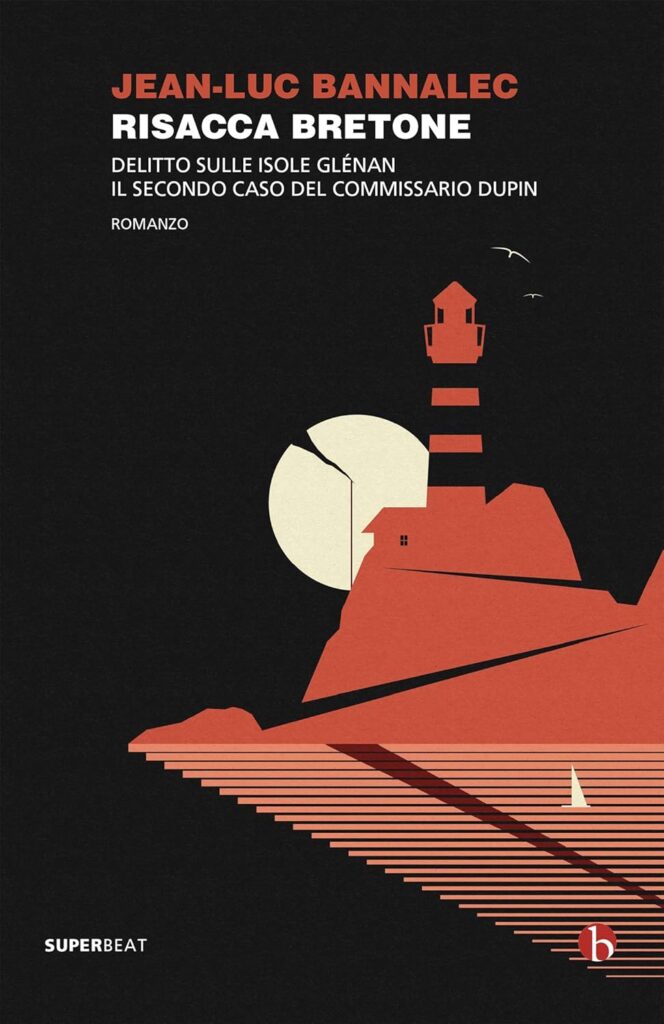
SINTESI DEL LIBRO:
L’arcipelago si stendeva all’orizzonte come un miraggio: le piatte
isole dalla forma allungata apparivano tremule e un po’ sfocate,
fluttuanti in un’atmosfera onirica sul mare iridescente.
Quelle più grandi si riconoscevano già a occhio nudo, identificate
da pochi edifici emblematici: il forte con il suo alone di mistero su
Cigogne, il vecchio faro sferzato dalle tempeste su Penfret, la
cascina abbandonata su Drénec; le quattro case segnate dalle
intemperie su Saint-Nicolas, l’isola principale del suggestivo
arcipelago... Le leggendarie isole Glénan.
A dieci miglia marine c’era il continente, con Concarneau, la “città
blu” della Cornouaille, i cui abitanti consideravano da sempre le isole
le loro “protettrici”, vedendo in esse il proprio orizzonte immutabile.
Dal loro aspetto – a seconda cioè che apparissero nitidamente
delineate o appannate da un velo di nebbia, bene incastonate
nell’acqua oppure eteree e inconsistenti – era possibile prevedere
come sarebbe stato il tempo il giorno seguente e, in certe giornate
particolari, per la rimanente parte dell’anno. Da secoli i bretoni si
ostinavano a discutere sul numero esatto delle isole: sette, nove,
dodici o venti erano le risposte che ricorrevano con maggiore
frequenza. «Sette grandi»: almeno su questo non c’erano dubbi. E
“grandi” significava al massimo qualche centinaio di metri di
lunghezza. In origine erano un’unica isola; poi, a poco a poco,
questa era stata erosa dal mare in burrasca e dal perenne frangersi
dei flutti.
Alcuni anni prima una commissione dipartimentale aveva
ufficialmente decretato – sulla base dei criteri oggettivi di definizione
di un’isola (porzione di terra completamente circondata dalle acque,
stabilmente emersa e dotata di una vegetazione permanente)
l’esistenza di «ventidue tra isole e isolette». All’infuori di queste
esisteva una serie pressoché infinita di faraglioni e gruppi di scogli, il
cui numero variava peraltro in modo considerevole a seconda delle
maree, a loro volta altamente incostanti, influenzate com’erano dalla
posizione del Sole, della Luna e della Terra. Certi giorni il livello del
mare cresceva anche di tre, quattro metri; quando, invece, la bassa
marea raggiungeva i livelli minimi, un’isola poteva apparire più
grande, prolungandosi in un banco di sabbia altrimenti nascosto
sotto la superficie dell’acqua. Non esisteva una “norma”. Così il
paesaggio dell’arcipelago era in continua trasformazione e nessuno
poteva mai dire: «Ecco le Glénan, sono fatte così». Le Glénan non
erano terraferma a tutti gli effetti; erano un indistinto luogo
intermedio: metà terra, metà mare. Durante le furiose bufere
invernali, onde gigantesche si abbattevano sulle isole, e la schiuma
impetuosa del mare inghiottiva ogni cosa. «Praticamente persa nel
nulla, nella distanza infinita»: così veniva descritta, con una formula
poetica ma senza dubbio realistica, l’umanità di quel luogo.
Era un’incantevole mattina di maggio, in tutto identica a una
giornata d’estate, sia per la temperatura elevata, sia per la luce
intensa e i colori vivaci. Anche l’aria era già estiva, più mite, meno
pregna di sale, iodio e alghe, di quella fragranza atlantica così
difficile da descrivere. Già a quell’ora, alle dieci, il sole balenava
inquieto all’orizzonte, dal quale un cono di luce argentata si allargava
progressivamente incontro allo spettatore.
Il
commissario Georges Dupin, del commissariato di polizia di
Concarneau, non prestava molta attenzione a tutto ciò. Quel lunedì
mattina era particolarmente di cattivo umore. Proprio mentre
ordinava il suo terzo caffè all’Amiral, accingendosi alla lettura dei
soliti giornali («Le Monde», «Ouest-France» e «Le Télégramme»), il
suo cellulare lo aveva fatto trasalire con un potente squillo. Alle
Glénan erano stati rinvenuti tre cadaveri. Non si sapeva ancora
nulla; solo questo: tre cadaveri.
Era partito subito e in pochi minuti era a bordo di una motovedetta
della polizia: il suo bar preferito, nel quale cominciavano tutte le sue
giornate, si trovava proprio al porto. Era stato alle Glénan una sola
volta, l’anno prima, a Penfret, l’isola più a est dell’arcipelago.
Stavano viaggiando da venti minuti e avevano percorso circa
metà della distanza; cioè, a suo modo di vedere, ancora troppo
poco: la barca non faceva per lui. Il mare gli piaceva, ma così come
poteva piacere a un classico parigino del VI arrondissement – qual
era stato lui fino al suo “trasferimento”, quasi quattro anni prima
ovvero per la spiaggia, per il paesaggio, tutt’al più per i bagni, i
profumi, l’atmosfera, il relax... Già non amava andare in barca,
figuriamoci in motoscafo! Era su una delle due nuove motovedette
che la guardia costiera aveva ottenuto due anni prima, dopo lunghe
lotte contro la burocrazia, e delle quali andava tanto orgogliosa: di
nuovissima generazione, dei veri gioielli tecnologici, dotati di ogni
sorta di sonde e sensori. Sfrecciavano letteralmente a pelo d’acqua.
Una si chiamava Bir (“freccia” in lingua bretone), l’altra Luc’hed
(“saetta”). Dupin avrebbe scelto dei nomi diversi, ma quello che
contava era il significato.
Inoltre l’ispettore era a corto di caffeina, e quindi irritabile. Due
caffè non erano minimamente sufficienti per un uomo della sua
stazza: non era grasso, ma certamente neanche magro; inoltre, fin
dall’infanzia soffriva di pressione bassissima.
Era salito a bordo controvoglia, giusto per non mostrarsi debole
agli occhi di Riwal, uno dei suoi due giovani ispettori, che lo
ammirava (cosa che, in genere, trovava alquanto seccante).
Piuttosto sarebbe stato disposto a farsi mezz’ora di macchina fino
al piccolo aeroporto di Quimper e a raggiungere le Glénan a bordo
del ridicolo, malfermo elicottero a due posti della centrale di polizia,
benché ci volesse più tempo e volare fosse tutt’altro che di suo
gradimento. Ma il mezzo era già stato prenotato dal suo superiore, il
prefetto, in volo alla volta di Bordeaux – un sonnacchioso paesino
sull’isola di Guernsey, nella Manica – per un “incontro amichevole”
con la prefettura delle Isole del Canale britanniche (Guernsey,
Jersey e Alderney). Il lavoro di squadra della polizia doveva essere
intensificato: questa era la ferma volontà sia da parte inglese sia da
parte francese. Perché «il crimine andava sconfitto, di qualunque
nazionalità esso fosse». Il commissario Dupin trovava il prefetto Lug
Locmariaquer insopportabile e, dopo quasi quattro anni, non era
ancora capace di pronunciarne correttamente il nome (nel
complesso Georges Dupin tendeva a essere – secondo lui a ragion
veduta – piuttosto insofferente nei confronti dell’autorità). Da
settimane riceveva le invadenti, assillanti telefonate del prefetto, «a
caccia di idee» per il suo illustre meeting. Nolwenn, la formidabile
segretaria di Dupin, aveva dovuto eseguire per Locmariaquer una
ricerca sui «casi irrisolti» degli ultimi decenni che potessero
«eventualmente» avere una connessione con le Isole del Canale;
casi che avrebbero «forse» potuto trovare «una soluzione», se allora
ci fosse stata una collaborazione più stretta. Una richiesta assurda,
che aveva provocato le proteste di Nolwenn: non riusciva a capire
perché mai loro «del Sud» dovessero occuparsi del Canale nel
lontano Nord, dove transitavano gli iceberg e dove pioveva tutto
l’anno. Avevano scartabellato in lungo e in largo ma, con grande
rammarico del prefetto, non erano riusciti a trovare un solo caso
significativo.
Il piccolo “incidente” avvenuto sulla barca poco dopo la partenza non
aveva certo migliorato l’umore di Dupin. Aveva fatto quello che solo i
peggiori marinai d’acqua dolce fanno: a quella velocità, con quel
vento teso e con il mare agitato, si era fermato proprio a babordo a
guardare le isole, mentre l’ispettore Riwal e i due membri
dell’equipaggio del Bir si erano saggiamente posizionati a tribordo.
Non era passato molto tempo prima che un’onda immane lo
prendesse in pieno. Ora si ritrovava completamente fradicio: la
giacca, che portava sempre aperta, la polo e i jeans – ovvero la sua
“divisa” da marzo a ottobre – erano incollati al corpo; solo i calzini
erano rimasti asciutti.
Ma, più di tutto, lo rodeva il fatto di non possedere nessun’altra
informazione a parte quell’unica certezza: che, per l’appunto, erano
stati trovati tre cadaveri. E lui non era affatto un tipo paziente.
Kadeg, il suo secondo ispettore, che gli dava sempre del filo da
torcere, era riuscito a comunicargli al telefono soltanto ciò che aveva
appreso dalla voce sconvolta di «un tizio con un forte accento
inglese», che aveva appena chiamato in commissariato. I corpi si
trovavano sulla spiaggia nordorientale di Le Loc’h, l’isola più estesa
dell’arcipelago, intendendo con ciò una lunghezza di quattrocento
metri. Le Loc’h era disabitata, con un monastero diroccato, un
vecchio cimitero, una fabbrica di soda dismessa e un lago simile a
una laguna, principale attrazione dell’isola. Kadeg aveva dovuto
ripetere una dozzina di volte che non aveva nient’altro che quelle
due informazioni: Dupin, di cui era noto l’interesse quasi maniacale
per i dettagli e per i fatti apparentemente insignificanti, lo aveva
assillato con tutte le domande possibili e immaginabili.
Tre morti. Senza che nessuno sapesse niente. In prefettura la
notizia aveva comprensibilmente destato grande scalpore. Era un
evento decisamente inaudito lì nel Finistère, come i Romani avevano
battezzato quella pittoresca terra di confine, che ovviamente per i
Galli e per i Celti – con i quali gli abitanti continuavano peraltro a
identificarsi – era l’esatto opposto: non “finis terrae” ma “Penn ar
Bed”; non la fine bensì, letteralmente, l’inizio, il principio del mondo.
La motovedetta aveva rallentato e ora procedevano a velocità
moderata: il tratto che seguiva era accidentato. In quel punto il
fondale era basso e costellato di appuntiti scogli sommersi o a pelo
d’acqua: la bassa marea costituiva senza dubbio un ulteriore
ostacolo alla navigazione, che in quelle acque era già di per sé
rischiosa e riservata ai capitani più esperti. Il “corridoio” tra Bananec
e il grande banco sabbioso di Penfret era ancora la via d’accesso
meno pericolosa alle Glénan, che conduceva nella Chambre, la
“camera”, come veniva chiamata la porzione di mare più interna
all’arcipelago, che le isole circostanti riparavano dalle tempeste e
dalle correnti. Il valoroso Bir si destreggiò tra gli scogli con alcune
abili manovre, seguendo la rotta per Le Loc’h.
«Non possiamo arrivare fino a riva».
Il capitano, un giovanotto allampanato con un’uniforme high-tech
decisamente larga per lui, aveva gridato dalla sua postazione
rialzata senza guardare nessuno, esclusivamente concentrato sulla
navigazione.
Dupin si sentì male. L’isola distava ancora almeno un centinaio di
metri.
«Marea sigiziale. Coefficiente centosette» gridò ancora al vento
l’ossuto capitano.
Dupin guardò il suo ispettore con aria interrogativa; dopo
l’incidente con l’onda si era tenuto nelle immediate vicinanze degli
altri e non si era più avventurato in giro.
Riwal si accostò all’orecchio di Dupin: nonostante l’imbarcazione
fosse quasi ferma, il rumore dei motori era ancora assordante.
«Abbiamo la massima escursione di marea, commissario. Nei giorni
di marea sigiziale il livello dell’acqua cala ancora di più che con la
normale bassa marea. Non so se lei...».
«So benissimo cos’è una marea sigiziale» lo interruppe Dupin. E
avrebbe voluto aggiungere “Vivo in Bretagna da quasi quattro anni e
ho già visto parecchie maree sigiziali e di quadratura”, ma sapeva
che era inutile. E poi doveva ammettere che, sebbene la storia dei
coefficienti delle maree gli fosse stata spiegata e rispiegata più volte,
non gli era ancora entrata del tutto in testa. Per Riwal, come per tutti
i
bretoni, anche dopo decenni lui avrebbe continuato a essere un
“forestiero” (il che, di per sé, non implicava alcun giudizio negativo),
e un forestiero della peggior specie: un parigino (questo sì che era
grave!). Ogni volta se lo sentiva ripetere daccapo: «Quando la Terra,
la Luna e il Sole risultano allineati, per cui le forze di attrazione
gravitazionale si sommano...»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :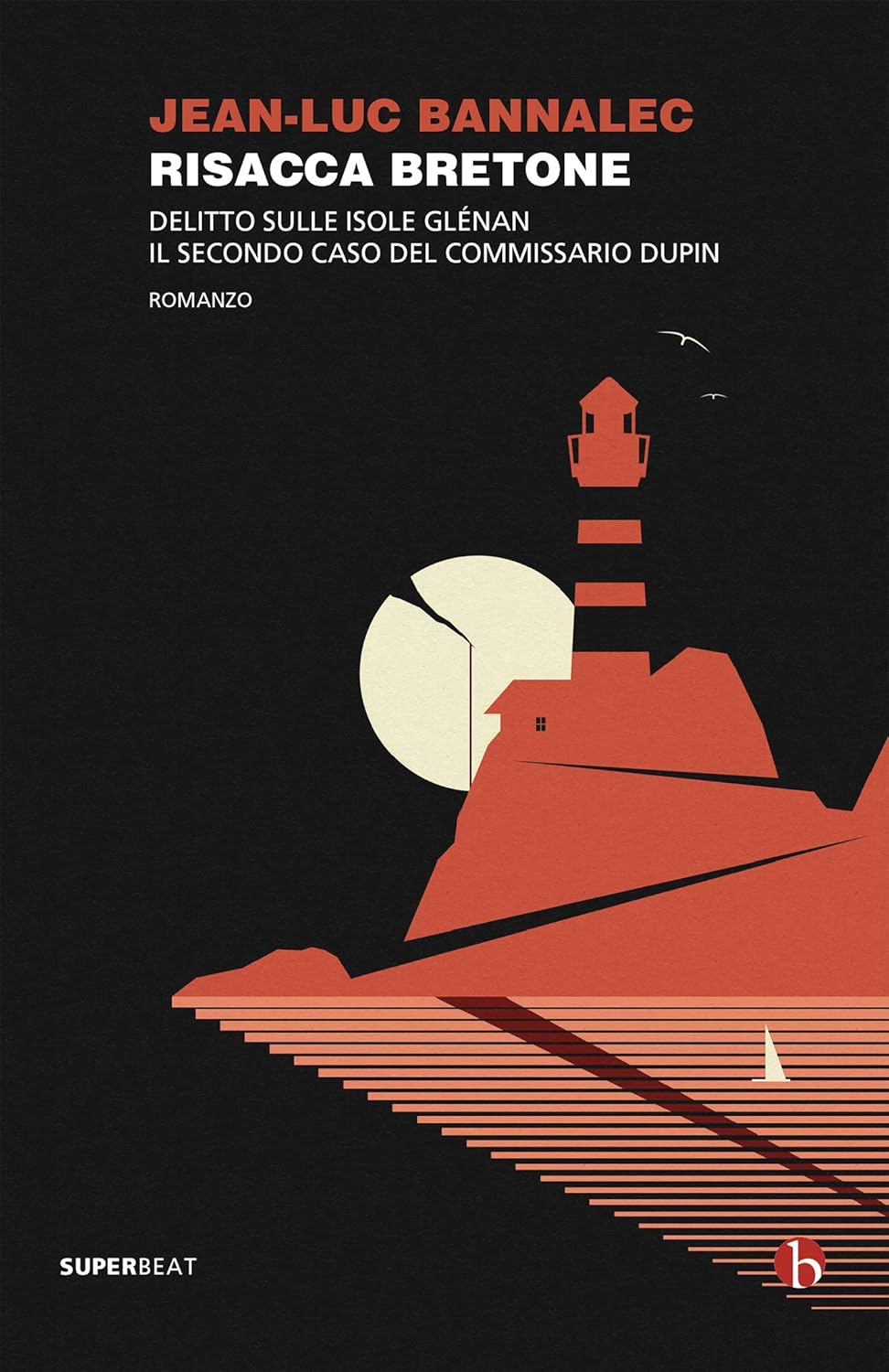






Commento all'articolo