La fine della cultura. Saggio su un secolo in crisi d’identità. Ediz. illustrata – Eric J. Hobsbawm

SINTESI DEL LIBRO:
In realtà, è inappropriato chiedere a uno storico quali caratteristiche avrà la
cultura nel nuovo millennio. Noi siamo esperti del passato. Non ci
interessiamo del futuro, e certamente non del futuro delle arti, che stanno
attraversando l’epoca più rivoluzionaria della loro lunga storia. Ma poiché
non possiamo fare affidamento sui profeti di professione, a dispetto delle
somme astronomiche spese da governi e aziende per le loro previsioni, uno
storico può anche avventurarsi nel campo della futurologia. In fin dei conti,
malgrado tutti gli sconvolgimenti, passato, presente e futuro formano un
continuum indivisibile.
Ciò che caratterizza le arti del nostro secolo è la loro dipendenza da una
rivoluzione tecnologica storicamente unica – in particolare le tecnologie
della comunicazione e della riproducibilità – e la trasformazione che esse
hanno subito in seguito a tale rivoluzione. Quanto alla seconda forza che ha
rivoluzionato la cultura, cioè la società dei consumi di massa, essa è
impensabile senza la rivoluzione tecnologica, per esempio senza il cinema,
la radio, la televisione e i dispositivi portatili per l’ascolto della musica da
tenere nel taschino della camicia. Ma è precisamente questo a non
consentire che poche predizioni generali sul futuro dell’arte come tale. Le
vecchie arti visive, come la pittura e la scultura, sono rimaste fino a non
molto tempo fa puro artigianato; semplicemente, non facevano parte
dell’industrializzazione – di qui, per inciso, la crisi in cui si trovano
oggigiorno. La letteratura, d’altro canto, si è adattata alla riproducibilità
tecnica mezzo millennio fa, ai tempi di Gutenberg. La poesia non va intesa
né come opera destinata a una rappresentazione pubblica (com’era una
volta il caso dell’epica, che di conseguenza scomparve dopo l’invenzione
della stampa) né – per esempio nella letteratura cinese classica – come
opera calligrafica. È soltanto un’unità assemblata meccanicamente con
simboli alfabetici. Dove, quando e come la riceviamo, sulla carta, sullo
schermo o in altro modo, è del tutto irrilevante, una questione secondaria.
Nel frattempo, nel XX secolo e per la prima volta nella storia, la musica
ha sfondato il muro di una comunicazione esclusivamente fisica tra
strumento e orecchio. La stragrande maggioranza dei suoni e dei rumori che
udiamo oggi come esperienza culturale ci raggiunge in maniera indiretta –
riprodotta meccanicamente o trasmessa da una certa distanza. Ciascuna
delle Muse ha avuto una diversa esperienza dell’epoca della riproducibilità
individuata da Walter Benjamin, e affronta il futuro in modo differente.
Lasciatemi perciò cominciare con una breve panoramica delle singole
aree della cultura. In quanto scrittore, mi sia permesso di prendere in esame
innanzitutto la letteratura.
L’umanità nel XXI secolo (diversamente dagli inizi del Novecento) non
sarà più composta principalmente da illetterati. Oggi ci sono solo due aree
del mondo in cui la maggioranza delle persone non sa né leggere né
scrivere: l’Asia meridionale (India, Pakistan e le regioni circostanti) e
l’Africa. Istruzione regolare significa libri e lettori. Un semplice incremento
del 5 per cento del tasso di alfabetizzazione equivale a cinquanta milioni in
più di potenziali lettori, perlomeno di libri di testo. Inoltre, a partire dalla
metà del nostro secolo gran parte della popolazione dei cosiddetti «Paesi
sviluppati» può aspettarsi di ricevere un’istruzione di secondo grado, e
nell’ultimo terzo del secolo una percentuale significativa dei gruppi di età in
questione riceve un’istruzione di livello superiore (attualmente in
Inghilterra la proporzione si aggira intorno a un terzo). I fruitori della
letteratura di ogni genere si sono quindi moltiplicati, e con essi, tra
parentesi, il «pubblico colto» a cui tutte le arti dell’alta cultura occidentale
si sono indirizzate sin dal XVIII secolo. In cifre assolute, questa nuova
audience di lettori continua ad aumentare vertiginosamente. Anche gli
odierni mass media mirano a essa.
Nel film Il paziente inglese, per esempio, la protagonista legge Erodoto, e
subito frotte di inglesi e americani sono corse ad acquistare le opere dello
storico greco antico, che prima, nel migliore dei casi, conoscevano solo di
nome.
Una simile democratizzazione del materiale scritto deve necessariamente
condurre – come nell’Ottocento – a una frammentazione attraverso la
crescita di vecchie e nuove letterature in volgare e – di nuovo come nel XIX
secolo – a una età dell’oro per i traduttori. Del resto, in che altro modo, se
non attraverso le traduzioni, Shakespeare e Dickens, Balzac e i grandi autori
russi avrebbero potuto divenire patrimonio comune della cultura borghese
internazionale? Questo è in parte vero anche ai nostri giorni. Un romanzo di
John le Carré diventa un best seller perché viene regolarmente tradotto in
trenta, se non addirittura cinquanta lingue. Tuttavia, la situazione attuale è
fondamentalmente diversa per due aspetti.
In primo luogo, come sappiamo, per un certo tempo la parola ha dovuto
indietreggiare davanti all’immagine, e la parola scritta e stampata davanti a
quella pronunciata sullo schermo. Fumetti e libri illustrati con testi ridotti al
minimo non sono più ormai destinati solo a principianti che stanno ancora
imparando a compitare. Molto più importante, tuttavia, è la ritirata delle
notizie stampate dinanzi a quelle illustrate o comunicate verbalmente. La
stampa, il principale medium della «sfera pubblica», secondo Habermas,
nel XIX secolo e in buona parte del XX, difficilmente sarà in grado di
mantenere questa posizione nel XXI secolo. In secondo luogo, però,
l’economia e la cultura globali dei nostri giorni necessitano di una lingua
globale per integrare quella locale, e non soltanto per una élite trascurabile
in termini numerici, bensì per strati più ampi della popolazione. Oggi questa
lingua globale è l’inglese, e probabilmente rimarrà tale nel XXI secolo. Una
letteratura specialistica internazionale in inglese si sta già sviluppando. E
questo nuovo inglese-esperanto ha a che vedere con l’inglese letterario non
più di quanto il latino ecclesiastico del Medioevo ne abbia con Virgilio e
Cicerone.
Ma tutto ciò non può arrestare la crescita quantitativa della letteratura,
cioè delle parole stampate, nemmeno quella delle belles lettres. In effetti,
sarei quasi tentato di sostenere che – malgrado tutte le previsioni
pessimistiche – il libro stampato, per tradizione il principale medium della
letteratura, terrà duro senza eccessive difficoltà, con alcune eccezioni, come
le grandi opere di consultazione, vocabolari, dizionari eccetera, ovvero i
prediletti di Internet. Primo, non c’è nulla di più facile e pratico da leggere
del maneggevole e nitidamente stampato volumetto tascabile inventato da
Aldo Manuzio a Venezia nel XVI secolo –, molto più facile e pratico di una
stampata del computer, a sua volta incomparabilmente più semplice da
leggere di un testo tremolante sullo schermo. Cosa che può essere
confermata da chiunque passi un’ora a leggere il medesimo testo dapprima
in forma stampata e poi sullo schermo del computer. Anche l’e-book non
basa le sue pretese su una migliore leggibilità, ma su una maggiore capacità
di memoria e sul fatto di non dover girare pagina.
Secondo, la carta stampata è, finora, più durevole dei media
tecnologicamente più avanzati. La prima edizione dei Dolori del giovane
Werther è leggibile ancora oggi, ma non è per forza così per i testi
elettronici, sia perché – come le vecchie fotocopie e pellicole – hanno solo
una vita limitata, sia perché la tecnologia diventa obsoleta così rapidamente
che i computer più recenti semplicemente non sono più in grado di leggerli.
Il progresso trionfale del computer non eliminerà il libro, così come non ci
sono riusciti il cinema, la radio, la televisione e altre innovazioni
tecnologiche.
La seconda tra le belle arti che se la cava bene ancora oggi, e continuerà
a farlo nel XXI secolo, è l’architettura. Questo perché l’umanità non può
vivere senza edifici. I quadri sono un lusso, ma le case una necessità. Chi
progetta e realizza edifici, dove, come, con quali materiali, in quale stile,
che sia un architetto, un ingegnere o un computer… tutto questo
probabilmente cambierà, ma non l’esigenza di creare edifici. Anzi, si può
persino affermare che nel corso del XX secolo l’architetto, in particolare
quello di grandi edifici pubblici, sia divenuto il re del mondo delle belle
arti. È lui – in genere è sempre un «lui» – a trovare l’espressione più
consona, cioè la più costosa e imponente, alla megalomania della ricchezza
e del potere, nonché del nazionalismo. (Dopotutto, la regione basca ha
appena commissionato a una star internazionale la realizzazione di un
simbolo nazionale, ossia un museo d’arte a Bilbao, che ospiterà un altro
simbolo nazionale, Guernica di Picasso, benché a dire il vero Picasso non
l’abbia dipinto come un esempio di arte regionale basca.)
È abbastanza certo che tale tendenza proseguirà nel nuovo millennio.
Oggi Kuala Lumpur e Shanghai stanno già dimostrando di meritare in
prospettiva il diritto a uno status economico internazionale con nuovi record
di altezza dei grattacieli, e la Germania riunificata sta trasformando la sua
nuova capitale in un gigantesco cantiere. Ma di che tipo saranno le
costruzioni destinate a diventare i simboli del XXI secolo? Una cosa è
indubbia: saranno di grandi dimensioni. Nell’epoca delle masse, ci sono
minori probabilità che siano sedi di governo, o di grandi società
internazionali, sebbene queste ultime continuino a dare il loro nome ai
grattacieli. Quasi sicuramente si tratterà di edifici o di complessi di edifici
aperti al pubblico. Prima dell’età borghese, almeno in Occidente, erano le
chiese. Nell’Ottocento, almeno nelle città, in genere erano i teatri lirici, le
cattedrali della borghesia, e le stazioni ferroviarie, quelle del progresso
tecnologico. (Varrebbe la pena studiare un giorno perché, nella seconda
metà del Novecento, la monumentalità abbia smesso di essere una
caratteristica delle stazioni ferroviarie e dei loro successori, gli aeroporti.
Può darsi che un domani ritorni a esserlo.) Alla fine del nostro millennio, vi
sono tre tipi di edifici o di complessi idonei a divenire i nuovi simboli della
sfera pubblica: primo, i grandi stadi e palazzetti destinati allo sport e allo
spettacolo; secondo, gli hotel internazionali; e terzo, il più recente di questi
sviluppi, le enormi strutture chiuse che ospitano i nuovi centri commerciali
e ricreativi. Se dovessi scommettere su uno di questi cavalli, punterei su
palazzetti e stadi. Ma se mi chiedete quanto durerà la moda che imperversa
sin dalla costruzione del teatro dell’opera di Sydney, cioè quella di
progettare questi edifici in forme inaspettate e bizzarre, non vi posso dare
una risposta.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
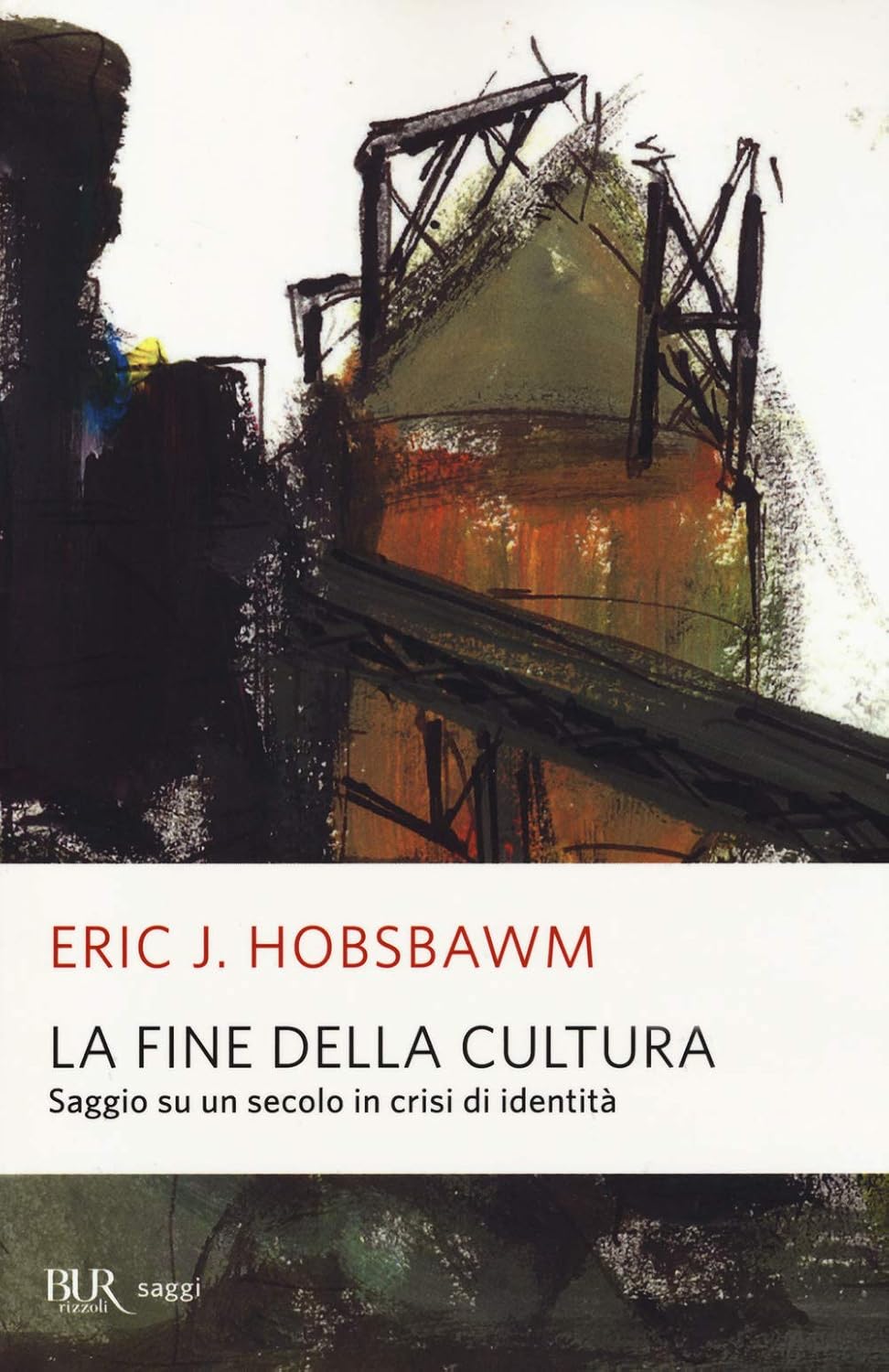






Commento all'articolo