Passaggi segreti – Federico Pace
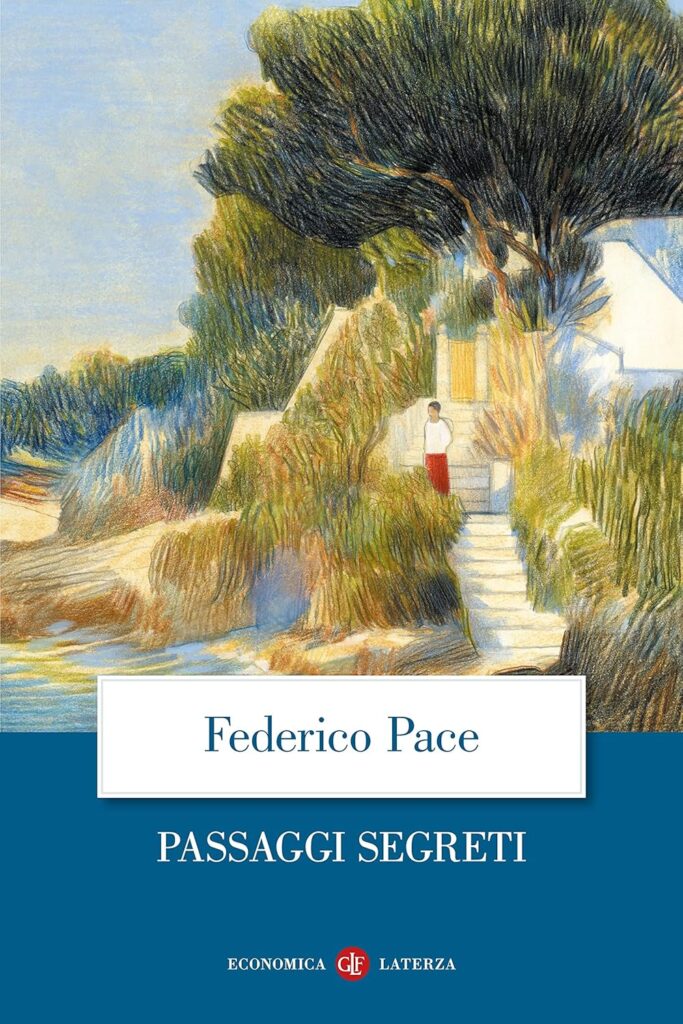
SINTESI DEL LIBRO:
Fu un invito a cena, un gesto di cortesia e familiarità, a mettere in moto
un viaggio tra i boschi e i monti. Partii da San Martino di Castrozza, nella
Valle di Primiero, dove ero arrivato da pochi giorni. Per giungere a
Predazzo, lì dove ero stato invitato, avrei dovuto prendere la provinciale
50 attraverso le abetaie e seguendo infiniti sali e scendi. Mi mossi con un
po’ di ritardo, con apprensione, come quasi sempre mi accade, per colpa
del tempo che compie passi così più rapidi dei miei. Non avevo mai
percorso la provinciale in quel tratto e con l’auto mi inoltrai, ignaro di
quel che mi attendeva, come non possiamo che essere in ogni istante della
nostra esistenza, lungo le curve, le salite e attraverso l’aria leggera che, con
il finestrino tirato giù, respiravo come si fa con una prelibatezza che per
lungo tempo ci è stata proibita. Era tutto il giorno che osservavo il Cimon
della Pala. Prima che il sole gli sorgesse alle spalle, l’avevo veduto cupo,
annerito, pietroso e pesante, con il piccolo grumo di luci gialle delle case
che gli stava accovacciato ai piedi. E poi, proprio poco prima di partire,
l’avevo visto quasi addolcirsi e divenire rosato. Quasi effimero, leggero,
apparentemente composto di quel di cui sono composte le nubi.
Impalpabile e seducente. Senza neppure sapere ancora delle arenarie di
colore rosso, dei calcari grigi che, depositandosi silenziosamente centinaia
di milioni di anni prima, avevano dato vita a quelle forme. Nulla
sembrava altrettanto mutevole e vivo.
Dal basso immaginavo il vento che stava scuotendo l’altopiano delle
Pale, il battito dell’aria sul tavolato enorme che si distendeva
misteriosamente proprio lassù, oltre i duemila e cinquecento metri. I
luoghi e quel che significano per noi. Gli spazi che abitiamo, che
visitiamo e i modi con cui alimentano, misteriosamente, la nostra
immaginazione. Sempre ci perdiamo fortunatamente dietro qualcosa, un
pensiero, un’evocazione. Nell’uscire da San Martino, la provinciale mi
concedeva ancora di rivolgere lo sguardo a quella catena montuosa.
Ipnotica. Incantatoria. Sublime e terribile. Cimon della Pala, Dente del
Cimone, Rosetta, Pala di San Martino. Ripetevo, quasi come una
cantilena, i nomi di quelle dentature montuose che circondavano le case,
silenziose e accovacciate. E poi Vezzana e Bureloni. Le ripetevo come un
insegnante giovanissimo, appena giunto in una classe, cerca di rimandare
a memoria i nomi di quei volti dei ragazzi che ha appena incontrato e
cerca di capire il prima possibile la loro intima natura. Per non fare errori.
Per non sbagliare anche questa volta. E, come un giovane docente, ero
caduto anche io già in una specie di simpatia a prima vista per qualcuno di
loro, per il Cimon della Pala, prima ancora di conoscerne la storia. Prima
ancora di saper nulla di quel che aveva dovuto passare.
Ogni volta che lo volgevo verso l’alto, verso la distesa di quella catena
montuosa, lo sguardo finiva quasi sempre per andare a cercare le linee del
Cimon. Mi rammentavo di un’amica che quelle cime le fotografava dalla
pianura, che cercava di continuare a vederle anche quando era dovuta
tornare a Venezia. È più facile cadere nella malia dell’incanto, pensavo,
che liberarsene. Mentre seguivo le linee che s’aprivano nella strada, come
crepe, come fenditure, forse per il freddo dell’inverno, per l’incuria,
superai le ultime abitazioni del paese. Il legno, il bianco, i tetti acuminati.
I tappeti stesi sulle ringhiere dei balconi. Uno, due, tre ciclisti, che
ostinati nelle loro curve schiene spingevano sui pedali. Risalire la vetta.
Andare più in alto. La foga, il desiderio. Poi svoltai seguendo la freccia
che indicava Passo Rolle. Fu così rapido il piegarsi della strada, il girare su
se stessa, l’inerpicarsi, che quasi mi sorprese poi l’inoltrarmi già nei
boschi. Attraverso il cruscotto, mi venivano incontro gli abeti, rapidi,
pensosi e frementi, per mostrarmi le loro punte aguzze mentre venivano
lambite dalla luce del sole radente e le radici se ne stavano nel fondo
precipitoso, cupo, umido e scosceso della montagna.
A invitarmi a cena era stata una coppia di amici, Giovanni e Luisa, che
proprio in quei giorni erano stati attirati fino a Predazzo, fino a quel
cumulo di case che stava dall’altra parte della valle proprio nel cuore della
Val di Fiemme, da un’improvvisa relazione d’amore che era nata tra il
proprio figlio, poco più che diciottenne, e una ragazza del luogo. Lui
altissimo, ciondolante, interrogativo. Lei piccolina, esile e gentilissima. I
primi incontri. Gli inganni e gli incanti. L’attrazione, l’incomprensione e
la seduzione. I due giovani si erano appena veduti qualche volta e
ciascuno sembrava contenere dentro di sé proprio quello che desiderava ci
fosse dentro l’altra. Era l’anelito che prima o poi scuote ciascuno di noi,
era il desiderio di quel che non riusciamo a raggiungere, quel che di
prezioso sembra in serbo per noi ma sta nascosto nel corpo e nella mente
di un’altra persona che ancora non conosciamo e non sappiamo se, nel
breve arco della vita, riusciremo a trovare. Non sappiamo ancora, o forse
non sapremo mai, se dovremo, invece, accontentarci, inconsapevolmente,
della illusione di averla trovata.
Senza certezze, senza convinzioni, forse meravigliati da quella stessa
meraviglia, forse abbacinati dallo splendore dei luoghi, dal mistero dei
boschi, dalla vasta profondità del cielo, dall’odore del legno, dalla
freschezza delle lenzuola delle stanze degli alberghi accovacciati ai piedi
delle Dolomiti, o forse preoccupati da quell’anelito che ci spinge a cercare
qualcosa nell’altra, i genitori avevano seguito il loro altissimo e
ciondolante figliolo fino a Predazzo. Sempre i genitori finiscono per
seguire i propri figli. Sempre cercano di anticipare i passi che compiranno
le proprie creature. Fino a che possono. Fino a che, a loro volta, i passi dei
loro figli diventeranno così ampi che i genitori, anche loro creature di
altri genitori, non potranno fare altro che lasciarli andare.
Avevo ancora, negli occhi della mente, l’eco dello splendore rosato,
incantevole, ipnotico del Cimon della Pala, mentre salivo, curva dopo
curva, tra l’odore verde dei prati, l’umido del bosco e la tentazione che
esercitavano le fughe delle stradine in terra battuta che quasi a ogni curva,
che si piegava a gomito, dipartivano per inoltrarsi nel denso del bosco. Lo
strano mistero della luce che filtrava tra le ramificazioni. Il bosco è uno
spazio che meraviglia per ciò che è, ma anche per quel qualcos’altro a cui
allude e rimanda, per ciò che intende sempre celare. A ogni passo si ha la
percezione di arrivare più vicino, di stare per intravedere quel che viene
tenuto nascosto. Si intuisce la possibilità di raggiungere il luogo da cui
arriva la luce. O il nucleo stesso del bosco, lo spazio segreto, il centro più
profondo. Quel che l’altro sembra contenere dentro di sé. Ma più si
avanza e più il bosco ricrea se stesso, si perde, si dirada, si infittisce e si
ostina ad allontanare i confini del proprio limitare. Quanto più lo
inseguiamo, quel confine, e tanto più il bosco relega quel che c’è al di là,
ancora più in là. Infine scompare, quasi spaventato. Infine s’arresta,
d’improvviso, davanti alle case, alle strade, alle prime voci degli uomini, al
voltare di una curva.
Giravo e rigiravo. E la strada era una lingua che serpeggiava tra
l’inclinarsi delle vette. Saliva. E gli abeti, da una parte e dall’altra, stavano
con le radici aggrappati alla terra per non scivolare via. Ogni tanto anche
la strada pareva prendere un po’ di respiro e si lasciava andare quasi
pianeggiando, come se volesse lasciar guardare chi guidava, con maggiore
attenzione, gli abeti nella loro altezza mentre svettavano precipitosamente
verso l’alto. Passai sul rio Marmor. Un secco greto fatto di pietre. Più
andavo e più gli abeti sembravano avvicinarsi al ciglio della strada, quasi a
voler ricreare la fitta trama del bosco, nonostante l’auto, nonostante la
velocità. Lo stormo delle punte aguzze degli abeti che si sospingevano
tutte insieme verso l’alto davano l’illusione che il nutrimento, che dava
loro modo di crescere, non arrivasse dal profondo, dalla umidità
sotterranea delle proprie radici, quanto piuttosto dal cielo, da quel che li
attirava verso l’alto.
M’era tornato in mente così, a cospetto di quegli abeti, di quando, da
piccolo, molto più piccolo del figlio altissimo e interrogativo di Giovanni,
mi arrampicavo sugli alberi. Un ricordo che avevo rimosso del tutto dalla
memoria. Accade così. Gran parte di quel che abbiamo vissuto non
rammentiamo neppure di averlo vissuto. E per lo più ci sembra naturale
che quel fiume di giorni, una volta attraversato, fluisca nel mare della
dimenticanza. Solo a tratti ci viene concesso di riavvicinarci a quel che più
di ogni altra cosa ci è appartenuto. Ero così piccolo che forse neppure
arrivavo al ripiano del tavolo. Guidavo e risentivo sulla pelle, per la prima
volta, l’eccitazione e l’ebbrezza di quelle imprese solitarie e inebrianti.
L’arrampicata come una questione che aveva a che fare soprattutto con il
corpo. Arrampicarsi era una gioia, uno sfogo. Una rabbia. Un anelito
animalesco, antichissimo e primordiale, di cui nessuno era partecipe.
L’impresa a cui mi accingevo lontano da tutti. Dapprima con le mani
cercavo il ramo più vicino, quello a cui arrivavo appena e che mi
permetteva di staccarmi da terra. Già dopo quel primo passo, dopo aver
afferrato un braccio vegetale, ero in una dimensione diversa. E allora
salivo di ramo in ramo. Con una perizia sconosciuta, con una lentezza
che si alternava a gesti rapidissimi. Il timore di cadere, il fitto e articolato
mondo che dipartiva dal tronco e si sospingeva orizzontalmente verso
l’esterno in ricami e giravolte.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :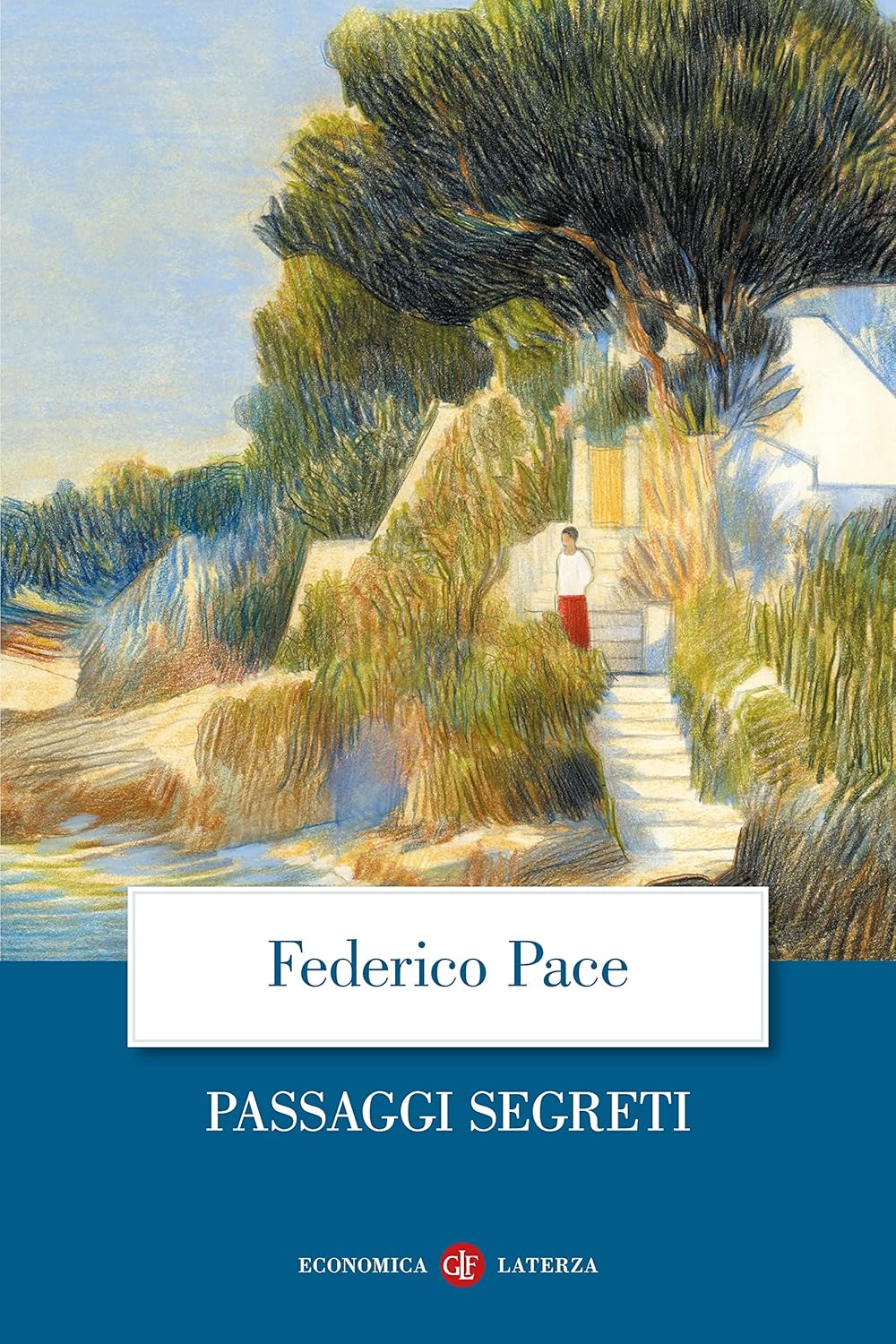






Commento all'articolo