Parole chiave – Jean Baudrillard

SINTESI DEL LIBRO:
L’oggetto sarebbe stata per me la “parola chiave” per eccellenza. Fin
dall’inizio, ho scelto questo termine perché volevo svincolarmi dalla
problematica del soggetto. La trattazione dell’oggetto rappresentava
l’alternativa e, allo stesso tempo, apparteneva al mio orizzonte di
ri essione. Vi erano anche delle ragioni legate all’epoca: negli anni
Sessanta, il passaggio del primato dalla produzione a quello del
consumo ha posto in primo piano il valore degli oggetti. Tuttavia, ciò
che mi interessava veramente non era tanto l’oggetto fabbricato,
prodotto, creato, ma ciò che gli oggetti “si dicono” gli uni con gli
altri, il sistema segnico e la sintassi che esprimevano. E, soprattutto, il
fatto che essi rinviavano ad un mondo meno reale di quello che
poteva lasciar credere apparentemente la legge del consumo e del
pro tto. Ero convinto che in questo mondo di segni, gli oggetti
fuggissero troppo presto dal loro valore d’uso, per entrare in gioco tra
di loro, per corrispondersi.
Dietro questa interpretazione semiologica, senza dubbio si trovava
una reminiscenza della Nausea di Sartre e di quella di usa
concezione (la famosa radice
1
) [Cors. d.C.] che fa dell’oggetto un
qualcosa di ossessivo, una sostanza velenosa... Mi sembrava che
l’oggetto fosse quasi dotato di passione o, almeno, che potesse avere
una vita propria, uscire dal suo ruolo passivo per acquisire una sorta
di autonomia e forse anche la capacità di vendicarsi su un soggetto
n troppo sicuro di poterlo dominare. Gli oggetti sono sempre stati
considerati come un universo inerte e muto, di cui si dispone
impunemente col pretesto di averlo prodotto. Ma questo universo
per me aveva qualcosa da dire, qualcosa che andava ben al di là del
suo uso puro e semplice. Esso entrava nel regno dei segni dove nulla
accade per caso, poiché il segno rappresenta sempre la negazione
della cosa, la sua eliminazione o sovrapposizione L’oggetto designava
dunque il mondo reale, ma anche la sua assenza – e in particolare
quella del soggetto.
Ciò che ha suscitato il mio interesse è proprio la dimensione
polimorfa degli oggetti. Per a rontare questo argomento ho applicato
tutte quelle discipline che in quel periodo erano di moda: la
psicoanalisi, l’analisi marxista della produzione e, soprattutto,
2
sull’esempio di Barthes
,
l’analisi linguistica. Ma lo studio
dell’oggetto esigeva di passare contemporaneamente attraverso tutte
quelle discipline, imponendo trasversalità, dato che, giustamente,
esso non era riconducibile a nessuna scienza particolare ma, anzi, le
metteva tutte a nudo rendendole enigmatiche, aiutandole a porre in
discussione i loro stessi postulati – compresi quelli della semiologia,
dove l’oggettosegno, nel quale conuiscono molteplici tipi di valori, è
molto più ambiguo del segno linguistico.
Nonostante questi approcci portassero a di erenti conclusioni, ciò
che mi appassionava e, mi appassiona tutt’oggi, è il modo in cui
l’oggetto evade, si assenta – tutto ciò che esiste in lui d’“inquietante
estraneità”. Lo scambio di cui esso è il supporto resta inappagato.
Esso è certamente mediatore, ma, a causa del suo essere sempre
immediato e immanente, infrange la mediazione. L’oggetto si pone
contemporaneamente su due versanti: quello appagante e quello
ingannevole; esso verosimilmente prende le mosse da quella “parte
3
maledetta”, di cui parlava Bataille
,
parte che non sarà mai salvata,
mai riscattata. Non esiste la Redenzione dell’oggetto; in qualche
luogo c’è un “avanzo”, di cui il soggetto non può impossessarsi,
poiché esso crede di dissimulare tutto ciò attraverso la
sovrabbondanza, l’accumulo e la ridondanza, ma così facendo non
provoca altro che ulteriori ostacoli alla relazione. In un primo tempo
si comunica attraverso gli oggetti, poi la loro proliferazione
interrompe questa comunicazione. L’oggetto ha un ruolo
drammatico: è un attore a pieno diritto in quanto elude ogni
semplice funzione. In ciò sta il suo fascino.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




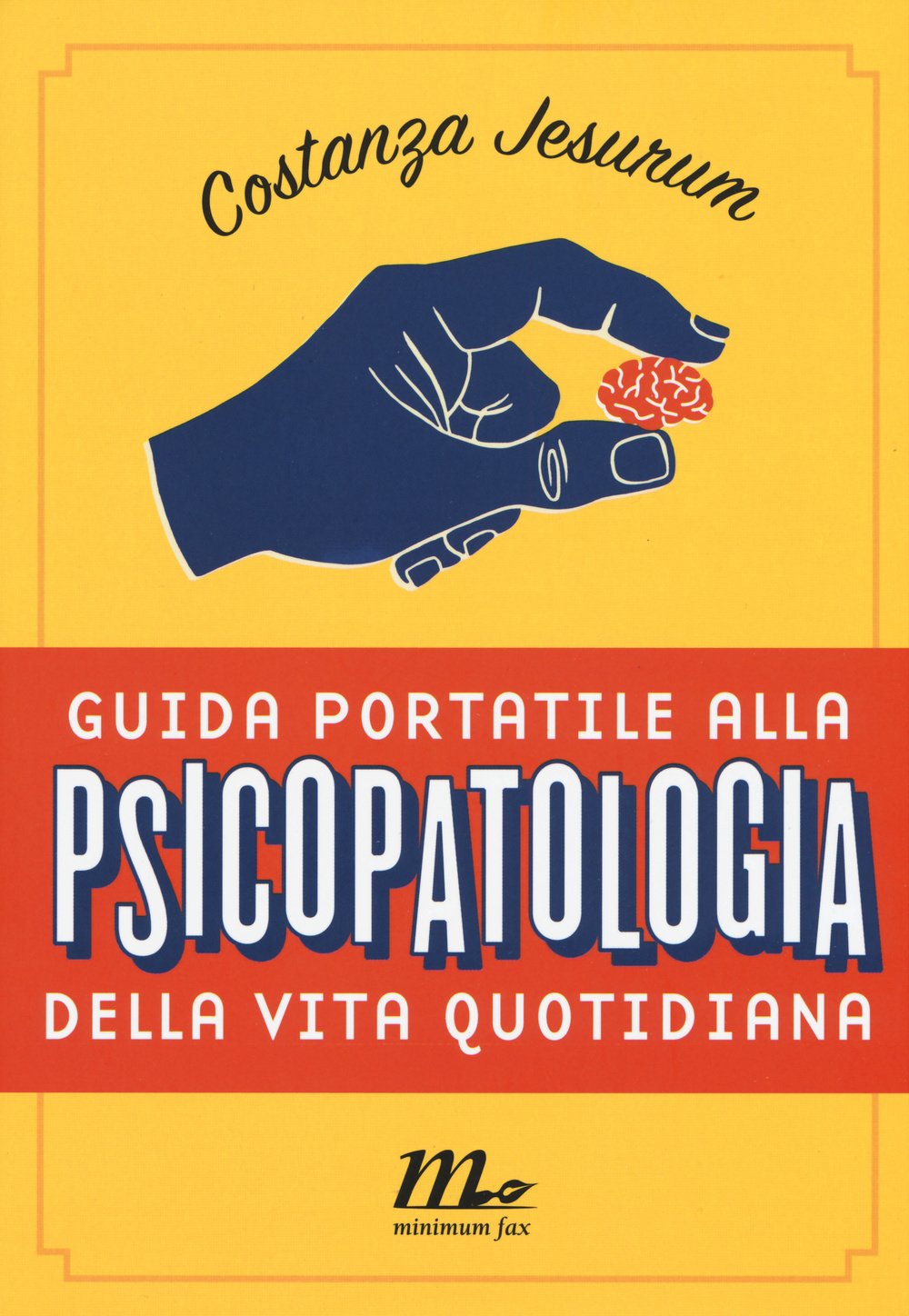
1 commento