Orbanismo – Ágnes Heller
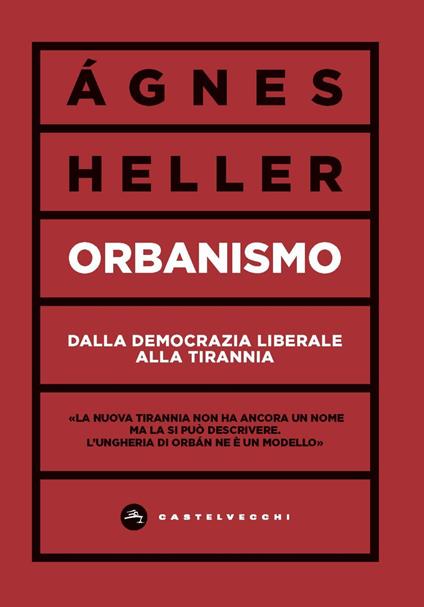
SINTESI DEL LIBRO:
Gli anni 1989-91 sono stati il periodo della liberazione per tutti i popoli
dell’Europa orientale che avevano sofferto la dominazione sovietica, i
sistemi politici totalitari, l’indottrinamento ideologico.
Come tutti già sappiamo dalla Bibbia (Esodo) e più di recente dagli
avvertimenti di Hannah Arendt, liberazione non significa ancora libertà.
Prima occorre che si costituiscano le istituzioni della libertà e che il
popolo impari a farle funzionare, al tempo stesso instillando in esse lo
spirito. Nel 1989-91 il futuro, il destino di tutte le nazioni liberate
dipendeva dal successo o dal fallimento del passaggio dalla liberazione alla
libertà. Alcune delle nazioni appena liberate svolsero bene questo
compito, altre meno. Nelle pagine che seguono discuterò il caso
dell’Ungheria: in che modo la libertà possa essere perduta.
In Ungheria, nel 1989, l’entusiasmo per il cambiamento di sistema fu
grande tra gli intellettuali, che senza la libertà erano spiritualmente
debilitati. Una parte considerevole della popolazione condivise questo
entusiasmo, credendo che la creazione di istituzioni democratiche avrebbe
immediatamente portato ai livelli di vita dell’Occidente. La sua
aspettativa, perciò, era quella di una vita di gran lunga migliore.
Per un certo periodo, tutti i Paesi in precedenza soggetti al sistema
sovietico conobbero un’evoluzione essenzialmente analoga. In seguito,
tuttavia, le differenze assunsero altrettanto rilievo delle analogie. Poco alla
volta, il caso ungherese si è dimostrato peculiare, poiché solo l’Ungheria è
passata attraverso un secondo cambiamento di sistema, non solo de facto
ma anche de iure. Il Primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha definito
il risultato di questo secondo cambiamento di sistema “democrazia
illiberale” e “sistema di collaborazione nazionale” (NER).
Questo risultato dimostra che in Ungheria una grande opportunità è stata
malamente sprecata, recisa: l’opportunità di far radicare la democrazia
liberale sul suolo ungherese. Nello stesso tempo si è colta un’altra
opportunità: affidarsi all’antica tradizione ungherese di seguire un capo,
di attendersi ogni cosa dall’alto, di credere a tutto ciò che viene detto, o
almeno di far finta di crederci, insieme al cinismo per cui, ad ogni modo,
le cose non potrebbero essere altrimenti.
Ogni storia è sempre una storia di scelte. Non era scritto negli astri che
l’Ungheria dovesse essere, tra tutti gli Stati post-sovietici, quello che
probabilmente ha fatto di peggio, che dovesse essere il più radicale nella
soppressione della libertà di stampa, della divisione dei poteri, finendo
per instaurare un sistema che io definirei tirannia. La tirannia non è una
forma di Stato, ma una modalità di governo in cui una singola persona (un
maschio) decide tutto ciò che avviene in un Paese, e niente può accadere
contro la sua volontà. Mentre il primo cambiamento – dopo il 1989
instaurò, tra l’altro, un sistema multipartitico, nel corso del secondo
dopo il 2010 – si affermò la tendenza opposta. Il Partito dominante
(Fidesz) ormai non è più una parte, ma un meccanismo per l’esecuzione
della volontà, delle decisioni, delle opinioni del capo, quasi allo stesso
modo in cui il Partito comunista non era un partito, ma un meccanismo
per l’esecuzione della volontà del Comitato centrale e, tramite questo,
della volontà di Mosca.
“Quasi” lo stesso, poiché nessun Paese straniero controlla il Primo
ministro ungherese; l’attuale governo ungherese non è soggetto a un
dominio o controllo esterno, le sue scelte sono soltanto sue e così le
decisioni. Anche il contesto politico è assai differente. L’Ungheria è
circondata a Occidente da democrazie liberali (almeno fino a questo
momento), è membro dell’Unione europea. Se mai l’Ungheria subisce
pressioni, si tratta di pressioni blande per il ristabilimento dello Stato di
diritto, prive di qualsiasi risultato.
Benché non fosse scritto negli astri che ciò dovesse accadere, la possibilità
di una ricaduta in una qualche forma di tirannia era presente fin
dall’inizio. Com’è accaduto e perché?
In primo luogo, perché la liberazione è giunta all’Ungheria come un dono
inatteso. Tranne poche migliaia di intellettuali, nessun altro aveva lottato
per essa, o fatto qualcosa perché accadesse. I rappresentanti del vecchio
Partito comunista e quelli dei partiti nuovi si erano seduti a una tavola
rotonda e avevano deciso il futuro della nazione, il carattere delle sue
istituzioni, la “transizione pacifica”. La transizione fu effettivamente
pacifica, solo che il popolo ne fu tenuto fuori, molto più che in Romania o
in Cecoslovacchia. Gli ungheresi hanno ricevuto gratuitamente la libertà,
anche se non c’è niente che si dia e riceva gratis. Prima o poi occorre
pagare. L’Ungheria sta pagando adesso.
I principali partiti che hanno diretto il cambiamento di sistema nel 1989
92 sono stati l’Alleanza dei liberi democratici (SzDSz) e il Forum
democratico ungherese (MDF). La SzDSz è stata fondata e diretta da
intellettuali liberali, principalmente di Budapest, che inizialmente
traevano la loro forza dall’essere stati i principali oppositori del regime di
Kádár, editori di samizdat1, organizzatori di azioni di contestazione.
Tuttavia, dopo il cambiamento di sistema, solo un’esigua percentuale degli
elettori sostenne il Partito a causa dei suoi principi liberali, mentre ciò
accadeva principalmente in quanto esso veniva visto come l’avversario più
radicale del comunismo. A ragione, poiché aveva organizzato e guidato il
primo plebiscito libero e ottenuto il sostegno della maggioranza – tra
l’altro – per il suo rifiuto del sistema presidenziale. Diversamente dalla
SzDSz, il MDF era una specie di partito nostalgico nazional-conservatore.
Era riuscito a radicarsi bene nei centri più piccoli, ricreando una qualche
continuità con l’Ungheria di prima del comunismo, con i vecchi tempi. I
suoi leader erano legati anch’essi, come quelli della SzDSz, al modello
occidentale delle istituzioni liberal-democratiche. L’Ungheria avrebbe
tratto grandi vantaggi da una coalizione governativa formata da questi due
Partiti, poiché riforme talvolta dolorose avrebbero potuto essere sostenute
meglio da una “grande coalizione nazionale”. Questo non è accaduto
perché i Presidenti di entrambi i Partiti rifiutarono la proposta. Si trattò
del primo errore che avrebbe condotto alla loro caduta definitiva.
Fu il Partito vincitore delle prime elezioni libere (MDF) a formare il primo
governo libero. Poiché non disponeva della maggioranza assoluta, fu
costretto a coalizzarsi con altri Partiti minori. Perciò il primo governo era
assai eterogeneo. Comprendeva esponenti del conservatorismo liberale,
ma anche politici di estrema destra che sostenevano con veemenza i loro
programmi, a volte con successo.
Il Primo ministro, József Antall, un dignitoso conservatore, era debole e
per di più gravemente malato (sarebbe morto mentre era ancora in
carica). La sua politica era confusa, economicamente dannosa, anche se in
tema di libertà, in linea di massima, molto corretta. L’Ungheria in quel
periodo aveva anche due importanti figure politiche. Il Presidente della
Repubblica, Árpád Göncz, e quello dell’appena istituita Corte
costituzionale: László Sólyom. Anche se venivano commessi serissimi
errori politici, queste due eminenti personalità ci portavano a credere che
le nuove istituzioni liberali e democratiche fossero solide e non potessero
essere messe in discussione, ancor meno distrutte. Ad ogni modo, e la
cosa si è potuta vedere solo retrospettivamente, l’errore più letale venne
commesso durante il periodo della loro carica. Non si ebbe una nuova
Costituzione formata attraverso il dibattito popolare. Il popolo fu lasciato
senza una base politica su cui poter fare affidamento, una base che lo
unificasse come una sola collettività. Intanto, la proposta, o meglio, la
richiesta di molti membri del Parlamento di rendere pubblici gli elenchi
degli informatori durante il regime di Kádár, ancora conservati nella
cassaforte dell’ex polizia segreta, veniva costantemente elusa. I dossier
venivano tenuti segreti per essere usati a scopo di ricatto o per farne
trapelare occasionalmente delle parti, al servizio di determinati interessi
politici.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




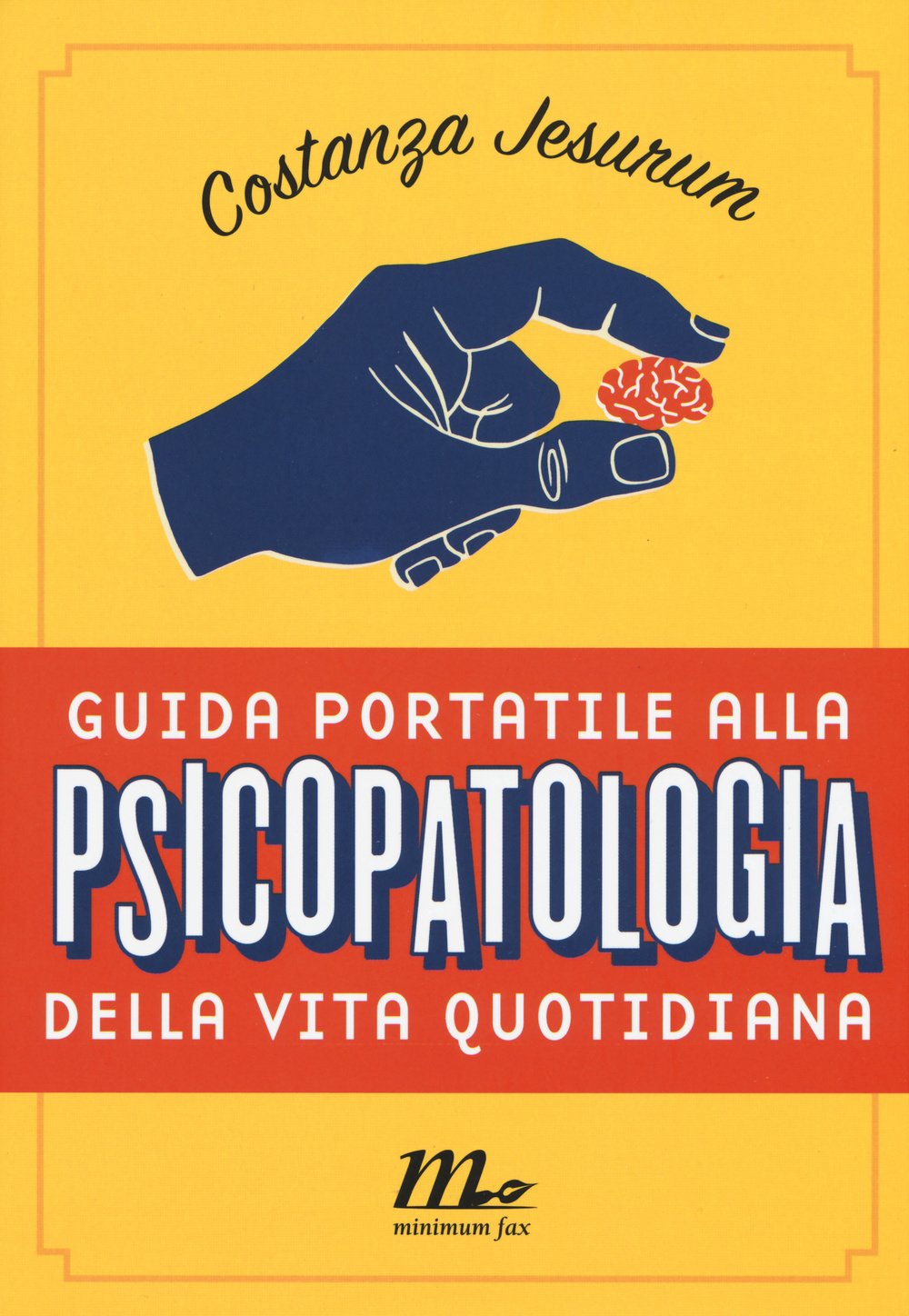
1 commento