Madri e no – Flavia Gasperetti
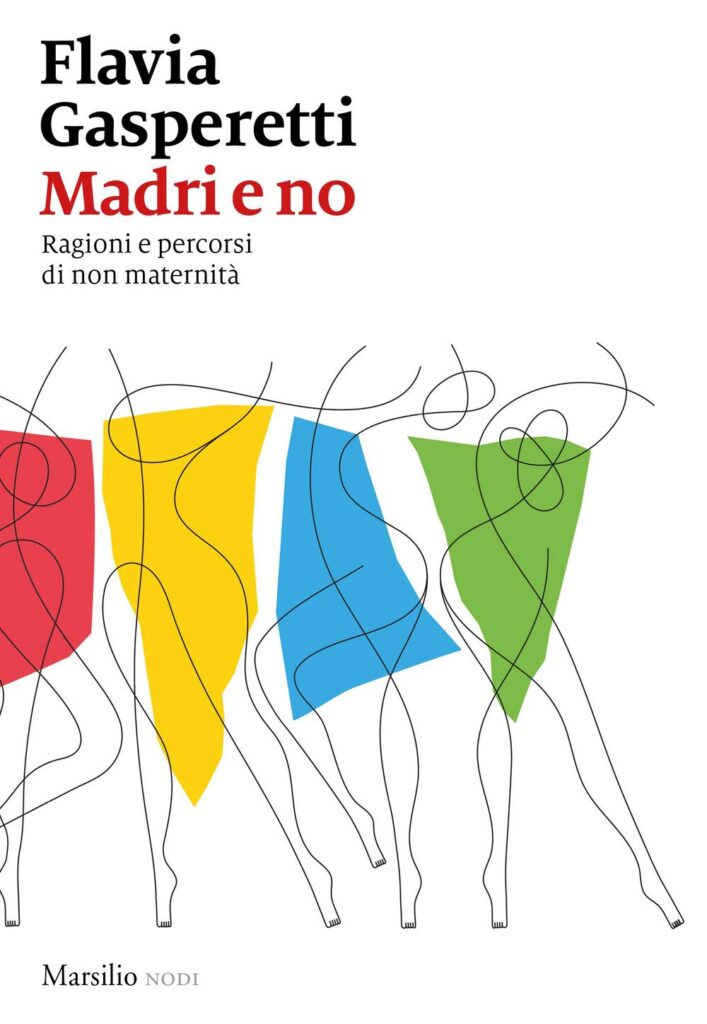
SINTESI DEL LIBRO:
Succede. Può succedere a molte donne di ritrovarsi a varcare
senza vera coscienza quell’impercettibile soglia e passare
dall’essere una che non ha ancora un figlio a una che non ne ha
avuti. A molte, ho scritto. Stavo per scrivere «a molti» ma mi sono
fermata, perché per i maschi – o almeno così ci hanno detto –, per
la maggioranza dei maschi le cose pare stiano in maniera diversa.
Nella vita di un uomo, si suppone, quel confine raramente assume
l’aspetto di una porta così definitivamente chiusa.
Per tutte coloro che vorrebbero o avrebbero voluto, salvo poi
scoprire che è troppo tardi, che non è più o che non è mai stata
una possibilità, il passaggio tra questi due stati dev’essere come
ritrovarsi in esilio, un risveglio dentro una vita diversa dove tutto
resta in apparenza uguale, e nuovi giorni da passare per sempre
al di qua di questa maledetta porta chiusa. Contemplare la soglia
non ispira in tutte gli stessi sentimenti. Anche io tra poco sarò una
che non ha avuto figli e sento la tentazione di dire che a quel
punto sarò compiutamente me stessa – la persona che voglio
essere e quella che sono si troveranno infine in un allineamento
più semplice, leggero, leggibile.
A voler dar retta ai dettami del senso comune, una volta passati
i quarant’anni l’orologio biologico di ciascuna dovrebbe mettersi a
ticchettare all’impazzata; siamo abituati a pensare che,
all’avvicinarsi della data di scadenza della loro scorta di ovociti, le
donne saranno prese come da una febbre, si lanceranno in uno
scomposto arrembaggio alla maternità prima che sia troppo tardi,
eppure niente nella mia fisiologia preannuncia un imminente
Sturm und Drang procreativo.
L’orologio biologico, come ha scritto l’autrice e accademica
Moira Weigel in un suo recente libro1, è una metafora, divenuta
così familiare che ci siamo abituati a considerarla invece un fatto,
un avvenimento fisico concreto come il ciclo mestruale o la
menopausa. E tuttavia non è stato un medico o una prestigiosa
rivista scientifica a dare al termine il significato che conosciamo,
ma un giornalista, Richard Cohen, in un articolo di costume
pubblicato nel 1978 dal «Washington Post» dedicato alle
aspirazioni delle giovani donne in carriera2. Fino a quel momento
l’orologio biologico era stato solo un sinonimo con cui la scienza
medica era solita riferirsi ai ritmi circadiani dell’animale uomo, ai
suoi cicli sonno-veglia e non, come è stato da allora, uno
spauracchio con cui turbare i sonni delle lavoratrici dell’Occidente
capitalizzato. La protagonista dell’articolo di Cohen, da lui
ribattezzata Composite Woman, era una donna appunto
“composita”, una ragazza-mosaico da lui costruita assemblando i
tratti salienti delle, a suo dire, tante giovani impiegate e
professioniste che aveva incontrato e intervistato per il suo
articolo. In ogni ufficio, agenzia o redazione, la sua donna
composita del 1978 era «quella carina», «ben vestita», «con un
bel fisico». Aveva un’età tra i ventisette e i trentacinque anni e il
suo lavoro era «semplicemente meraviglioso». A volte era sposata
e a volte no, ma a ognuna di esse, come avrebbe poi confessato in
privato al nostro cronista, pareva già di udire l’ineluttabile,
incalzante ticchettio. E Cohen, che raccontava tutto questo
assumendo il tono del benevolo e compartecipe confessore, nel
chiudere il suo articolo non ha potuto resistere alla tentazione di
mettere nero su bianco la triste morale che il lettore doveva aver
intuito da un pezzo: la situazione di queste donne dimostrava che
la liberazione femminile ha, di necessità, un suo limite intrinseco,
un capolinea naturale e inalterabile, che esiste e esisterà sempre,
un ambito fondamentale nel quale «una donna è una donna
biologicamente, fisiologicamente, incontrovertibilmente diversa».
Non è un caso che l’orologio biologico abbia cominciato a
spadroneggiare nei media e nella cultura popolare proprio nei
primissimi anni ottanta, quelli che la giornalista e autrice Susan
Faludi, in un suo testo uscito in Italia nel 1992, ha definito come
gli anni del contrattacco, il puntuale backlash culturale che si
scatena in risposta a ogni nuova e parziale conquista femminile
sui piani molto cruciali della partecipazione al lavoro e/o
dell’autonomia sul corpo3. Il 1978, l’anno di pubblicazione
dell’articolo di Cohen, rappresenta in qualche modo una soglia: la
f
ine di un decennio che aveva visto l’emergere della seconda
ondata femminista, una massiccia entrata delle donne in molti
settori occupazionali e la storica conquista rappresentata da Roe
vs Wade, la sentenza con cui il 22 gennaio 1973 la Corte suprema
americana aggiudicò la causa intentata da Norma McCorvey,
chiamata Jane Roe per proteggerne l’anonimato, contro lo Stato
del Texas. Si fissò allora il più importante precedente giuridico
nella legislazione sull’aborto, dichiarando incostituzionale, in
nome del diritto dei cittadini alla privacy, l’ingerenza governativa
sulla scelta di interrompere una gravidanza, cosa che era ancora
reato in trenta Stati dell’unione4. Il decennio successivo ha
prodotto diverse e persuasive narrazioni controrivoluzionarie, e
l’orologio biologico ne è l’esempio più emblematico: un costrutto
che ha preso forma a partire da una manciata di studi accademici
dalle credenziali traballanti, rilanciato poi dai media con un tale
furore che il termine ha ampiamente varcato i confini nazionali
per entrare stabilmente nel lessico comune di tutti noi. Oltre a
infestare le pagine dei magazine femminili e uno stupefacente
numero di romanzi della collezione Harmony, l’orologio spopola da
decenni nel nostro immaginario collettivo – è la data di scadenza
di cui scrive Bridget Jones nel suo diario; è il bambino che danza
nelle allucinazioni dell’avvocatessa televisiva Ally McBeal; è, per
fare un esempio più vicino a noi, la minacciosa clessidra che
accompagnava lo slogan La bellezza non ha età. La fertilità sì
della campagna pubblicitaria lanciata nel 2016 dall’allora ministro
della Sanità Beatrice Lorenzin per il Fertility day.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :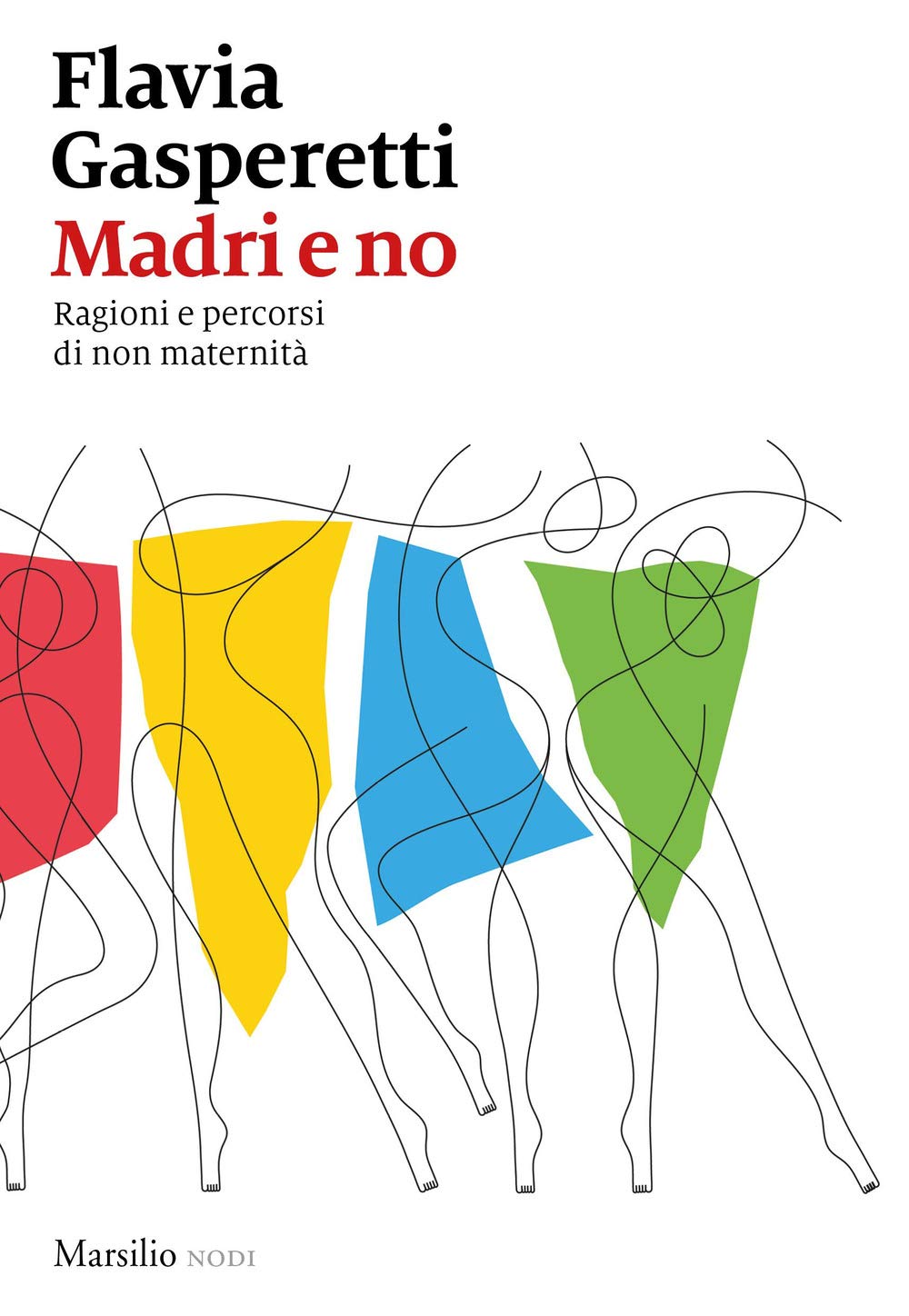






Commento all'articolo