L’ultimo arrivato – Marco Balzano
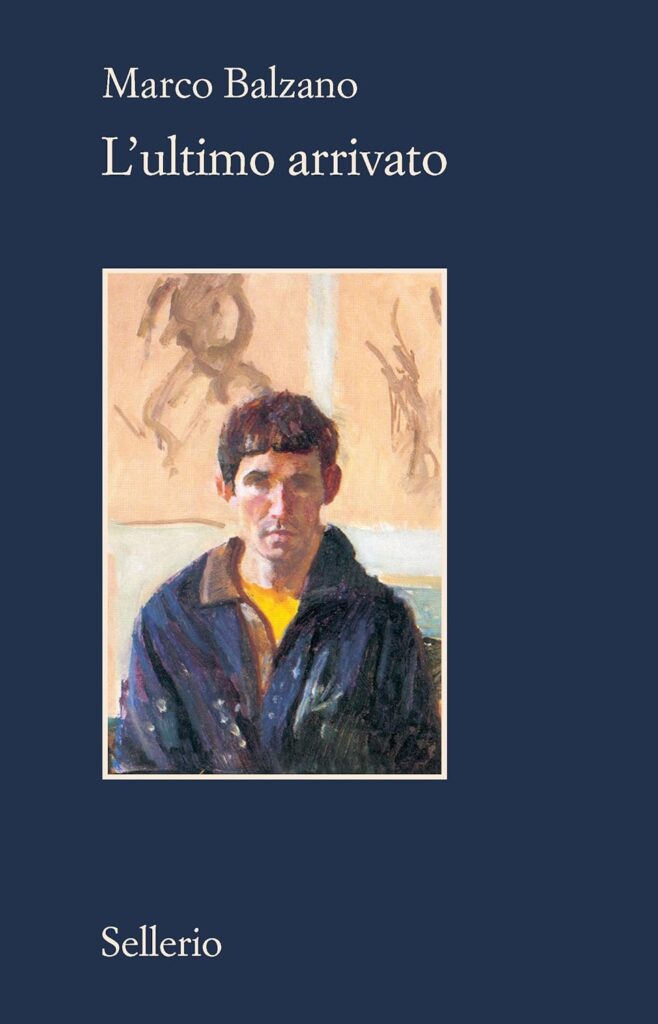
SINTESI DEL LIBRO:
Prima di chiamarmi pelleossa mi chiamavano strillone, i bambini
della scuola elementare di via dei Ginepri. Me li ricordo ancora tutti e
trentaquattro, anche se la faccia che più mi è rimasta in testa è
quella di Peppino, con quei capelli dritti da dita nella corrente.
Insieme ci divertivamo a fottere la merenda di pane e mortadella a
Ettore Ragusa, il figlio del macellaio. Quando se ne accorgeva tirava
uno strillo più acuto dei miei e frignava a fontana. Io e Peppino,
allora, andavamo lì con la bocca ancora bisunta e facevamo i
dispiaciuti, «ma no, Toruccio... ma che si piange per fatti così
piccoli?», «morto un panino se ne fa un altro, su!», queste frasi di
consolazione gli dicevamo. Ogni tanto mi sentivo in colpa e chiedevo
a Peppino se non stavamo esagerando.
«Ma quale esagerazione! Quel cornuto è più largo che lungo e a
casa trova tutti i giorni la pastasciutta. Tu che trovi?».
«Acciughe» rispondevo io.
Fino a nove anni ho vissuto di acciughe. Anzi, di un’acciuga al
giorno. Me la rifilava mamma mia al mattino prendendola da un
barattolo col sale rancido attaccato al vetro. La stiracchiava su una
fetta di pane che lei chiamava «pane in cassetta» e mi diceva di
stare alla larga dalla cucina fino a sera.
«Smammare» ripeteva con un gesto da generale.
Dopo un paio d’ore tendevo l’orecchio sulla pancia perché sentivo
che da lì dentro uscivano rumori strani. Sgorghi, ragli, risucchi, non
saprei come chiamarli. Così se qualcuno con le mie stesse calorie in
corpo mi proponeva di andare a rubare, io subito ci stavo. Più facile
era sgraffignare frutta dalle cassette di legno che le vecchie
tenevano sulla soglia. Peppino distraeva la vecchia e io ficcavo
pesche sotto la maglietta o nelle mutande. Complicato andare a
rubare nelle case di un paio di paesani senza più cervello al seguito.
Io di solito, visto che avevo una parlantina affilata, facevo da palo e
Peppino, o Ciccillo o Berto o qualche altro affamato, mi passavano
dietro la schiena per rovistare a casaccio dentro qualunque tiretto. A
volte si usciva con un bottino niente male, ma nella maggior parte
dei casi si raggranellavano cose da niente. Tozzi di pane, torroncini,
qualche uovo da sucare. Difficile, infine, rubare nell’alimentari di
Turuzzu, sia perché quel negozio era fetente e uno se ne voleva
scappare prima ancora di metterci piede, sia perché Turuzzu era
svelto e se ti beccava menava calci. Per arrischiarsi da lui bisognava
avere nel sangue la pressione delle lucertole, altrimenti conveniva
evitare.
Nel tempo, però, ho realizzato che a San Cono in tanti seguivamo
la stessa dieta e allora mi sono messo l’anima in pace. Tutti, presto o
tardi, ci siamo messi l’anima in pace. Un’acciuga? E un’acciuga sia!
Da picciriddi non ci si demoralizza mica così. Certo, finché andavo a
scuola era un discorso. Stavo seduto al banco l’intera mattina,
ascoltavo il maestro Vincenzo e la storia finiva lì. Ma quando a
mamma mia la notte del 10 ottobre 1959 venne il colpo apoplettico e
rimase menomata per sempre, beh, non fu proprio la stessa cosa
perché dovetti ritirarmi da scuola e filare in campagna con mio padre
a fare lo jurnataru.
Dopo Peppino, anche se non gliel’ho mai detto, la persona a cui
volevo più bene era il maestro Vincenzo. Ero più affezionato a lui
che a mio padre Rosario. Non solo perché non era noioso e non
menava mazzate quando rientravo a casa con la giubba strappata o
le ginocchia sbucciate, ma per le poesie che ci leggeva. Di Giovanni
Pascoli specialmente. Non metteva mai fretta di capirle. Era prima di
tutto una questione di musica.
«Al senso ci penseremo dopo!» ripeteva quando noi bambocci
facevamo certe facce da incomprensione.
Dopo aver recitato marciando tra i banchi ordinava di trascrivere la
poesia sul quaderno perché «ricopiare vuol dire imparare!», diceva
col bastone in aria per farci stare muti.
Il
maestro Vincenzo era come un amico per me, non ci sono
storie. Basta dire che ci vedevamo pure fuori scuola. Anzi, il
sottoscritto era la prima persona che incontrava, visto che eravamo
dirimpettai. L’appuntamento era all’angolo di via Archimede, alle
sette e mezza. Io quando lo vedevo in lontananza sbattevo le mani
sulle gambe per scuotere i peli del micio e correvo verso di lui. Gli
dicevo subito che la versione in prosa non l’avevo fatta perché
trasformare una poesia mi pareva una brutta operazione. Il maestro
non ribatteva, mi domandava soltanto se l’avevo imparata.
«Sicuro che l’ho imparata! Volete che ve la ripeto?».
«Non adesso».
«E mi metterete il brutto voto?».
«Se non l’hai imparata sì».
Ma quale brutto voto, io le poesie le sapevo tutte quante a
menadito e pigliavo sempre Lodevole! Quando tornavo a casa
sventagliavo in aria il quaderno per mostrare la sua scritta in penna
rossa e reclamavo in premio un pezzo di cioccolata o il corrispettivo
di piccioli per andarmela a comprare. Tutto questo, l’ho già detto,
fino al 10 ottobre 1959, perché dopo non ci fu da reclamare più
niente.
Superata l’edicola di Rocco, il maestro si faceva guidare da me.
Una volta comprata l’Unità non parlava più e camminava senza
guardare. Allora, siccome al passaggio a livello di San Cono c’era
già scappato il morto, gli prendevo il braccio come si fa coi ciechi.
Quando era successo il fatto del morto ammazzato sotto il treno, il
maestro aveva detto che dovevamo dispiacerci anche se non lo
conoscevamo e sapevamo soltanto che la locomotiva lo aveva
sbattuto lontano, lui, la bicicletta e il sacco di arance attaccato al
manubrio.
«Chi non si dispiace della morte di una persona è barbaro» disse
in classe, e quando passò il carro funebre ci ordinò di interrompere il
dettato per andare alla finestra a recitare una preghiera.
Il
maestro fu il primo a cui raccontai del colpo apoplettico di
mamma mia. Quel mattino ero rimasto muto e non gli avevo manco
pigliato il braccio al passaggio a livello. Quando finalmente mi
guardò interrogativo, gli raccontai che era caduta per terra nel cuore
della notte, una macchia di sangue nero gli si era formata sulla
tempia e non se ne andava. Il maestro allora fermò il passo, ingoiò la
saliva a fatica e mi disse tante cose importanti. Che però non mi
ricordo più.
Da quel giorno, in casa di mio padre Rosario, passò ad aiutarci zia
Filomena, la sorella di mamma mia. «La gobbetta precisina» la
chiamavano in paese. Zia Filomena era una che veramente aveva
sempre da ridire. Per ogni cosa sbuffava. Un suo sbuffo poteva pure
scafazzarti i capelli tanto era potente. Una volta chiesi a mio padre di
cosa era morto il marito della zia e lui rispose: «Di sbuffi». Lei sola
però non aveva schifo di niente. La cambiava, la lavava in mezzo
alle gambe, la imboccava perché la bocca era diventata storpia. Poi
a piacimento, il giorno che gli pareva a lui, veniva a visitarla il dottor
Cucchi, uno che quando passava la gente di via Archimede si
scappellava tutta quanta. Prima di visitare il dottor Cucchi chiedeva a
noialtri di uscire perché dove ci sono ammalati ci vuole ossigeno,
diceva.
«La cosa migliore sarebbe ricoverarla a Catania, in un ospizio»
sentenziava sulla porta con la valigia in mano. «E comunque voi,
signor Giacalone, dovete portare pazienza. Bisogna imparare a
prendere un giorno alla volta, questa è la saggezza che insegna la
malattia».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :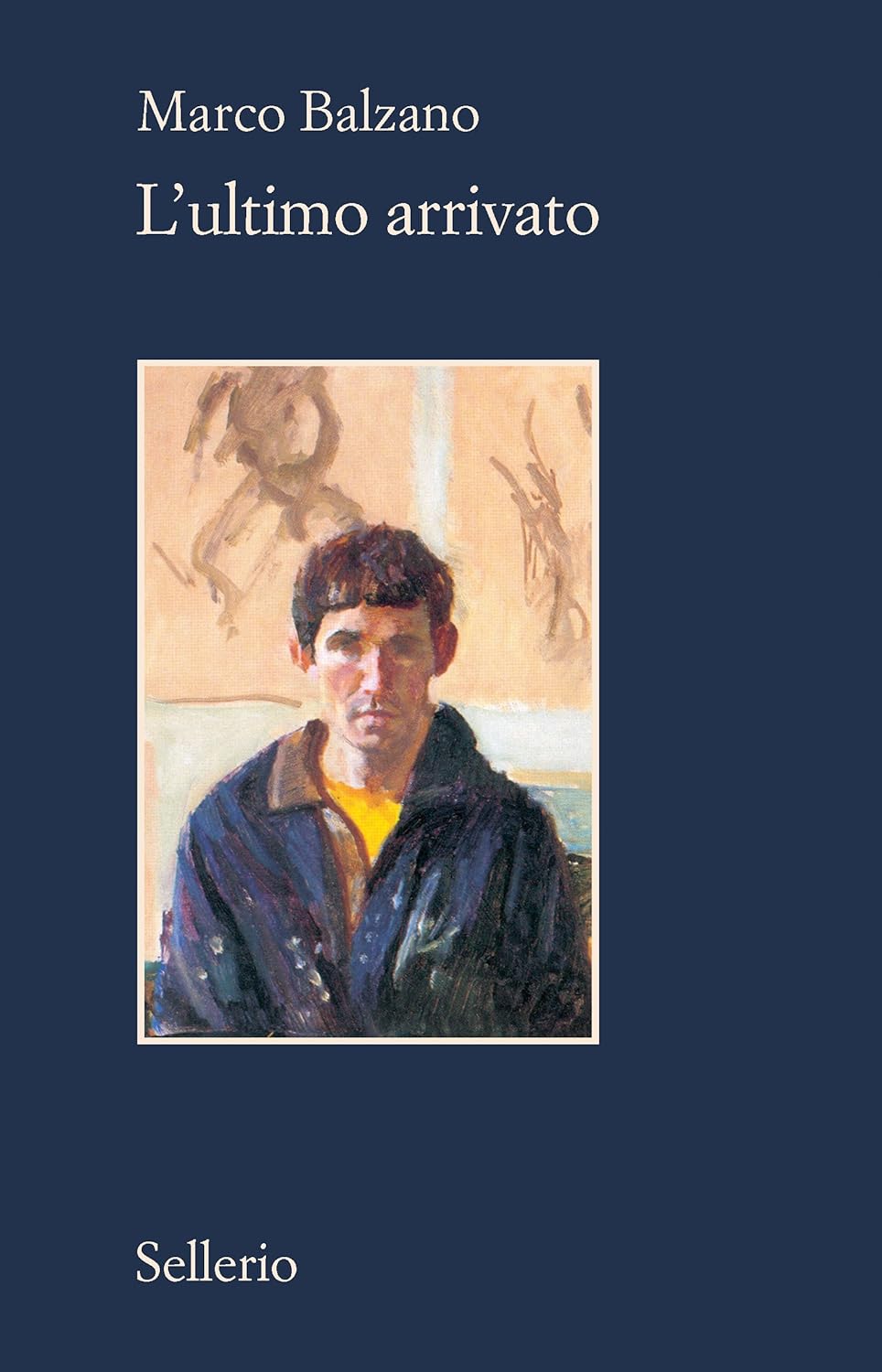






Commento all'articolo