L’Italia spensierata – Francesco Piccolo
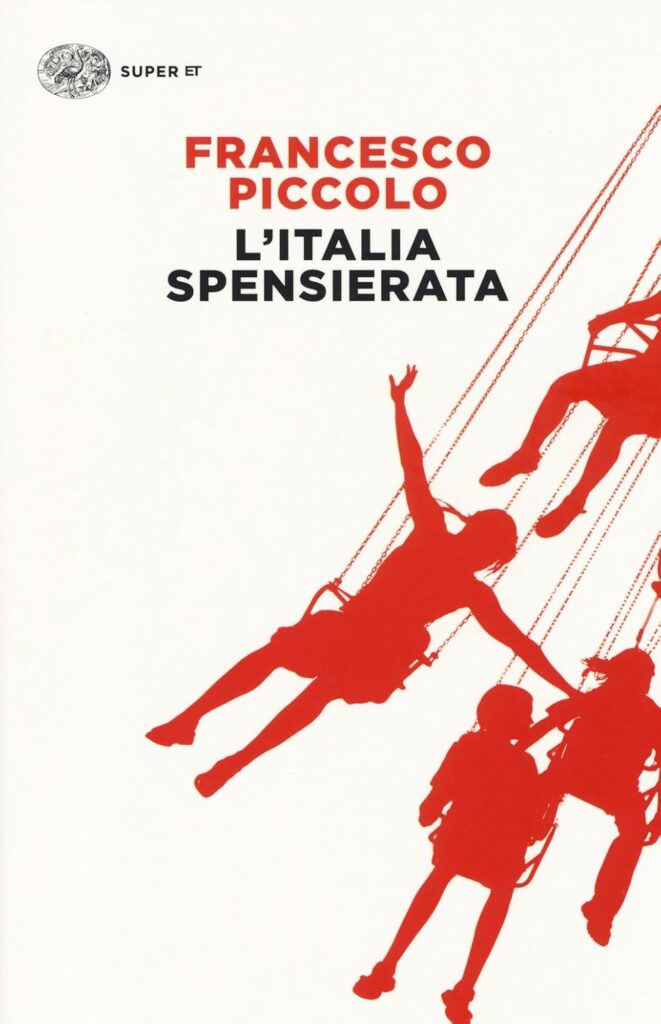
SINTESI DEL LIBRO:
Molti anni fa, nell’inverno del 1969, avevo cinque anni e mia sorella
tre. Il sabato sera mia madre ci faceva il bagno, ci asciugava i capelli
per un tempo infinito, ci riempiva di borotalco, ci infilava il pigiama.
Mio padre veniva a prenderci in bagno e in braccio ci portava in
soggiorno, su un divano enorme. Poi andavano di là, mentre noi
vedevamo Carosello, e preparavano dei grossi panini con la frittata
che erano morbidissimi, grazie all’olio e al calore. Ci sedevamo tutti
e quattro sul divano e mangiavamo, aspettando. L’annunciatrice
diceva che stava per cominciare. Infatti apparivano le gemelle
Kessler, seguite in ogni movimento da un microfono gigantesco che
cadeva dall’alto (si chiamava «la giraffa»): ballavano con sincronia
perfetta, con l’intento, credo, di apparire una lo specchio dell’altra, e
ci dicevano che se cantavamo insieme a loro, quella sera, eravamo
belli come loro, e se non cantavamo, eravamo brutti. Noi cantavamo.
Ed eravamo più che sicuri di far parte di una comunità molto grande
quella sera, una comunità di gente come noi che aveva la casa
occupata dall’odore di borotalco e di frittata. E che cantava come
noi.
Quelli belli come noi é una canzone scritta da Canfora, Verde,
Terzoli e Vaime, ed era la sigla di Canzonissima, il programma di
varietà più seguito in quegli anni. Il varietà televisivo era un modo
allegro e sentimentale per far passare serenamente il sabato sera
alle famiglie italiane, ed era anche (o: quindi) un elemento strategico
dal punto di vista politico per la costruzione del consenso, per
formare una memoria condivisa. Se uno non ha cinque anni, o non li
ha più, comprende senza illusioni che la sigla del programma era
una canzone che mirava a qualcosa. Era un motivetto allegro e che
restava nella testa, certo, ma era anche un messaggio molto serio e
molto rassicurante (che doveva restare nella testa, appunto); in
pratica, diceva: stiamo vivendo anni di cambiamento e di rivoluzioni
grandi o piccole, stiamo subendo destabilizzazioni, ma se voi, la
grande maggioranza degli italiani, seguite noi, state con noi, noi
resteremo saldi nei nostri vecchi principi e nessuno potrà farci del
male. Lì fuori la gente urla, ma sono pochi e brutti. Qui, al caldo delle
case, con tutte le famiglie sui divani, unite, siamo tanti e siamo belli.
Come poteva venirti voglia, se stavi seduto con tutta la famiglia in
quell’odore di pulito e di fritto, di stare lì fuori con la minoranza e non
qui dentro con la maggioranza?
Del resto, anche qualcun altro, in quegli anni, cantava con
convinzione e molto successo un’esortazione simbolico-profetica agli
italiani: finchè la barca va, lasciala andare...
Quella canzone-tormentone, negli anni, mi é rimasta in mente come
un evento traumatico: é il punto in cui si incontrano l’omologazione
più (s)frenata e la felicità più nitida. Tutta la mia vita é stata un
elastico tra la coscienza e l’abbandono. Tra la capacità di ragionare
su quello che vedo e la volontà di perdermi nella partecipazione.
Ogni volta che mi torna in mente il refrain di Quelli belli come noi, la
coscienza mi dice che nella sua leggerezza é infida, che va
combattuta; ma la memoria mi porta a un momento perfetto, a un
senso di felicità assoluta, quello che ricordo con più rapidità quando
penso alla mia infanzia, in cui aderivo senza alcuna resistenza
all’esortazione delle Kessler.
Se c’é un punto in cui la mia personalità si sente in bilico tra due
esperienze, idee e percezioni del mondo, é quando attraverso il
ricordo della sigla di Canzonissima metto a confronto un senso di
allarme e una volontà di partecipazione. Da lì, credo, nasce l’io
narrante che vive e indaga l’Italia spensierata.
In carne e ossa
Sono quasi le due del pomeriggio di questa domenica d’inverno
gelido, e io sono davanti ai teatri di posa della Dear in via
Romagnoli, a Roma. C’é silenzio e ci sono soltanto io, quindi quello
che mi hanno detto é vero: Mara Venier sta per cominciare la sua
parte di Domenica in, che si chiama «Anteprima:», e il fatto che si
chiami così la rende talmente diversa da tutto il resto, che non é qui,
dove fanno Domenica in, ma al Teatro delle Vittorie. E io che ho
scelto di venire a vedere dal vivo Domenica in un po’ (o forse molto)
anche per lei, mi ritroverò tutto il pomeriggio senza di lei. La
questione é che io e Mara Venier abbiamo un conto in sospeso, a
prescindere dal fatto che lei ne sia o no consapevole. A causa sua,
oltretutto, e del timore di non entrare, sono venuto con talmente
tanto anticipo sull’orario d’ingresso (fissato dopo le due e mezza)
che i sorveglianti mi trattano con un bel po’ di disprezzo mentre mi
dicono che é presto e che devo tornare non prima di un’ora (e sarà
comunque prima delle due e mezza). Non mi guardano negli occhi e
non mi piace: sento da parte loro una malcelata arroganza che
esprime sia superiorità sia insofferenza; e non mi piace. Ho chiesto
solo se é questa l’entrata per il pubblico di Domenica in e se il mio
nome é segnato tra quelli che possono entrare. Mi hanno detto di sì
e questo mi rassicura. Me ne vado in cerca di un bar per un caffé,
nel deserto di una zona residenzial-periferica nel dopopranzo della
domenica. Non c’é niente, non c’é nessuno -fino a quando non trovo
qualche centinaio di metri più in là un grande incrocio e una scritta
«Lo zio d’America» e i vetri lunghi e lucenti di una pasticceria, entro
e c’é tanta gente, e mangio tre (sì, tre) aragoste alla crema, bevo il
caffé e compro sigarette leggere e accendino, anche se non fumo
più. Ma mi faccio offrire sigarette durante le cene con gli amici, nelle
notti d’estate, quando bevo il caffé con qualcuno che fuma, quando
c’é da festeggiare qualcosa o quando sono molto incazzato. E in
momenti speciali come oggi, quando vado in qualità di pubblico a
vedere Domenica in.
Quando torno, si vede che é l’ora giusta. C’é tanta gente davanti
all’ingresso, e un pullman targato Arezzo scarica una comitiva di
signore e signori perlopiù anziani che sono abbastanza eccitati e
guidati da uno che sembra sapere il fatto suo, e si aggira
abbastanza orgoglioso del fatto che il suo pullman di gente di Arezzo
non abbia dovuto passare lo sbarramento doganale al quale ci
stiamo sottoponendo noi. Bisogna consegnare il documento
d’identità; una signora ha soltanto la tessera sanitaria nuova di
zecca, sostiene che é scritto su tutti i giornali che vale come
documento d’identità, lo so anch’io ma non ho nessuna voglia di
aiutarla perchè non ho nessuna voglia di inimicarmi coloro che
detengono il potere: bado al fatto che voglio superare io lo
sbarramento, quindi non voglio creare altri malintesi con quelli che
decidono se passi o no. La guardia non legge i giornali, la cosa in
ogni caso é troppo recente perchè possa essere accettata con
disinvoltura, e alla fine si giunge al compromesso di accettarla
parzialmente: la signora entrerà, ma con una dichiarazione del
marito che quella é sua moglie; e anche con la tessera sanitaria.
Metà e metà, insomma, e nessuno é insoddisfatto.
Ci dicono di consegnare i documenti uno alla volta, di scandire bene
il nome, di aspettare appena fuori dalla guardiola la restituzione del
documento, di non restare troppo vicini e di non parlare ad alta voce.
Ci danno degli ordini, in pratica, e questi ordini non sono camuffati in
nessun modo. Non ci trattano bene, se devo parlare chiaro. Penso
che qui all’ingresso, forse, sono frustrati per il fatto di essere ai
margini della macchina televisiva, oppure provano piacere
nell’esercizio di un potere qualsiasi, sia esso anche soltanto quello di
gestire un sottoprodotto di passaggio doganale. In fila, poi, a un
certo punto squilla un telefonino molto grande e quasi quadrato; una
signora risponde e non so se ha premuto il tasto vivavoce - ma
penso poi, riflettendo, che forse il videotelefonino deve andare
automaticamente in vivavoce, sennò uno come fa a parlare e
guardare le immagini contemporaneamente? Infatti un signore
dall’altra parte (il marito, capiamo tutti) urla a squarciagola che lui la
vede, ma lei lo vede? E lei dice che non lo vede e poi però lo vede e
di nuovo non lo vede, ma lui la vede sempre? In pratica parlano solo
di questo. Non so se il marito ha chiamato soltanto per sapere se lei
lo vede, mi sembra di sì -perchè poi alla fine, quando sono riusciti a
vedersi, si sono salutati soddisfatti e la telefonata é finita, anche se
la signora si vergognava un po’ di aver subito le urla del marito
davanti a tutti noi -, e cosi possiamo concludere che anche il
videotelefonino (oltre alla tessera sanitaria) é agli albori, almeno per
questa coppia di anziani signori che di sicuro si parlavano al
videotelefonino per la prima volta. Ogni oggetto che é agli albori non
é ancora un mezzo ma é soprattutto il fine per cui si usa quel mezzo.
Del resto, anche se compriamo un frigorifero nuovo, quando lo
mettiamo in funzione la prima cosa che cerchiamo di capire non é se
il
latte o le uova sono nel posto giusto, ma é: vediamo come
funziona. Per tutto il resto della vita ci interesserà cosa c’é dentro,
ma nei primi giorni ci interessa il frigorifero in sè, e non cosa c’é
dentro. L’autoreferenzialità del prodotto, in questo caso del
videotelefonino, insomma, ha una sua logica e, nei primi tempi, una
sua giustificazione. Lo dico perchè il telefonino pone la questione
dell’autoreferenzialità in maniera profetica rispetto a ciò che sto
andando a vedere, anche se ancora non me ne rendo conto mentre
la signora vede e non vede il marito. Tutto ciò che accadrà durante il
pomeriggio si riferirà sempre alla televisione, come se fossimo
sempre nel primo mese dell’invenzione del mezzo, e quindi rimane
più importante ciò che accade lì dentro che non il rapporto tra quello
che si fa lì dentro e la realtà. Quindi, adesso che sto superando la
barriera e sto entrando nello spazio degli studi, da questo momento
in poi la televisione non sarà solo il mondo che mi conterrà ma
anche ciò di cui ci occuperemo tutti, e se c’é qualcuno che é rimasto
a casa, mi vedrà o non mi vedrà attraverso lo schermo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :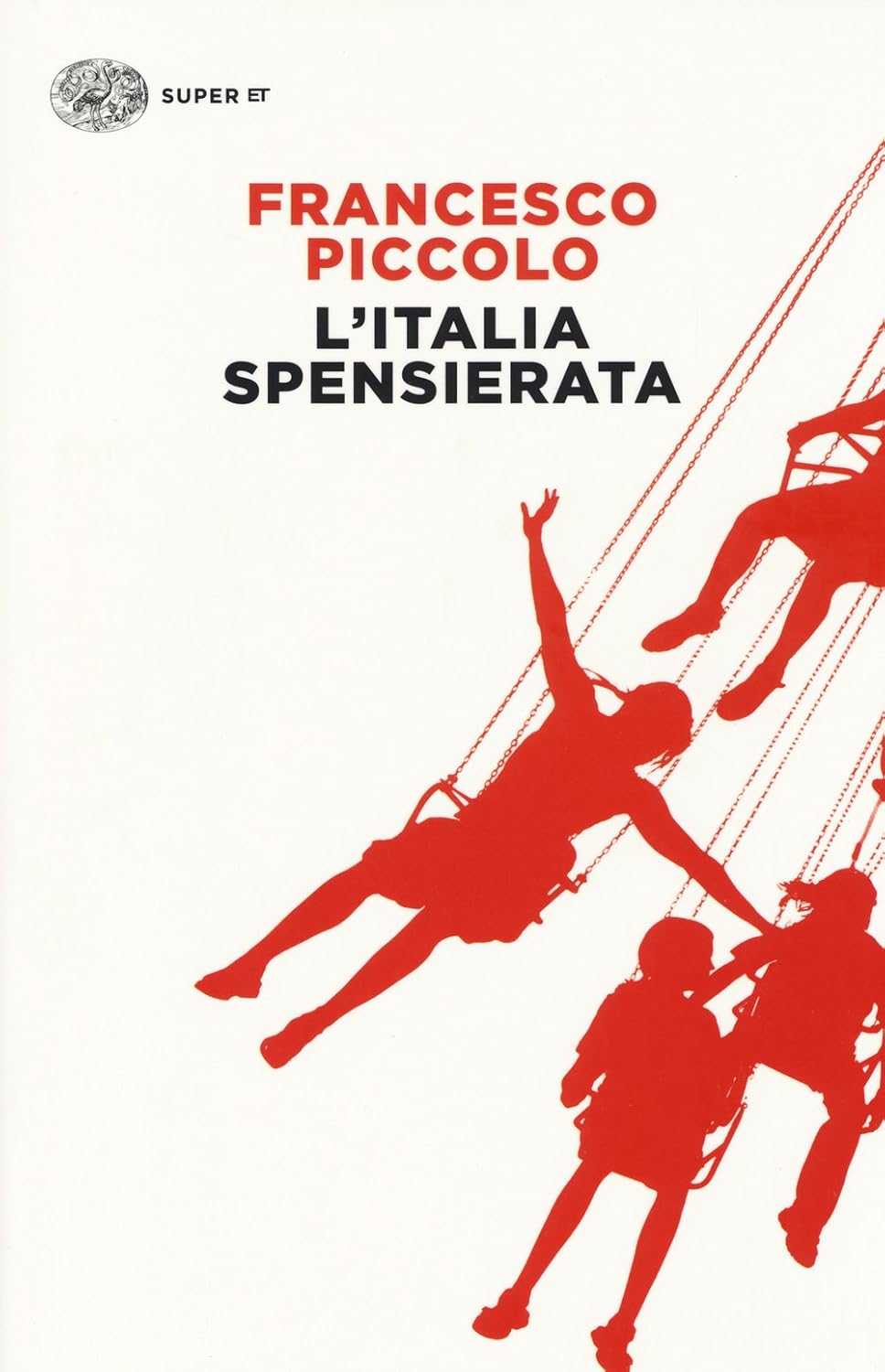






Commento all'articolo