Lo studente che sfidò il Papa – Inquisizione e supplizio di Pomponio de Algerio – Umberto Vincenti
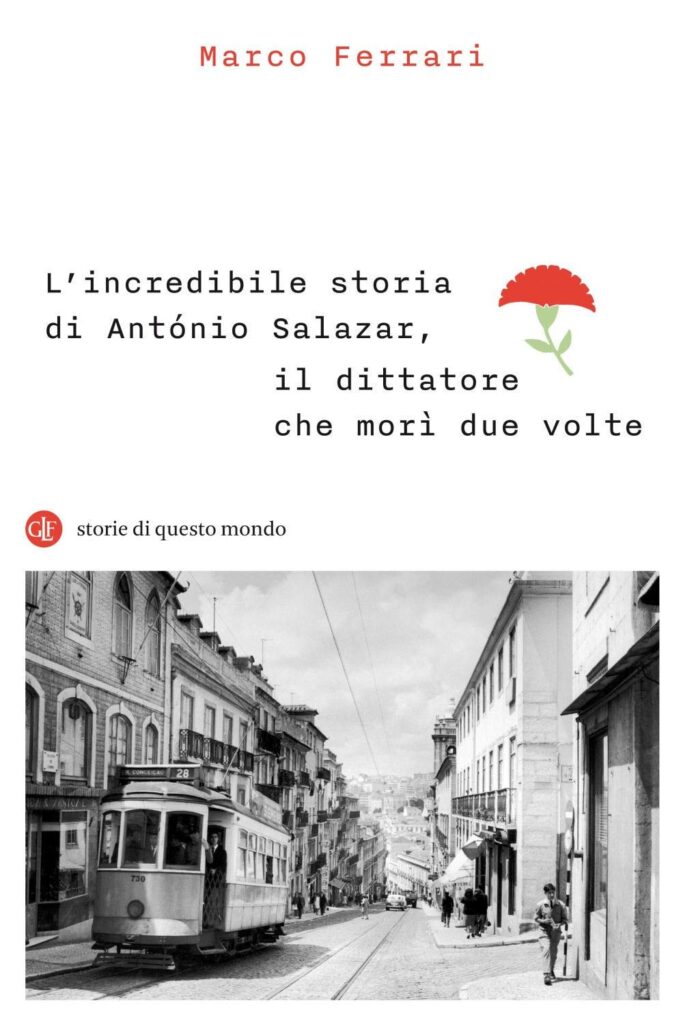
SINTESI DEL LIBRO:
Lo studente comparve davanti al Tribunale dell’Inquisizione padovano il
29 maggio 1555. La prima domanda che gli fu posta fu quella di rito,
l’invito a declinare le proprie generalità:
Io mi domando Pomponio Algiero de Nola del Regno de Napoli (DFC 1999, 238).
Algiero o de Algerio o Algieri: tutte varianti di uno stesso cognome che
doveva essere diffuso nel Napoletano. Qui si è preferito assumere la
seconda: quella, vedremo, che compare nel cosiddetto ‘libro dei fuochi’,
una specie di registro a un tempo dell’anagrafe e della consistenza
patrimoniale, ora conservato nell’Archivio di Stato di Napoli.
In un dispaccio del 24 agosto successivo l’allora ambasciatore presso la
Santa Sede, Domenico Morosini, riferisce che l’arresto avvenne per
ordine di Gerardo Busdrago, vicario del vescovo di Padova, il cardinale
Francesco Pisani (PP 1959, 119). Non conosciamo la data dell’arresto.
Conosciamo, invece, il luogo in cui avvenne. Ad oltre tre anni di distanza– l’11 novembre 1558 – davanti al Sant’Uffizio compariva tale
Hyeronimo de Stasiis, testimone nel processo contro certo Ippolito
Craya: sia de Stasiis che Craya, il primo «compare» dell’altro (FS 2008,
161), erano appartenenti alla nobiltà dell’isola di Veglia. Craya, qualificato
come «Dottor» (FS 2008, 161), aveva casa a Padova, nel quartiere Portello,
in cui risiedevano molti scolari dello Studio. Ora, nel costituto
processuale di de Stasiis, si legge che a casa di Craya – dove dovevano
albergare parecchi studenti – si viveva «a la lutherana» (FS 2008, 162).
A detta di de Stasiis, «a la lutherana» viveva anche Caterina, la moglie di
Craya, che avrebbe avuto «più mariti vivi» sparsi tra Piemonte, Padovano
e Regno di Napoli: appunto perché «cusì se fa a la lutherana» (FS 2008,
160, n. 18). Il marito napoletano di Caterina era tale Jacomo Castrucco
(o Castrocucco). Da una lettera del 2 gennaio 1559 inoltrata dal vescovo
di Veglia, Alberto Duimio, al Consiglio dei Dieci risulta che Pomponio
era «amico e compagno» di questo Jacomo (FS 2008, 162): de Stasiis
testimoniava al Sant’Uffizio che stavano entrambi nella casa di Craya,
probabilmente «a dozena», cioè pagando una somma mensile per vitto e
alloggio («quali tutti stavano in una medesma casa in Padoa»: FS 2008,
161).
E sempre a detta di de Stasiis, Pomponio era luterano come i padroni di
casa, anch’essi successivamente inquisiti: Ippolito Craya e i due giovani
napoletani avevano a che fare con lo Studio, il primo addirittura laureato
in utroque iure il 24 ottobre 1552, gli altri due ancora studenti. Da Ippolito
e Caterina – è scritto nella lettera di Duimio – tutti «vivevano a la
lutherana», irridendo durante la messa l’elevazione dell’ostia, da essi
ritenuta un semplice «pezzo di pane», e dedicandosi in casa alla lettura
quotidiana di lettere in materia di religione, provenienti da altri compagni
di fede (FS 2008, 162).
Il vescovo Duimio aveva processato Craya a Veglia prima che il caso
passasse all’Inquisizione romana; d’altra parte de Stasiis, chiamato a
testimoniare nel processo romano, doveva stare molto attento a non farsi
coinvolgere considerata la sua vicinanza al reo. Sicché è probabile che essi
abbiano enfatizzato questa vita «a la lutherana» evidenziandola come
pericolosa e deviata non solo dal punto di vista religioso. In questa
prospettiva non è casuale che entrambi abbiano addotto, quasi a prova
della depravazione, la presenza nella casa di Craya di Pomponio de
Algerio, la cui figura doveva essere assunta a modello del peggior eretico,
ribaldo, senza ritegno o rispetto, però attrattivo e perciò molto pericoloso.
Un modello vivo a distanza di anni dal rogo di Piazza Navona: è la
dimostrazione che questo studentello non doveva essere considerato alla
stregua di un eretico qualunque né da parte cattolica né – vedremo – da
parte protestante. Così accadde dagli inizi della sua vicenda di
persecuzione.
Il 29 maggio 1555 Pomponio fu interrogato – per la prima volta – nella
Sala podestarile (Camera) del Palazzo Pretorio di Padova: la Sala delle
Udienze, ultimata solo l’anno prima ad iniziativa del Podestà Stefano
Trevisan, che era nel collegio che quel giorno esaminò lo studente
arrestato e detenuto nelle prigioni dette ‘delle Debite’, annesse al Palazzo
Pretorio. L’inquisitore – Gerardo Busdrago, vicario del vescovo di Padova– non gli chiede cosa egli facesse a Padova, ma se fosse a conoscenza della
ragione per la quale era stato arrestato: anche questa, una domanda di
rito.
Pomponio dichiara di non saperlo nemmeno immaginare; e poi
aggiunge:
supplico la Illustrissima Signoria se degni come scolaro semo observarne la fede sotto della quale et
io et tutti li scolari qua semo che possiamo liberamente vaccare a tutte scientie che si legeno
publicamente in li Studii et de quelle dar conto (DFC 1999, 238).
Pomponio supplica di portare rispetto al suo status di scolaro e di non
attentare ai diritti che competono a qualunque scolaro: una supplica che
vale come sfida lanciata agli inquisitori – ‘scolaro’ era il termine con cui,
in quel tempo, era usuale indicare lo studente di uno Studio, cioè di
un’università. A questo scolaro, ricorda perentoriamente Pomponio,
spetta uno statuto che è come un corredo naturale negli Studii perché
congruo rispetto alla loro pubblica funzione: se negli Studii si apprendono
i saperi e si ricercano conoscenze sempre nuove, gli scolari debbono
potersi dedicare senza impedimenti al proprio acculturamento e
all’acculturamento altrui.
V’è da dire che al conflitto di opinioni sembrerebbe essere avvezzo
quello stesso ambiente ereticale patavino che sarà poi intensamente
frequentato da Pomponio. Ce lo conferma la deposizione resa agli
inquisitori il 2 ottobre 1553 da Giovanni Laureto – un frate, anch’egli
campano (di Cava de’ Tirreni) –, che riferisce dei «molti dispareri» che si
agitavano nella sua casa a Santa Caterina, una contrada esistente a Padova
dal XIV secolo e nella quale stavano gli alloggi dei professori giuristi, che
vi tenevano lezione:
Et havendo pigliata una casa a S. Catherina, li ditti Benedeto et compagni per far riduti et
congregationi, ci reducevamo tuti in ditta casa et qui ragionavamo di questa doctrina anabattistica
et ogniun diceva quel che li pareva, et tra nui erano di molti dispareri, ma nella doctrina lutherana
tuti eravamo d’accordo insieme (DFC 1972, 41).
Prima pagina del costituto padovano del 29 maggio 1555 (=ASV, Santo Ufficio, busta 13): vi si
leggono i nomi dei giudici, le generalità declinate da Pomponio, le prime risposte all’inquisitore.
Seconda pagina del costituto padovano del 29 maggio 1555 (=ASV, Santo Ufficio, busta 13): vi si
legge l’appello di Pomponio alla Signoria veneziana affinché garantisca la libertà sua e degli
studenti patavini di dedicarsi “liberamente ... a tutte scientie”.
Ora, la supplica di Pomponio de Algerio è veramente una sfida perché lo
studente esige che non si violi l’ideale («la fede») perseguito dagli scolari:
la dedizione libera alla scienza, anzi alle varie scienze che si coltivano
negli Studii, con la conseguente, inevitabile libertà di opinione. Ma a chi
è rivolta questa supplica? Al vicario Busdrago? Ai Rettori padovani? A
tutto il Tribunale? L’espressione adoperata da Pomponio – «supplico la
Illustrissima Signoria» – sembrerebbe lasciare pochi dubbi: la Signoria era
il supremo organo di governo, composto dal Doge, da sei consiglieri
ducali e dai tre Capi della Quarantia, che a Venezia era una giurisdizione
di vertice. Allora è corretto pensare che lo studente si appellasse a questa
Signoria, responsabile e garante della libertas promessa allo Studio della
Serenissima e ai suoi scolari. D’altronde, come vedremo, nel resoconto da
lui
scritto
proprio
Pomponio afferma che, negli affari
dell’amministrazione pubblica, egli riconosce – quali suoi Principi – il
Podestà di Padova e la Signoria veneziana: ora, la tutela della libertà di
scienza nello Studio patavino era affidata a quell’autorità che l’aveva
promessa, cioè il governo veneziano, che trovava la sua massima
rappresentanza appunto nella Signoria.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :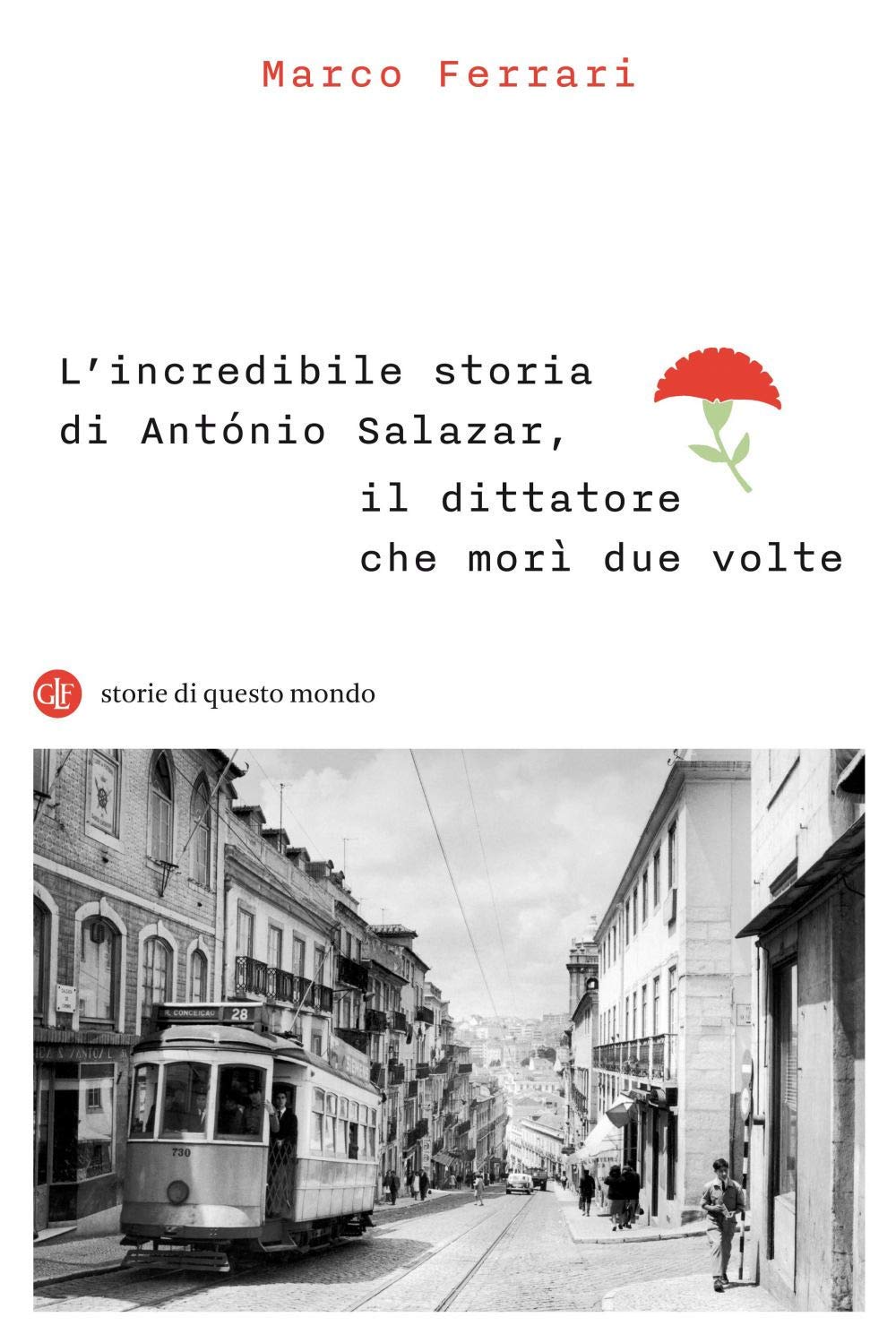






Commento all'articolo