Leggere – Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi – Corrado Augias
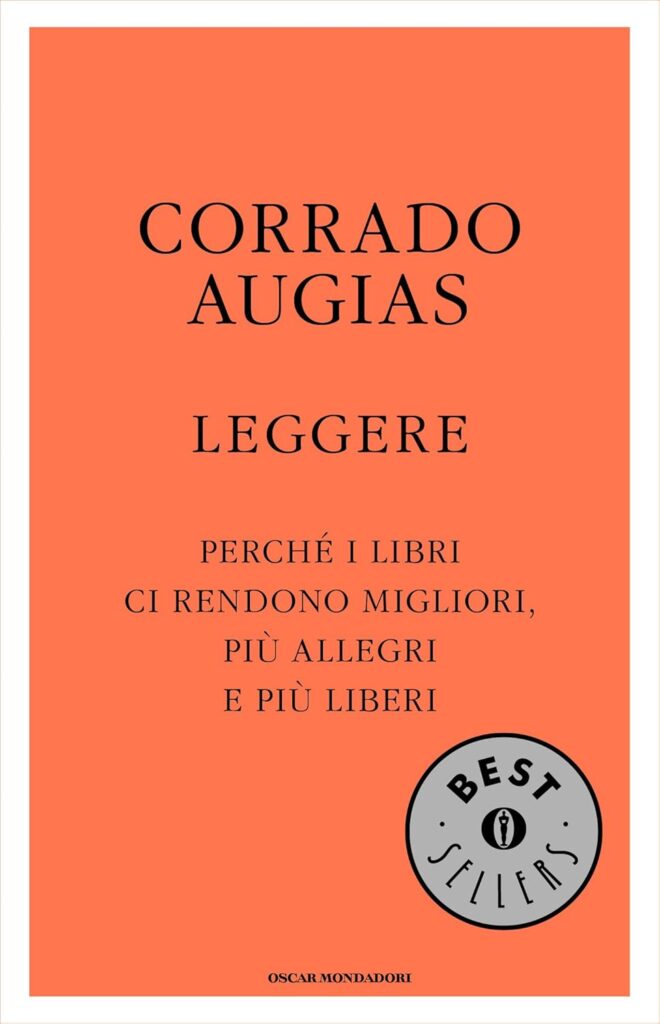
SINTESI DEL LIBRO:
Molti anni fa lessi una frase di Marcel Proust che mi parve subito assai bella
ma, per dire la verità, anche un po' eccessiva. Era il periodo in cui, come
scrive il poeta Giorgio Caproni, la vita s'avverte in modo più intenso: «Oh,
altezza / mai più raggiunta dal fuoco del cuore». Le parole di Proust, allora,
mi sembrarono troppo lontane da quel «fuoco del cuore». Dicevano: «Non
esistono forse giorni della nostra infanzia che abbiamo vissuto intensamente
quanto quelli che crediamo di aver perduto senza viverli, i giorni trascorsi in
compagnia di un libro molto caro».
È passato parecchio tempo e quelle parole mi sono tornate spesso alla
mente con un sapore sempre più intenso di verità. Non perché il «fuoco del
cuore» abbia attenuato le sue amme, che sarebbe una ragione troppo
biogra ca e un po' scontata; piuttosto, perché la lettura tende con gli anni a
diventare una specie di doppio dell'esistenza, anzi, un concentrato di
esistenza raramente eguagliato, per intensità, nell'ordinario scorrere delle
giornate.
Ho letto molti libri, alcuni per intero, altri parzialmente. Qualcuno l'ho
tralasciato dopo le prime pagine, qualche altro l'ho detestato. Con
l'esperienza ho imparato, credo, a riconoscere i libri che mi piacciono, i soli
che valga la pena di leggere per davvero. Diceva Franz Kaa: «Se il libro che
stiamo leggendo non ci colpisce come un soffio di vento nel cranio, perché
annoiarsi leggendolo? ... Un libro dev'essere l'ascia che spezza il mare
ghiacciato che è dentro di noi».
A dispetto di questa mia lunga esperienza, se dovessi rispondere alla
domanda del perché si legga, la ribalterei cominciando dalla domanda
opposta: perché si scrive?
La risposta più semplice è quella razionale: la scrittura è la forma migliore
di comunicazione, una forma, per ora, insuperata. Il mezzo è duttile, adatto
alla ri essione come all'impeto, si conserva nel tempo, consente
approfondimenti, richiami, citazioni altrui, sopporta qualunque indugio,
purché sapiente. Insomma, quanto di meglio per diffondere informazioni,
suggerire emozioni, stimolare reazioni d'ogni genere. Ma la scrittura, ecco il
punto, è anche una forma arti ciosa di comunicazione, diciamo pure la più
innaturale: una super cie, in genere bianca, viene ricoperta di piccoli segni,
in genere neri, che per convenzione hanno un certo suono e che,
raggruppati in parole e poi in frasi, assumono un certo signi cato. Si tratta,
com'è evidente, di un'attività puramente mentale, quanto di più lontano
dalla naturalezza.
In quest'ottica, leggere fa parte della stessa operazione mentale:
trasferendola in termini fotogra ci potremmo dire che si tratta del
«positivo» rispetto al «negativo» della scrittura. Il bello di quei piccoli segni
neri è che, scorrendoli con gli occhi (come state facendo ora), restituiscono
il valore che chi li ha scritti ha inteso dar loro. Lo restituiscono in misura
maggiore o minore obbedendo a una certa quantità di parametri, alcuni dei
quali tenterò d'illustrare in questa breve chiacchierata.
Nel suo Jacques il fatalista a un certo punto Denis Diderot fa pronunciare al
suo personaggio le parole: «Ma chi sarà il padrone? Lo scrittore o il lettore?».
Una prima risposta legittima è: entrambi. Alla libertà dello scrittore di
mettere su carta ciò che vuole (là dove abbia la possibilità di farlo senza
pericoli, beninteso) corrisponde, infatti, la libertà del lettore di interpretare
come meglio crede ciò che legge. Come si usa dire, e non si tratta di una
battuta, l'autore di un romanzo non è il suo miglior critico, anche se non
bisogna mai dimenticare che, fra le tante cose utili alla comprensione di un
testo, bisogna mettere pure ciò che Tommaso d'Aquino de niva quem auctor
intendit, le intenzioni dell'autore.
All'inizio degli anni Sessanta Umberto Eco, autore di precoce ingegno,
pubblicò un saggio dal titolo Opera aperta, che indicava come caratteristica
dell'opera d'arte la sua «apertura interpretativa». Se si può rispondere alla
domanda di Diderot sulla «proprietà» di un testo dicendo «entrambi», Eco
spingeva invece la questione al suo limite, teorizzando il paradosso secondo
il quale il vero padrone è in realtà l'interprete, cioè il lettore, o l'osservatore
nel caso di un'opera visiva. Tutte le grandi opere d'arte, sosteneva, non solo
quelle moderne, sono «aperte» a diverse possibilità di lettura, suscettibili
cioè di essere interpretate nei modi più vari.
Tipico della modernità è, però, che le opere sono spesso «aperte» in
maniera programmatica, dunque consapevole, n dall'inizio voluta. Negli
anni Sessanta erano in gran voga le avanguardie, e l'Opera aperta colse un
immediato e largo successo, fu il classico cacio sui maccheroni per un
movimento che cercava un suo «vangelo» e che in quelle pagine lo trovò. Per
la verità, quanto a opere prodotte, quel movimento non andò poi molto più
in là del «vangelo» iniziale, ma questa, come si usa dire, è un'altra storia.
Che cosa succede in realtà quando ci si lascia andare al piacere, o al dovere,
della lettura? Quali meccanismi emotivi si attivano? Quali frutti se ne
ricavano?
La lingua che suggiamo insieme al primo latte si chiama, non a caso,
«madre»; non è infatti meno madre delle mammelle (o del biberon) dalle
quali traiamo alimento. Il nostro grande umanista Leon Battista Alberti
esortava le donne che hanno cura dei bambini, madri o balie, a insegnare il
prima possibile l'alfabeto, anche in forma puramente visiva, associando ogni
lettera al suono. La lingua è «madre» perché ci permette d'intrattenere
rapporti con gli altri; ma, prima ancora, perché ci consente di pensare noi
stessi come individui, di capire (chi più, chi meno) chi siamo, in de nitiva di
esistere in quanto esseri pensanti. Se il pollice opponibile ha messo in grado
il genere umano di arrivare per evoluzione all'Homo faber, il linguaggio
articolato, i nomi delle cose hanno permesso la comparsa dell'Homo
cogitans.
Nella sterminata bibliogra a sul linguaggio che va da Aristotele a tutti i
grandi logici del Novecento, mi limito a citare l'opera di un losofo per il
quale nutro viva e crescente simpatia. Si tratta di John Locke, fondatore
dell'empirismo inglese, uno dei grandi teorici del liberalismo, autore di
quella Lettera sulla tolleranza che, insieme al saggio Sulla libertà di John
Stuart Mill, resta quanto di meglio la cultura occidentale abbia prodotto sul
tema dei diritti individuali e della convivenza civile.
Secondo Locke, le parole sono segni delle idee e poiché ogni idea è segno di
una cosa, le parole sono segni dei segni delle cose. Gioco di parole piacevole
ma anche pregnante. Locke ci dice che il linguaggio, segno convenzionale
delle idee, è lo strumento attraverso il quale l'uomo indica il proprio
pensiero e contrassegna la realtà. Con il tempo questo strumento si è
perfezionato grazie all'acquisita capacità di trasferirlo su un supporto
materiale, dal rotolo di un papiro allo schermo di un computer, insomma di
renderlo permanente, scrivendolo.
Per una curiosa coincidenza le idee di Locke sembrano avere un loro
completamento in un testo sapienziale ebraico composto circa dodici secoli
prima, il Sefer Yezirah. Dice il libro che Dio creò il mondo grazie a trentadue
vie segrete. Dieci sefiròt, o cifre, e ventidue lettere. Le sefiròt servirono a
creare le cose astratte, le lettere a dare origine a tutti gli esseri viventi. Nella
tradizione ebraica, insomma, l'universo è come un libro fatto di numeri e di
lettere. Chi è capace di padroneggiare la combinazione di questi segni può
interpretare correttamente il mondo e addirittura suscitare alcune forme di
vita. Poiché in quella tradizione non manca mai una complementare nota di
humour, dice una leggenda che due dotti talmudisti riuscirono
effettivamente a combinare lettere e numeri in modo così perfetto da far
scaturire dal nulla un vitello, che poi mangiarono allegramente a cena.
Non voglio farla troppo lunga, questo non è un trattato cabalistico né di
linguistica. Qui vorrei solo arrivare a dire in che cosa consista l'attività del
leggere, come si possa pro ttarne, quali conseguenze possa provocare.
La lingua è una struttura logica, non a caso nel Novecento tutti i maggiori
loso del linguaggio sono anche stati dei logici; ma la lingua è altresì un
noderoso sistema emotivo, capace di suscitare sentimenti non meno di
quanto sia in grado di trasmettere informazioni. Accade talvolta che il
linguaggio si imbrogli da solo creando un groviglio paradossale dal quale è
difficile uscire; avviene con i numeri guriamoci se non può succedere con
le lettere. Uno dei paradossi più citati, che risale addirittura all'antica Grecia,
è quello contenuto nella frase «Io sto mentendo», dove ciò che affermo è
vero solo se è falso. Se, infatti, sto veramente mentendo, allora quando dico
«sto mentendo» affermo la verità. Un altro paradosso di minor calibro ma
non meno inquietante sta nella domanda: «Che succede quando una forza
irresistibile incontra un ostacolo insormontabile?». Provate a rispondere, se
ne siete capaci.
Non sono solo giochetti. Il paradosso detto «del mentitore» fa vedere quali
attriti possano crearsi fra signi cante (l'immagine acustica associata al
concetto) e signi cato (il contenuto comunicativo di un'espressione
linguistica). Nel codice simbolico che si chiama «lingua» ogni termine resta,
infatti, puramente convenzionale, quale che sia la nobiltà della sua
provenienza. Faccio un esempio prendendo una qualsiasi parola di uso
comune come
MENTE
Cinque lettere alle quali possiamo dare almeno tre signi cati, a seconda di
come le decliniamo: la mente, le mente, egli mente. Non male in quanto ad
ambiguità.
Ma si può tentare di fare meglio prendendo un'altra parola di uso comune,
però ancora più ambigua:
SALE
Ho detto di «uso comune». Sì, ma quale? Queste quattro lettere, isolate da
un contesto al quale riferirle, perdono di signi cato, ovvero hanno una tale
quantità di possibili signi cati da non averne più alcuno. Solo per limitarmi
alla lingua italiana posso interpretare «sale» in tre modi diversi: il sale, le
sale, egli sale. Ma in inglese sale sta per «svendita», in francese per «sporco».
Dunque, cinque signi cati possibili, niente male per una banale paroletta di
sole quattro lettere.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :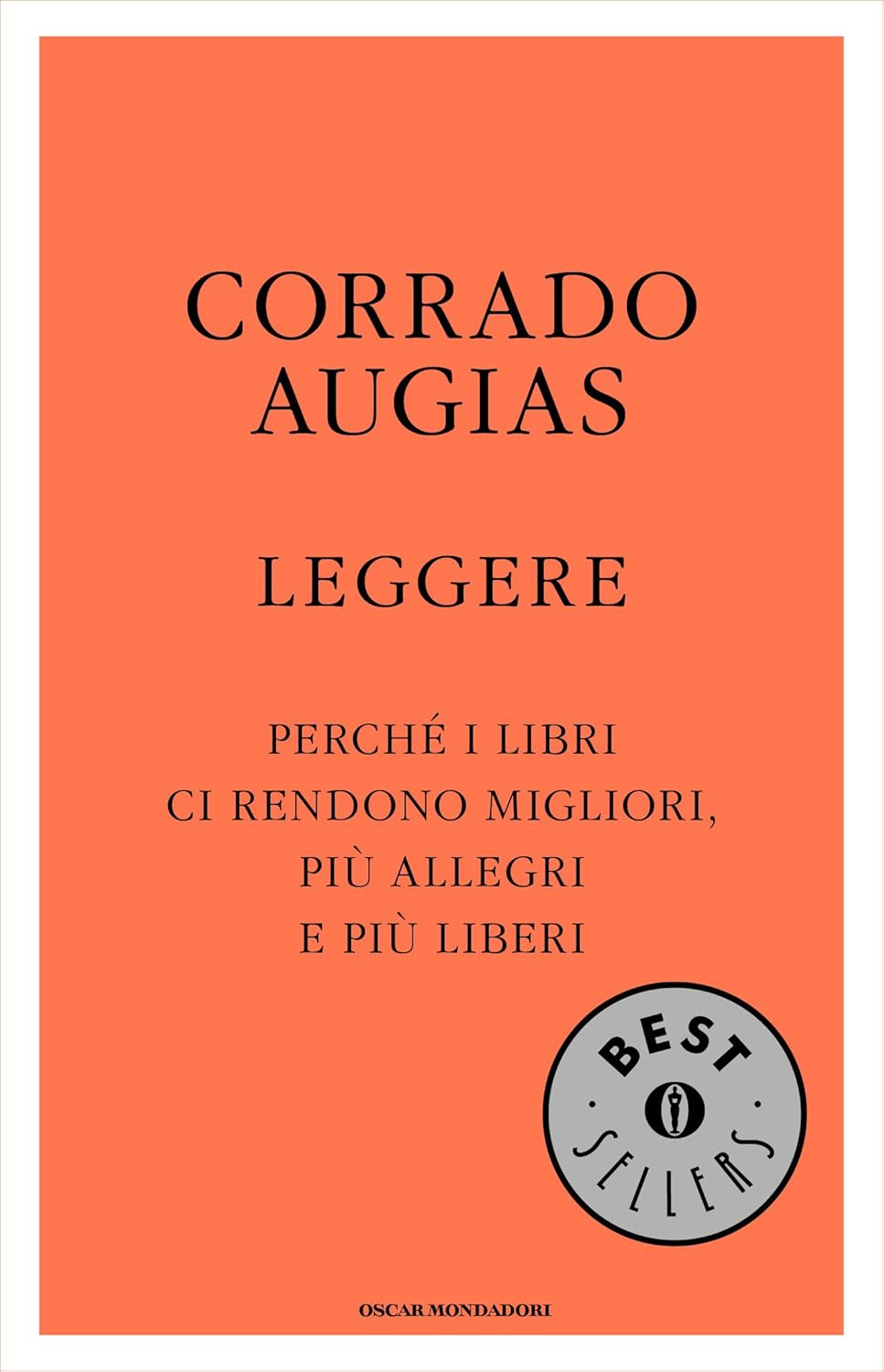





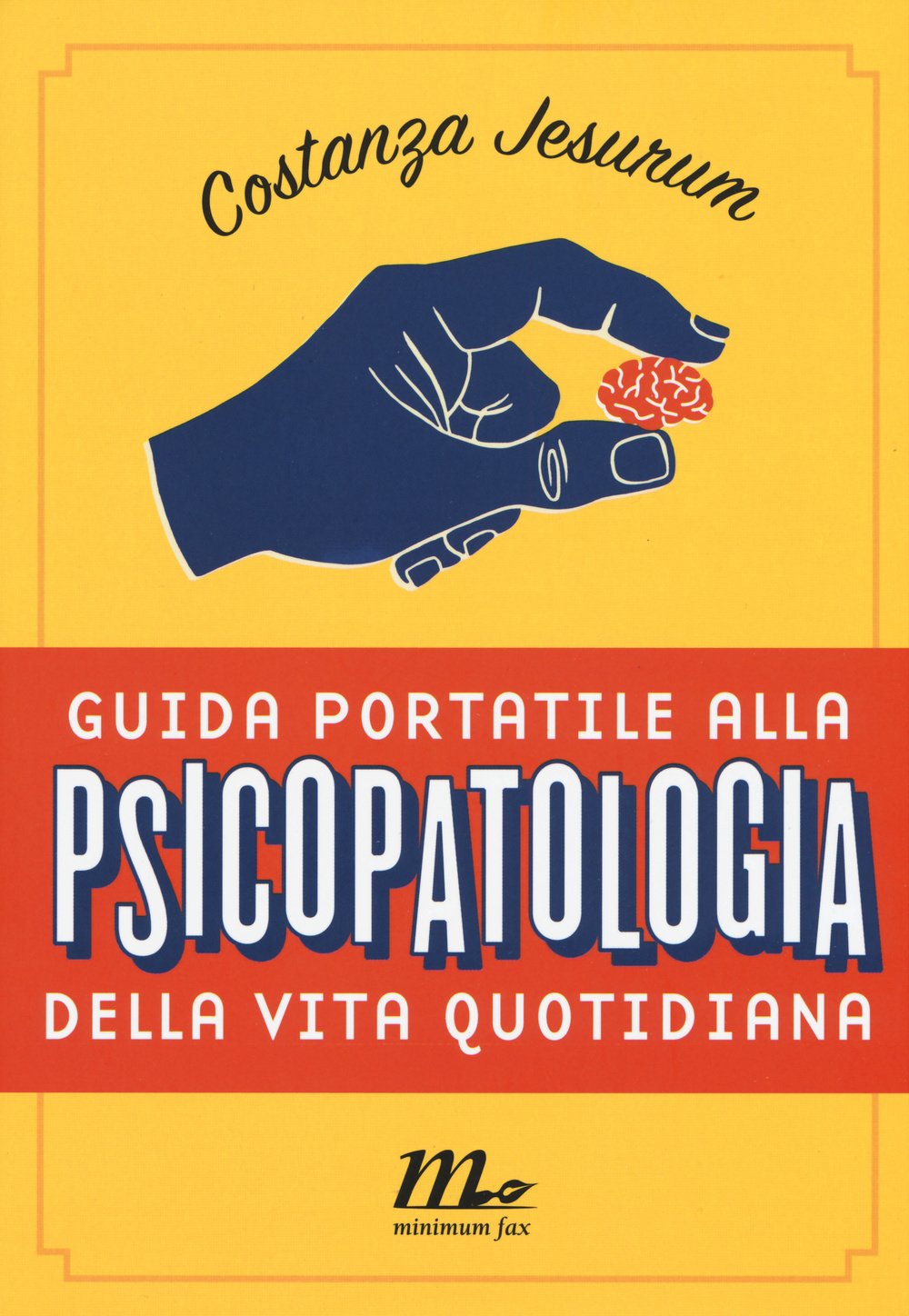
Commento all'articolo