Le due donne di Auschwitz – Lily Graham

SINTESI DEL LIBRO:
«Sei matta, Kritzelei?», le sibilò Sofie all’orecchio, gli occhi
sgranati pieni di paura, la cicatrice a zig-zag sulla testa rasata di
fresco che spiccava livida sul cranio pallido. «Vuoi proprio farci
fucilare? Cammina».
Sotto la pioggia torrenziale, Eva Adami incespicava negli zoccoli
spaiati troppo grandi e per poco non ne perse uno nel fango denso e
implacabile che si estendeva melmoso davanti a lei per centinaia di
metri. Era ancora buio, dovevano essere passate da poco le quattro
del mattino, malgrado le luci accecanti dei riflettori dessero
l’impressione che fosse pieno giorno. Si incurvò in avanti mentre
avanzava, nel tentativo di ripararsi dal freddo. Uno sforzo ingrato e
inutile. La pioggia sembrava quasi inclinarsi per dispetto, per
scivolarle dentro la scollatura. Eva detestava l’Appell. L’adunata
quotidiana che due volte al giorno le costringeva a trascinarsi fuori e
aspettare, con qualsiasi tempo, vestite o meno, di essere contate e
ricontate, per ore e ore, all’infinito. Disobbedire poteva costarti la
vita. Come, del resto, praticamente qualunque cosa in quel luogo.
Si girò a guardare l’amica, l’espressione stranita sul volto scarno,
gli occhi nocciola che sembravano ancora più grandi per via dei
capelli scuri tagliati a zero. «Siamo qui solo da una settimana. Così
ha detto Helga».
Seguì un sospiro lieve, poi un’imprecazione sommessa.
Una settimana. Lì.
Una settimana da quando erano state private della loro umanità.
Da quando erano state radunate come bestie e cacciate per giorni
su un treno ripugnante, tra tanfo di morte e degrado, in un ammasso
di corpi in cui era a malapena possibile respirare. Per poi arrivare nel
caos più assoluto: tra baccano, grida e mani brutali che le avevano
trascinate fuori, divise in gruppi e condotte in uno stanzone dove
erano state spogliate e costrette a sfilare nude sotto gli sguardi
lascivi delle SS per essere infine rasate da altre mani rudi. Dopodiché
erano state obbligate a rivestirsi rovistando in un mucchio di
indumenti usati e scompagnati e risputate all’esterno.
Eva non credeva che qualcosa potesse ancora scioccarla dopo
quanto aveva vissuto fino a quel momento, ma le parole di Helga vi
erano riuscite.
«Una settimana all’inferno», mormorò Vanda, facendo eco ai suoi
pensieri. I capelli rossi, la pelle diafana e le lentiggini ne tradivano le
origini ceco-ungheresi. «Sembrerebbe un’eternità». Anche lei era
arrivata con lo stesso treno. Avevano viaggiato in piedi per due
giorni. Con un secchio per il cibo e uno per le deiezioni da
condividere tra cinquanta donne.
«Credi serva più di una settimana a distruggere una vita?»,
mormorò Helga in tono scettico. Era sulla cinquantina, ma sembrava
molto più vecchia, con i capelli grigio scuro che le spuntavano in
ciuffi dritti sulla testa e gli occhi con lo stesso sguardo vitreo di molte
altre, come fosse un fantasma che cammina. Era arrivata diversi
mesi prima e il tempo cominciava a far sentire il suo peso,
soprattutto in termini di pazienza verso le nuove arrivate, come Eva.
«Non hai ancora capito che la vita può cambiare in un attimo?»,
chiese, battendo forte il palmo sul polso esile, e quel suono
improvviso come uno sparo fece trasalire tutte. Scosse il capo, poi si
rifiutò di girarsi a guardarle.
Eva lo sapeva eccome. Molto più di tante altre.
Eppure non riusciva a smettere di pensare che fino a una
settimana prima non aveva nemmeno idea che un luogo simile
concepito esclusivamente per lo sterminio –potesse esistere. Un
luogo che rendeva Terezín, il ghetto ebraico e campo di
concentramento alla periferia di Praga che era stato la sua casa
nell’ultimo anno, quasi un sogno.
«No, l’inferno sarebbe stato meglio», mormorò Vanda seguendo
con le altre Helga, che si era rimessa in cammino voltandosi a
guardarle con le labbra piegate in una parvenza di sorriso
sarcastico.
Tutte la fissarono disorientate quando un pastore tedesco prese
a ringhiare e a digrignare i denti, tirando il guinzaglio con il pelo ritto
sulla schiena, pronto a ridurle a brandelli e lasciare nel fango la scia
insanguinata dei loro resti.
Vanda scrutò il cane senza batter ciglio. «Almeno saremmo state
al caldo».
A Eva sfuggì una risata. Era incredibile cosa si potessero trovare
divertente in quella situazione.
Per il “pasto” di mezzogiorno aspettavano in fila il litro di minestra
prestabilito. Eva metteva le mani a coppa, senza mai riuscire a
trattenere la quantità di brodo annacquato che le spettava: senza
una scodella, infatti, nonostante gli sforzi il prezioso liquido finiva per
lo più a terra. Il cibo aveva un odore e un sapore strani. C’era chi,
all’arrivo, si rifiutava di mangiare, e persino lei – che arrivando da
Terezín già conosceva la fame – aveva faticato a ingurgitarlo
all’inizio, ma ora lo trangugiavano tutte con foga. Girava voce che le
guardie lo correggessero per tenerle buone e bloccare le
mestruazioni. Per il primo scopo non funzionava, quanto al secondo,
si sarebbe capito solo con il passare del tempo. Eva sospettava che
le razioni da fame avrebbero provveduto comunque in tal senso,
anche se non era una certezza, perché qualche poveretta
continuava ad avere il ciclo nonostante tutto.
La minestra aveva davvero un sapore terribile, eppure Eva
avrebbe pagato qualunque cifra per averne ancora. Non c’era spazio
nella sua mente per temere gli eventuali danni a lungo termine del
cibo potenzialmente avvelenato: al momento l’unica preoccupazione
era sopravvivere, e ciò implicava procurarsi altro cibo, in un modo o
nell’altro.
La sera verso le sette, dopo aver terminato la giornata di lavoro,
avevano a disposizione del “tempo libero” – che trascorrevano
comunque nelle baracche –, poi ricevevano una fetta di pane nero
da trecento grammi e un cucchiaino di marmellata o margarina a
testa, che dovevano bastare anche per la colazione. Poche
riuscivano a resistere e il mattino successivo erano costrette a
cominciare la giornata con un surrogato di caffè granuloso e privo di
sapore, finché finalmente non giungeva l’ora della minestra.
«La prima cosa che faremo», disse a Sofie dopo aver mangiato,
mentre una delle più “anziane” del campo riceveva una razione più
abbondante grazie alla tazza di metallo malconcia che stringeva tra
le mani, «sarà procurarci delle tazze, o magari delle ciotole».
Chi disponeva di un simile lusso si accaparrava razioni più
generose e persino pezzi di verdura più grossi. Un oggetto tanto
banale, che però in quel luogo faceva la differenza tra la vita e la
morte.
Sofie la osservò, poi scosse il capo e rise suo malgrado. Un
suono dolce e inaspettato, come un cinguettio di uccelli in un tetro
mattino invernale. «Una ciotola? Qui? Kritzelei, punti sempre alle
stelle. E come suggerisci di procurarcele?».
Per tutta risposta, le labbra di Eva fremettero e i suoi occhi
nocciola si illuminarono. Sofie l’aveva soprannominata Kritzelei
quando vivevano ancora a Terezín, dove si erano conosciute.
Significava “ghirigoro”, perché Eva tendeva a sognare a occhi aperti
e a vedere il mondo come avrebbe voluto che fosse. Un tempo era
stata un’artista e illustratrice con un futuro promettente, prima che i
nazisti decidessero altrimenti.
A Terezín, tuttavia, Eva aveva sfruttato la sua arte in altri ambiti,
facendo di necessità virtù. Come ridistribuire gli effetti personali di
cui erano stati privati, abitudine che veniva chiamata “prendere alla
Schleuse”, dal nome dell’area in cui i prigionieri venivano introdotti
nel campo e spogliati delle proprie cose. Prendere alla Schleuse non
era come rubare, ma piuttosto restituire, con l’aggiunta degli
interessi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :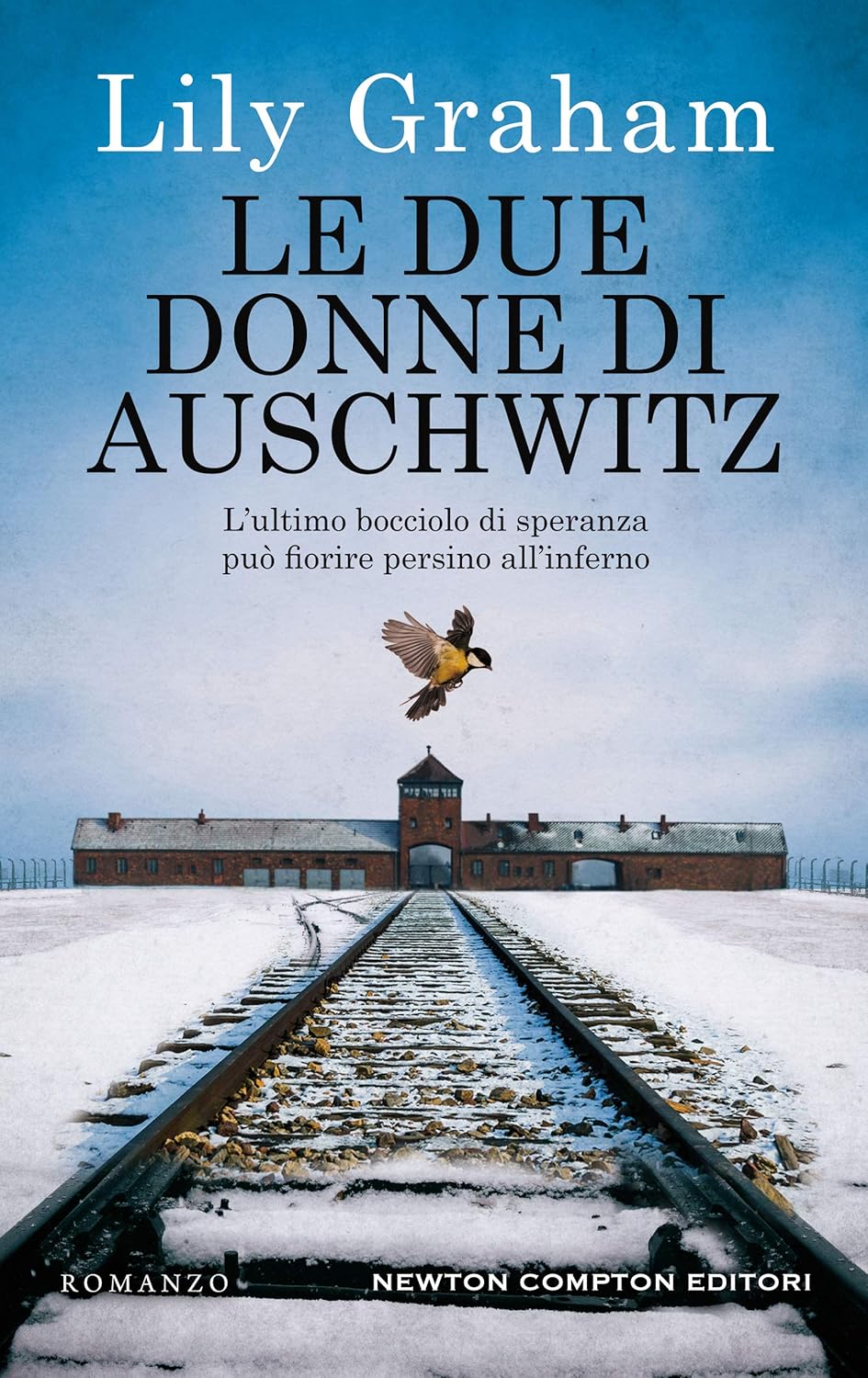






Commento all'articolo