Le cartoline di Leonardo – Margherita Melani
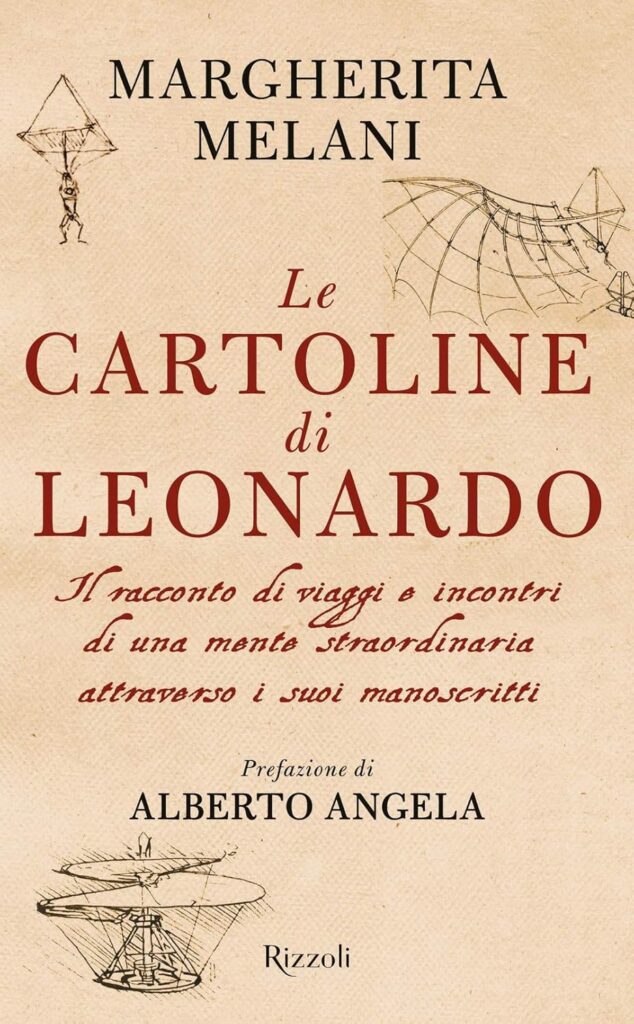
SINTESI DEL LIBRO:
Eccoci quindi iniziare il nostro viaggio sulle tracce di Leonardo da
Vinci partendo dal capoluogo lombardo, dove – come abbiamo visto– ha trascorso un terzo della sua vita.
Non è difficile immaginare quindi il forte legame dell’artista con la
ci à, che dal canto suo sembra in qualche modo “fregiarsi” dei suoi
illustri ospiti.
«Godi Milano che drento a le tue mura | De gli homini excellenti
hoggi hai li honori: | Del Vinci a’ suoi disegni e suoi colori | Et
moderni e gli antichi hanno paura». Così nel 1493 Bernardo
Bellincioni, poeta della corte sforzesca, ricorda Leonardo nelle sue
Rime.
Il primo documento che a esta la presenza di Leonardo a Milano è il
contra o di so oscrizione per la realizzazione della Vergine delle rocce,
datato 25 aprile 1483, ma possiamo supporre che Leonardo sia
arrivato in ci à intorno al Carnevale del 1482.
Come abbiamo visto, non era solito lasciare nulla al caso e anche
per questa occasione troviamo nei suoi manoscri i una traccia che ci
fornisce un affascinante spaccato di Leonardo e del suo tempo.
Risale infa i al suo arrivo a Milano alla corte di Ludovico il Moro
una pagina del Codice Atlantico1 paragonabile a un vero e proprio
curriculum di Leonardo, una le era di presentazione de agliata e
completa che potesse dare al nuovo mecenate una panoramica delle
sue capacità e delle sue competenze.
Il biglie o da visita dipinge Leonardo come un ingegnere in grado
di soddisfare tu e le esigenze del suo signore, siano esse di tipo
militare che civile.
A lungo gli studiosi hanno discusso se si tra i di una bozza reda a
so o de atura di Leonardo (ipotesi avvalorata dalla presenza di
numerose correzioni e abbreviazioni) o di una copia da un testo
autografo perduto o non identificato; quello che è certo è che il verso
del foglio contiene disegni a mano di Leonardo. L’ipotesi più
verosimile è che quella giunta fino a noi sia la copia di un originale
perduto, realizzata all’interno della stessa bo ega di Leonardo e
reda a da una mano da identificare. Possiamo invece solo avanzare
ipotesi su cosa spinse l’artista a redigere questo curriculum e se arrivò
mai nelle mani di Ludovico il Moro.
In realtà al suo arrivo a Milano Leonardo fu subito molto
apprezzato a corte come suonatore di lira – sappiamo che ne
possedeva una in argento a forma di teschio di cavallo che si era
costruito da solo – e come «dicitore di rime a l’improvviso».2 È facile
immaginare Leonardo, piacevole nella conversazione, che ben presto
ca ura l’a enzione recitando componimenti poetici.
Oltre a intra enersi a corte, Leonardo si muove con disinvoltura
tra le vie e le be ole ci adine; proviamo allora a seguirlo mentre gira
per Milano alla ricerca di volti per il Cenacolo. È un osservatore
a ento, che porta sempre in tasca un taccuino di piccole dimensioni
su cui disegna quello che vede e annota le proprie riflessioni
estemporanee, cercando tra la folla riferimenti e modelli ben precisi
per gli apostoli: sappiamo che Leonardo voleva volti segnati dalle
vicissitudini personali, perché ogni personaggio doveva esprimere in
modo chiaro il proprio cara ere.
Possiamo solo immaginare quanto possa essere stata ardua
l’impresa quando cercò “modelli” per i volti di Cristo e di Giuda: per
il
primo non osava immaginare bellezza terrena in grado di
rappresentare la divinità, per Giuda invece non era in grado di
concepire il volto di un uomo che, dopo aver ricevuto tanti benefici
dalla vita, era stato capace di tradire il suo Signore. Anche il cinema
ha provato a dare la propria versione di questo momento della vita
dell’artista. Nel film L’ultima cena di Luigi Giachino (1948) vediamo
Leonardo scegliere come modello per Cristo un giovane nobile
milanese dal cuore tormentato perché innamorato di una fanciulla di
umili origini a cui deve rinunciare. In preda al dolore il giovane parte
per un viaggio in cui resta coinvolto in un omicidio del quale viene
ingiustamente accusato. Al suo ritorno a Milano il dolore e
l’ingiustizia gli hanno talmente cambiato le fa ezze che Leonardo
vedendolo in una be ola lo sceglie per l’immagine di Giuda e solo in
un secondo momento si accorge che era la stessa persona che, molti
anni prima, aveva fa o da modello per l’immagine del Salvatore.
Come in tu i gli aneddoti, anche in questo si mescolano realtà e
f
inzione. Nel dipinto di Leonardo i volti di Cristo e Giuda sono
diversi, ma quali siano stati i modelli dell’epoca cui si è ispirato resta
un particolare avvolto nel mistero.
A Milano Leonardo si trova per la prima volta fuori dalla sua
Toscana, lontano dai suoi riferimenti culturali e figurativi, e non è
difficile immaginare quanto debba essere rimasto colpito da quello
che vedeva. Nonostante ciò, nella mole di materiale autografo non
resta traccia della sua reazione davanti al cantiere del Duomo di
Milano (così profondamente diverso da Santa Maria del Fiore!),
ancora privo della copertura del tiburio ma già adornato da
numerose guglie che sve avano verso il cielo; non sono giunte a noi
nemmeno note sulla basilica romanica di Sant’Ambrogio, o sulla
geniale quanto audace soluzione utilizzata da Bramante per il finto
coro della basilica di Santa Maria presso San Satiro. Tu i luoghi che
Leonardo ha sicuramente visto e che conosce bene.
Tra gli scri i, un breve accenno è dedicato al «barco [parco] del
Duca», un’ampia area verde recintata popolata di animali selvatici e
dotata anche di una peschiera, un fru eto oltre a vaste aree coltivate.
Curiosamente l’ogge o dell’interesse di Leonardo è una «ballo a»,
una palla di cannone, di grandi dimensioni, del peso di «se ecento
libre e» e alta più di un braccio, che il pi ore probabilmente ha visto
durante una visita al parco; a questo proposito ricorda che lanciata
riuscì a compiere ben vento o balzi.3 Nella stessa pagina, l’ingegno
di Leonardo, che ormai stiamo iniziando a conoscere, approfondisce
il lancio, «balzo», di un proie ile. Nel parco del Duca, poi diventato
piazza d’Armi per le guarnigioni straniere prima di essere
nuovamente convertito nell’a uale Parco Sempione, al di là
dell’interesse per questa enorme palla di cannone, l’artista si sofferma
anche a descrivere il padiglione del «zardino» della duchessa4
all’interno del labirinto: una stru ura circolare, con colonnato, chiusa
da una cupola e circondata dall’acqua, già esistente almeno dal 1480.
Altro luogo milanese documentato negli appunti di Leonardo è il
Castello Sforzesco, stru ura che conosce bene e che, molto
probabilmente, è alla base delle note di archite ura militare di una
pagina del Manoscri o B dove troviamo anche osservazioni sulle
fortezze e l’immagine di una chiesa a pianta centrale.5 Ma questo non
è l’unico riferimento del pi ore al castello; infa i nello stesso taccuino
che risale ai suoi primi anni lombardi ne descrive la «ghirlanda»: una
vera e propria cinta muraria, con torri angolari rotonde e una strada
coperta, posta a difesa della parte nord del Castello Sforzesco e che fu
demolita nel 1893. Nei propri appunti Leonardo dimostra di
apprezzare questa stru ura, ma nonostante ciò pensa a come
migliorarla per aumentarne la sicurezza in caso di a acco con armi
da fuoco:
I fossi del castello di Milano di dentro alla ghirlanda è braccia 30, l’argine sua è
alta braccia 16 e larga 40, e questa è la ghirlanda. I muri di fori sono grossi
braccia 8 e alti 40, e le mura dentro del castello sono braccia 60.
Il che tu o mi piace, salvo ch’io vorrei vedere le bombardiere che sono in e
muri della ghirlanda, non reuscissino in nella strada segreta di dentro, cioè in S,
anzi si calassi per ciascuna, come appare in M f, imperò che sempre i boni
bombardieri tralgano [traggano] alle bombardiere delle fortezze, e se rompessino
in de a ghirlanda una sola bombardiera, possano poi con via di ga i entrare per
de a ro ura e farsi signori di tu e torri, muri e cave segrete di de a ghirlanda.
Onde se le bombardiere saranno come M f, e che li accadessi ch’una bombarda
rompessi una di de e bombardiere, e ch’e nimici entrassino dentro, non possano
passare più avanti, anzi fieno dal piombatoro di sopra reba uti e discacciati. E la
cava f vol essere continuata per tu i i muri dai 3/4 in giù, e da lì in su non abbia
us[c]ita alcuna né in su’ muri né in torri, salvo quella donde s’entra, che arà
principio nella rocca. E de a via segreta f non de’ avere alcuno spiraculo di fori,
anzi pigli i lumi di verso la rocca per le balestriere spesse.
Forse l’unica stru ura che veramente ca urò l’a enzione di
Leonardo al suo arrivo a Milano fu la chiesa del Santo Sepolcro:
edificio di impianto romanico, ampiamente rimaneggiato in varie
epoche, organizzato su due livelli di uguali dimensioni. Leonardo
disegna la pianta della chiesa inferiore e di quella superiore in
un’unica pagina del Manoscri o B.6 Molto probabilmente fino a quel
momento aveva visto chiese con cripta inferiore – come la basilica di
San Miniato al Monte sopra Firenze – ma mai edifici religiosi su due
livelli uguali, una peculiarità riscontrabile in Italia nella chiesa
milanese del Santo Sepolcro e nella basilica di San Francesco d’Assisi,
altra stru ura romanica che all’epoca Leonardo non aveva ancora
avuto modo di vedere.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :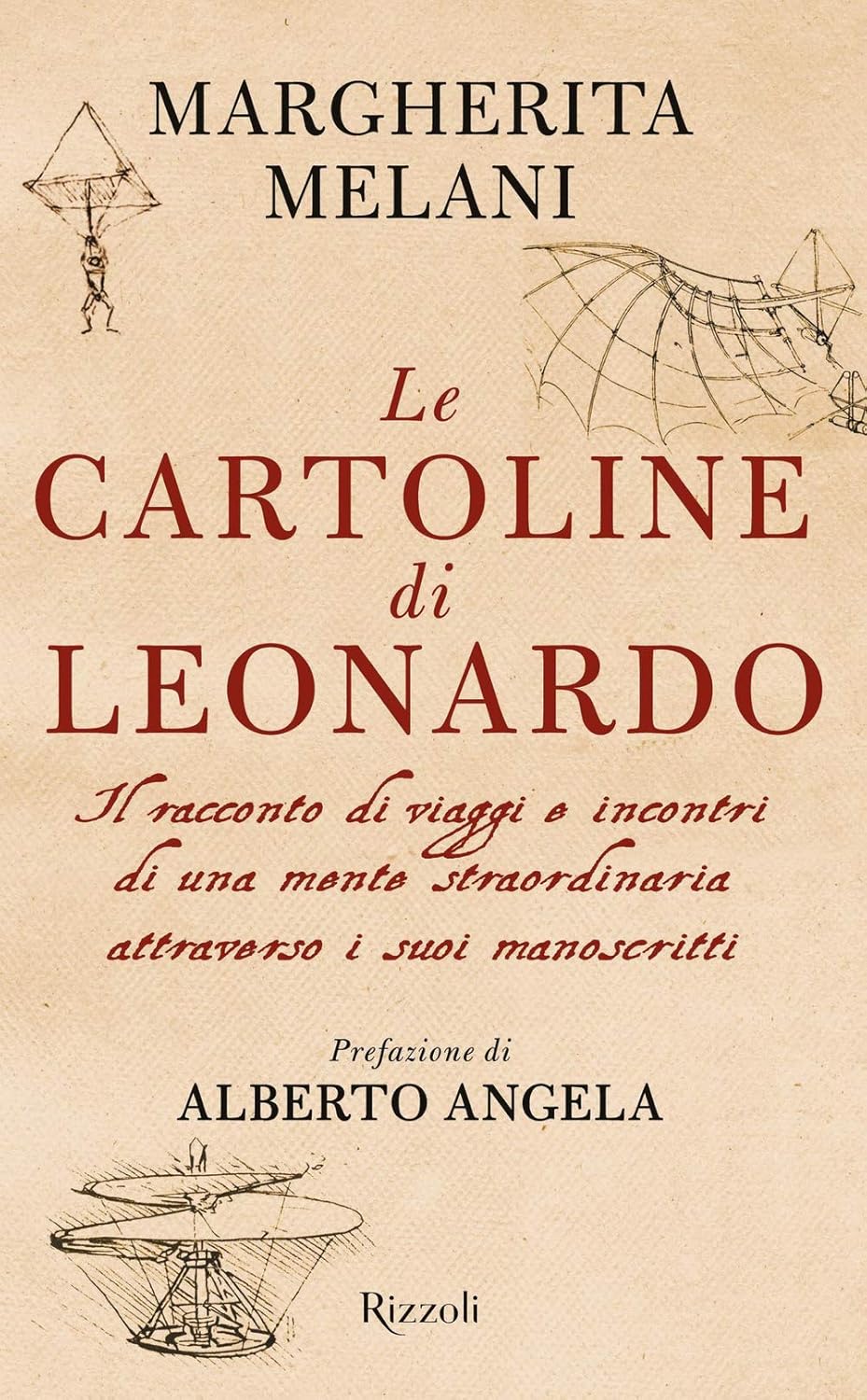






Commento all'articolo