Il grande califfato – Domenico Quirico

SINTESI DEL LIBRO:
Se chiudo gli occhi oggi, ora, posso vedere le sequenze dell'ultimo
selamlik, dell'ultima parata del califfo dei credenti. Sono davanti alla
moschea che fronteggia il palazzo Dolmabahge a Istanbul: il frastuono del
traffico, il caos della moderna città, che non c'era quel 29 febbraio del 1923,
non conta nulla. Nemmeno l'orribile albergo in vetrocemento che
insolentisce la collina dove un tempo c'era una pineta. Ah! L'Istanbul di
Erdogan resta incredibilmente quella che ne fecero i turchi: una città senza
tempo. Qui gli edifici sono itinerari, progetti di occupazioni articolate dello
spazio e del tempo, e hanno un rapporto di complicità, anche i più brutti,
con il luogo in cui sorgono. Inafferrabili e drammatici, non di rado sono
un'enfasi da tragedia classica.
Si sbuca alla cima dei colli come davanti alla superficie del mare. Le
cupole dei seminari intorno alle moschee rendono il paesaggio vastissimo,
come un lontano ondeggiare di dune; le tombe dei sultani, delle loro mogli,
dei capitani delle loro guerre interminabili che iniziavano puntuali ogni
primavera, degli scrivani celebri, si stendono come se riposassero durante
un lungo viaggio; sono cose di ieri e di cinque secoli fa.
Non si pensa a niente, non si ricorda niente: tutto è contemporaneo. Il
senso musulmano del tempo: un eterno presente di sensazioni passioni
emozioni rabbie che spiega molte cose di quello che sta oggi accadendo;
anche qui dove l'unica rivoluzione riuscita davvero nel mondo dell'Islam sta
retrocedendo e si fa opaca. Un partito islamista è ormai saldo al potere,
tornano i veli, alla frontiera, a sud, un nuovo califfo fa sentire i suoi
cannoni... Nulla è definitivo ed eterno. Sul Bosforo l'epoca delle moschee,
dei dervisci, dei seminari sembrava finita, laddove si sentivano le preghiere
dei dervisci e i loro ululati santi, si ascoltavano le canzoni di Madonna e le
moschee avevano la solitudine di musei.
Venivamo a Istanbul per rassicurarci: ecco l'Islam che ci piace,
modernizzato relativo tiepido come le nostre fedi, in fondo domato e
irrilevante. Di Istanbul, chissà perché, ho sempre amato i cimiteri. I turchi
seppellivano i loro morti in campi aperti presso la città o nei giardini tra
casa e casa; lapidi incastrate verticalmente su un'altra orizzontale, sulla
lapide un versetto del Corano. E la lapide delle donne era coronata da una
ghirlanda di rose scolpita, la pietra sembra acquistare una rotondità
femminile. Cinque secoli di storia erano qui, non uno di meno. Nessuno
aveva mai messo mano a quelle tombe, sul terreno cedevole le stele si
chinavano, rotolavano sulla strada e si camminava su un selciato di lapidi
come su teste troncate.
Il grande cimitero di Scutari è ora un intrico di strade, tutto annega in un
oceano di cemento, case e caseggiati, il Bosforo, "le dolci acque d'Europa",
"il diamante tra due smeraldi", è una cloaca, i colli sono il groppo piagato di
ville e di casermoni, l'automobile regna.
È l'ora di una delle preghiere: davanti a me un ragazzo elegante, la barba
curata, srotola il suo tappetino e inizia a inginocchiarsi ritmicamente. In
tutto il mondo questo rito si ripete per milioni di uomini: adesso. Genti
innumerevoli vivono nell'attesa della preghiera e raramente una religione ha
conservato tanto il colore originale di tutte le fedi, che è una opposizione
alla vita terrena, un continuo ammonimento alla vanità delle cose umane,
una evasione al cielo. E questo è forse la causa principale di molte vicende
che stanno accadendo.
La Storia lascia suoni odori, lievita nell'aria se la sai ascoltare.
Ecco: rivedo la parata del 1923. Abdul Mejid, l'ultimo califfo della
dinastia ottomana, il Servitore dei Due Luoghi santi è lì, il bel volto di
vecchio, la barba bianca e cespugliosa, il fez rosso che dà colore al nero
funebre dell'abito. La banda suona, e i soldati, i granatieri della guardia,
sfilano, e il califfo si sporge dalla sua carrozza. Non è venuto, come di
solito, montando il cavallo bianco di nome Konya che gli era stato donato
da Refet Pasha, il dubbioso governatore della città scelto da Kemal.
Dalla carrozza il sultano si inchina da un lato e dall'altro alla folla che
ancora lo applaude. Non porta più la spada di Osman, il fondatore della
dinastia: perché non è più sultano, la carica è stata già abolita.
Tutto è accaduto ad Ankara, la nuova capitale, all'assemblea nazionale.
Uno dei discorsi assassini di Kemal: «Fu con la forza che i figli di Osman
conquistarono la sovranità e il sultanato della nazione turca, quella
usurpazione l'hanno conservata per secoli... Ora la nazione turca si è
ribellata, ha intimato l'alt a quegli usurpatori e ha preso nelle sue mani, a
tutti gli effetti, quella sovranità e il sultanato...»
Nella mozione i deputati, obbedientissimi, hanno scritto parole di fuoco.
Bollando la follia la depravazione il tradimento della Sublime Porta nel
corso dei secoli... Con la schiena piegata da quegli insulti è partito per
l'esilio, a Sanremo, l'ultimo sultano e suo predecessore, suo cugino
Maometto VI.
Il giorno della nomina a califfo da parte dell'Assemblea, tre mesi prima,
Abdul Mejid è andato a pregare alla moschea Fatih: per la prima volta nella
storia in turco e non più in arabo (quanti segni contraddittori e ogni segno
una pugnalata, come avrebbe potuto resistere un uomo?).
Le vie della città sono piene di popolo plaudente arrampicato perfino
sugli alberi. Califfo dunque, non sultano: gli resta la nominale, ah, quanto
nominale, guida dei credenti, trecentocinquanta milioni di musulmani: ma
dei turchi no, quelli sono musulmani ma ormai non gli appartengono più,
appartengono a Kemal.
Il califfo è un uomo dolce e affabile, aristocratico fino al midollo, di
grande cultura. Ha passato cinquantanni nel suo palazzo sul Bosforo, tra
libri, quadri e la cura delle rose. Non è un intrigante o un ambizioso,
preferisce abbandonarsi ai suoi gusti, completare ad esempio la
straordinaria collezione di miniature persiane. Ma il vecchio regime, i suoi
personaggi tarlati, ulema, generali in pensione, funzionari licenziati, si
ammassano inevitabilmente attorno a lui.
È una distinzione tecnicamente assurda: i poteri del sultano e quelli del
califfo sono indivisibili. Un califfo che sia solo capo spirituale: ma è un'idea
presa a prestito dall'Occidente, il turco sa bene che il califfato è una carica
politica, è un sovrano temporale.
Eppure... Anche ora, a ogni segno del califfo le acclamazioni aumentano
e lui tende le labbra in un ampio sorriso, portando con eleganza la mano al
fez scarlatto. Chissà quanto costa al califfo ognuno di quei sorrisi! Fanno
credere a Mejid che ha sognato quel suo palazzo prigione, ma non è forse lo
stesso Mejid un sogno di Ataturk che lo ha messo sul trono per evitare
conseguenze di "spiacevole natura"?
Il 15 Ramadan, ultima cerimonia di venerazione delle reliquie del
Profeta, si tocca, palpabile, l'insofferenza. Dopo un selamlik, fatto
scandaloso!, si è levata ben chiara dalla folla una voce di donna: «A cosa ci
è servito il califfato durante la guerra quando morivamo di fame e i nostri
figli venivano uccisi a migliaia? Avete proclamato una guerra santa e a che
cosa è servita?»SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






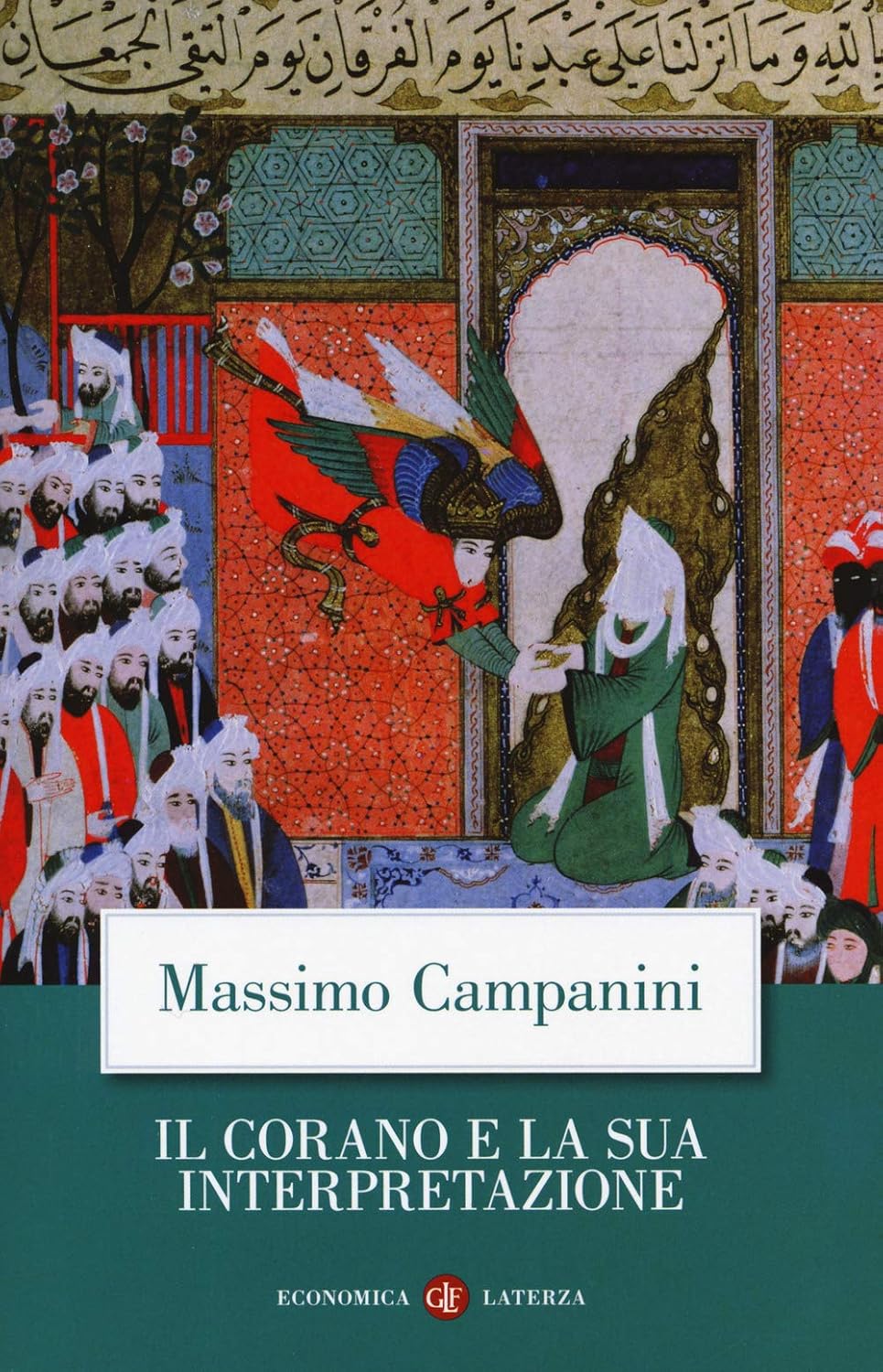
Commento all'articolo