La storia spezzata – Aldo Schiavone
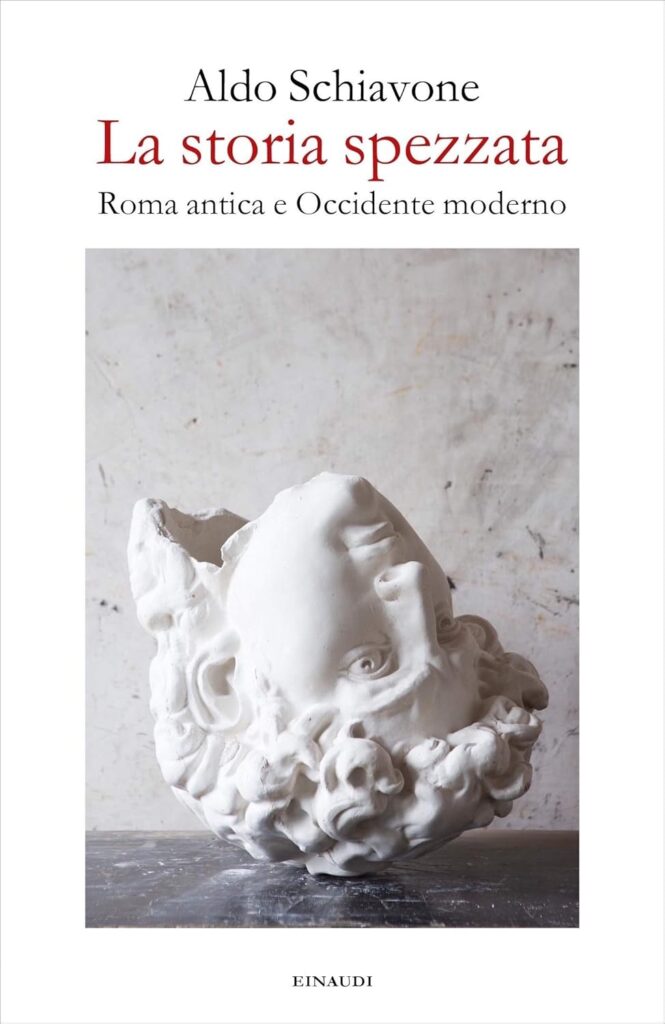
SINTESI DEL LIBRO:
Intorno alla metà del II secolo d.C., nella primavera di un anno
che non siamo in grado di indicare con certezza – il 143, o il 144, ma
c’è anche chi ha proposto una data diversa – un giovane e brillante
retore di lingua greca, nato ed educato nella lontana provincia di
Misia, in Asia Minore, tenne a Roma, innanzi alla corte imperiale, un
discorso destinato a restare famoso. Le conferenze pubbliche erano
la grande moda del momento. La qualità dell’ascolto prescriveva la
forma dello stile; e la vita intellettuale amava rappresentarsi come
votata alla scena, al gusto per le parole ben scelte e ben pronunciate
ricalcando gli antichi maestri, e per ogni occasione mondana di
incontro e di socialità.
L’oratore si chiamava Elio Aristide, ed era stato invitato grazie ai
buoni uffici del suo maestro Alessandro, che aveva contribuito
all’educazione di Marco Aurelio, e poteva contare su amicizie
influenti.
La manifestazione si svolse nell’Athenaeum, il nuovo magnifico
edificio voluto da Adriano come centro di promozione e di studio
della cultura greca, di cui oggi non rimane traccia, ma che doveva
trovarsi vicino al Foro di Traiano, nel cuore della capitale. Il tema sul
quale Aristide intrattenne il suo pubblico – fra gli ascoltatori vi era
forse l’imperatore Antonino in persona – non si poteva giudicare, per
quei tempi, di particolare originalità. L’argomento era un elogio di
Roma: il carattere della città, il confronto con gli imperi del passato,
la ricchezza dei consumi e delle abitudini, la bontà delle istituzioni e
del governo. Si trattava – a nessuno poteva sfuggire – di un soggetto
di maniera, probabilmente imposto dall’occasione: Aristide era stato
chiamato nell’ambito delle cerimonie per la ricorrenza del natale di
Roma.
Il
retore dovette però impressionare il suo uditorio, abituato a
distinguere fra un lealismo politico letterariamente decoroso, e la
piaggeria delle tante mezzefigure che si aggiravano ai margini della
corte, arrivate da ogni parte dell’impero. Sta di fatto che egli fu da
quel momento in rapporti con ben tre imperatori: dell’incontro con
Antonino abbiamo un ricordo diretto, affiorante in una visione onirica
dello stesso Aristide, riportata nei Discorsi sacri. E dopo, conobbe
Marco Aurelio – disposto a lunghe attese pur di ascoltarlo – e
Commodo.
Il giovane era destinato a rivelarsi tutt’altro che uno sprovveduto.
La sua vita, divisa fra malattie – psicosomatiche, è stato sospettato a
ragione – viaggi e ininterrotta registrazione dei propri sogni
(trecentomila righe di uno sterminato diario notturno: ma anche
Artemidoro, in quei medesimi anni, si appassionava a raccogliere e
collazionare testimonianze di sogni), fu un esempio significativo di
quel legame fra introspezione, ricerca dell’occulto, ascesi, ed
esercizio disinteressato del potere, che sembrava compensare le
superficiali frivolezze dell’epoca, e che con Marco Aurelio era
arrivato a coinvolgere la stessa personalità dell’imperatore. La sua
cultura, fra retorica e filosofia, si connetteva con una certa dignità a
quel movimento di idee e di convinzioni classiciste a volte
pedantemente anticheggiante, a volte piú serio e motivato, che
Filostrato avrebbe definito «seconda sofistica», e che dobbiamo
considerare come uno dei filoni piú rappresentativi del pensiero di
quei decenni.
In effetti, se riusciamo ad allontanare il discorso romano dalla luce
sfavorevole che possono proiettarvi le circostanze – un encomio
dell’impero pronunciato innanzi alla corte da un autore in cerca di
successo può non figurare a prima vista come un esempio di
indipendenza morale e di autonomia intellettuale – quel testo non
appare né piatto né insignificante. Le sue fonti, che gli studiosi
moderni hanno individuato con cura – Platone, Isocrate, Polibio,
Plutarco e molto altro ancora – non erano rielaborate in modo
scadente o volgare. La prosa e la costruzione concettuale riuscivano
a non annegare quasi mai in quell’oceano di luoghi letterari e di
senso comune cui pure Aristide si compiaceva talvolta di lasciarsi
andare, seguendo il gusto dominante.
L’orazione nasceva invece da un sentimento di pienezza e di
compiutezza civile, da una persuasione profonda di poter cogliere
nei tratti del secolo il segno del realizzarsi di un antico destino, che
sapevano diventare, oltre ogni manierismo, autentica interpretazione
del proprio tempo.
Ad Aristide era certamente noto che circolavano fra i suoi
contemporanei molte dottrine sulla missione universale di Roma. In
quegli anni, c’era persino chi, fin dal nome stesso della città, riteneva
di poter trarre un’indicazione predestinatrice: e rovesciando le lettere
della parola nota a tutti, immaginava di poterne scoprire un’altra
(«amor») ritenuta allusiva e segreta. Ma il retore riuscí a sollevare il
suo discorso al di sopra della piccola cerchia dei profeti del già
accaduto, per trovare la via di una lettura che univa alla modestia di
una fedeltà politica professata senza il minimo dubbio, l’orgoglio di
chi si riteneva in grado di chiarire ai padroni del mondo il significato
della loro stessa storia.
La conquista romana di un impero sterminato appariva ad Aristide
come un’opera di trasformazione completa dell’ambiente e della vita
sociale dell’intero genere umano. Addolcimento dei luoghi, innanzi
tutto: secondo il senso di una metafora, cui egli ricorre in una frase
anche stilisticamente pregevole («il mondo intero è stato [da voi
Romani] trasformato in un delizioso giardino»). Una fascia di natura
umanizzata – di natura amica, si potrebbe dire – rende adesso
piacevole la vita degli uomini, dove prima c’erano soltanto difficoltà e
asprezza («prima del vostro governo la vita, io penso, doveva essere
[…] dura, selvaggia, non molto diversa da quella che si fa sulle
montagne»); una moltitudine di città («le coste del mare e le regioni
dell’interno [ne] sono gremite»), tutte magnifiche («splendenti di
luminosa bellezza»); campagne sicure («le fumate che si levavano
dalle pianure, i fuochi di segnalazione per amici e nemici sono
svaniti»); mari solcati «da navi mercantili invece che da triremi da
guerra»; dovunque «ginnasi, fontane, templi, manifatture, scuole».
E insieme, cambiamento delle condizioni civili e politiche: grazie
alla diffusione universale da parte dei Romani di uno schema di
organizzazione sociale uniforme e razionale, che riusciva a integrare
conquistatori e conquistati, e che era capace di valutare secondo il
merito e non secondo il caso o la forza («voi avete diviso le comunità
di tutti i popoli dell’impero – e con questa parola sto indicando l’intero
mondo abitato – in due gruppi distinti: e dovunque avete trasformato
in cittadini [romani] i piú colti, abili e capaci, mentre gli altri sono stati
resi sudditi del vostro governo»). Dove una volta dilagavano i
conflitti, si distende adesso la pace fra gli uomini, («avete provveduto
a sopprimere ogni ragione di contrasto»), avendo assegnato a
ciascuno il posto che gli spettava non in base a una logica di
dominio, ma in nome di un criterio generale di ragionevolezza
sociale e politica (un modello esemplare di ordine, di taxis), che
sapeva distinguere tra coloro che apparivano degni di governare, e
chi invece non poteva che essere governato.
Lo stesso pensiero – la rappresentazione di un capovolgimento
totale – si rivelava attraverso il ricorso a una elaborata metafora
cosmologica, nel punto retoricamente e concettualmente cruciale
dell’orazione: «Come una volta, stando a quanto raccontano i poeti,
prima del regno di Zeus l’universo era in preda ai contrasti, alla
confusione e al marasma, ma dopo il suo avvento tutto fu sistemato
ordinatamente al suo posto […], cosí, se si considera lo stato del
mondo com’era prima di voi, e com’è sotto il vostro governo, si deve
arrivare alla conclusione che prima del vostro impero ogni cosa era
confusa, caotica e sottosopra, ma da quando voi governate, il
disordine e i contrasti sono finiti, un’armonia universale e una luce
gloriosa sono entrate nella vita e nell’ordinamento dei popoli, le leggi
sono ovunque rispettate, ed è ritornata la fede negli altari degli dèi».
Appare chiaro che quel che si imponeva all’attenzione di Aristide,
e che egli cercava di esprimere in una costruzione letterariamente
efficace, non riguardava tanto la grandezza dei principi e delle loro
imprese. Era la forza ordinante e trasformatrice dell’insieme della
civiltà romana, giunta al suo apogeo, e il suo effetto sulla condizione
precedente dell’umanità, a lasciarlo stupefatto e ammirato (Aristide
stesso usa piú volte la parola oikumenē nel senso di mondo
spiritualmente e materialmente civilizzato dalla presenza romana). E,
soprattutto, era la diffusione della ricchezza a colpirlo – noi diremmo
la potenza dell’economia romana – descritta in un’incalzare di
vedute e di impressioni che fanno da trama all’intero discorso. Si
comincia con l’enfasi del quadro offerto quasi all’esordio: «Qui [a
Roma] affluisce da ogni parte della terra e del mare tutto quello che
produce nelle diverse stagioni ciascuna provincia, e fiumi e paludi e
manifatture di Greci e di Barbari: per vedere queste cose insieme
non bisogna piú viaggiare da un angolo all’altro della terra, ma basta
invece vivere in città. Quanto viene prodotto nei singoli paesi, qui si
trova sempre, in quantità superiore ai bisogni. E cosí numerose
approdano le navi da trasporto, in tutte le stagioni, a ogni mutare di
costellazione, cariche di ogni tipo di merci, che la città si può
paragonare al grande emporio di tutta la Terra. E tanti carichi si
vedono arrivare dall’India e perfino dall’Arabia felice, da far sorgere il
dubbio che in quei paesi siano rimasti spogli gli alberi, e i loro
abitanti debbano venir qui a domandare quel che essi stessi hanno
prodotto, se ne hanno bisogno. E le stoffe di Babilonia e gli altri
generi di lusso di quelle lontane terre barbare si vedono arrivare con
molta maggiore frequenza e facilità delle merci inviate una volta da
Citno ad Atene. L’Egitto, la Sicilia e la parte abitata della Libia sono
vostri granai. Partenze e arrivi di navi si succedono senza sosta; e
c’è da meravigliarsi che non nel porto, ma nel mare ci sia
abbastanza posto per tanti scafi. E come, secondo Esiodo, ai confini
dell’Oceano vi è un luogo dove tutto confluisce in fondo al mare, e il
principio si congiunge alla fine, cosí qui si riversa proprio tutto:
commercio, navigazione, agricoltura, sfruttamento delle miniere, ogni
manifattura passata e presente, tutti i prodotti spontanei e quelli della
coltivazione. Se una cosa non si trova da voi, vuol dire che non è
mai esistita, o non esiste». E si arriva, nelle battute conclusive, sino
alla trasfigurazione dell’impero in un luogo magico dove si rinnovava
una eterna festa: «Eguale a un sacro fuoco inestinguibile, la
celebrazione delle feste non si interrompe mai; ma continua a
passare in momenti diversi da una gente all’altra, perché essa ora
appartiene a tutti»: un’immagine non priva di fascino.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :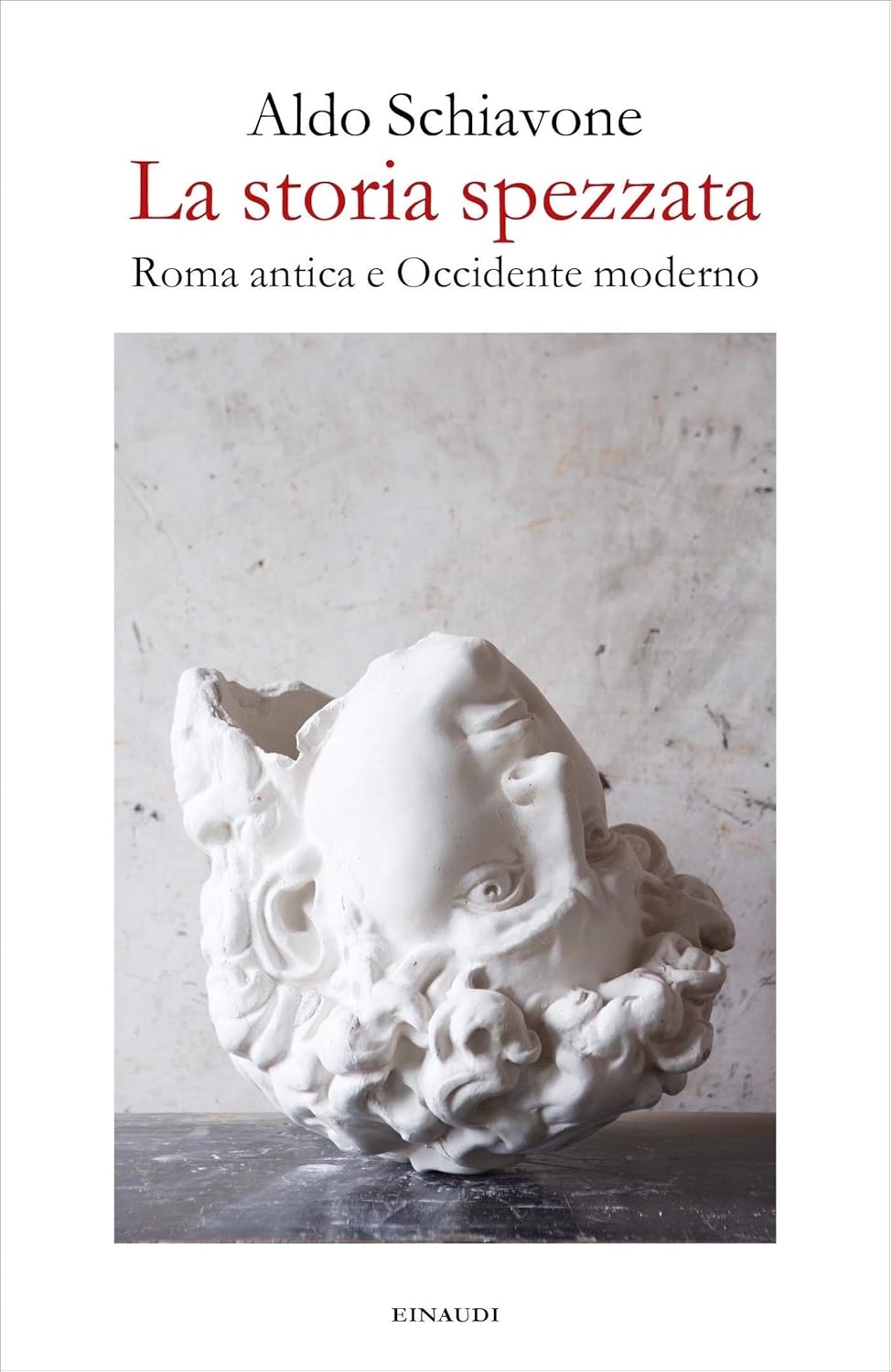






Commento all'articolo