La paura del desiderio – Claire Messud
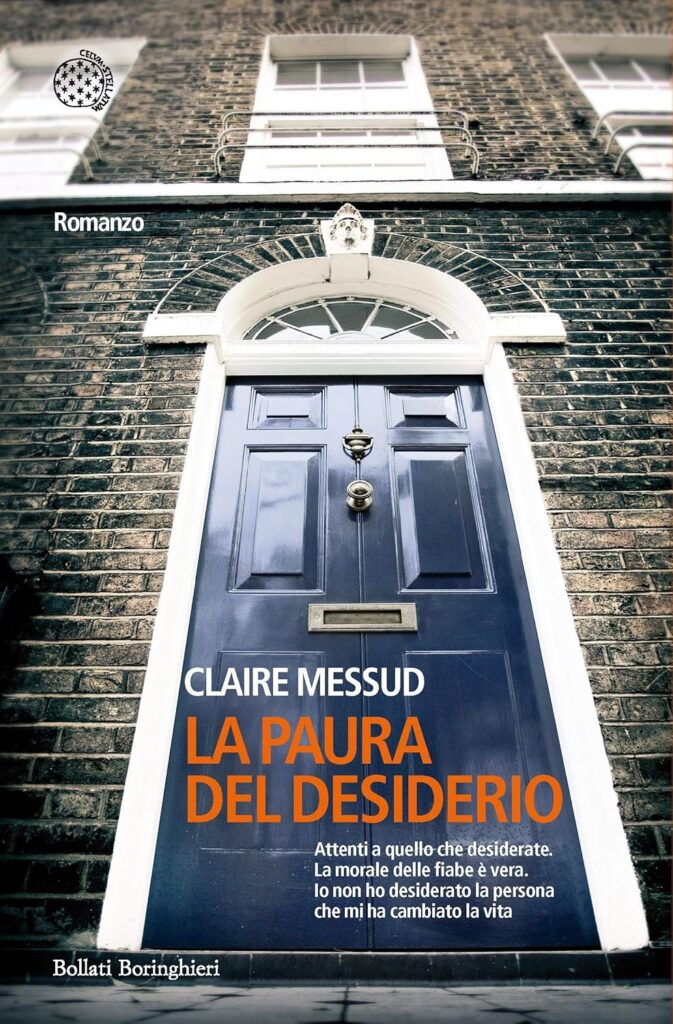
SINTESI DEL LIBRO:
Non molto tempo fa, per ragioni che non varrebbe la pena spiegare, mi
trovai ad alloggiare per un certo periodo in un appartamento ai margini di
Maida Vale, a Londra. Sarebbe stato più onesto chiamarlo Kilburn, ma
senz’altro l’agente immobiliare temeva che il canone di affitto esorbitante,
pensato proprio per attirare gli stranieri come me verso le sue proprietà (per il
principio saldo ma fuorviante secondo cui più paghi e più ottieni), fosse
sinceramente inconciliabile con la parola «Kilburn», che perfino un visitatore
poco informato avrebbe associato a irlandesi sdentati e barcollanti e Pit Bull
ringhiosi stagliati su uno sfondo di discount appariscenti, macellerie con la
carne brulicante di mosche e marciapiedi sconnessi.
Questa immagine stereotipata non era del tutto campata per aria, e se
l’agente immobiliare avesse anche solo sussurrato la parola Kilburn, di certo
le sciarpe svolazzanti di poliestere e le vetrine insaponate della vicina High
Road mi sarebbero parse meno pittoresche e più minacciose di quanto mi
sembrassero in quel momento. Ma mentre mi mostrava l’appartamento – era
una ragazza timida di ventidue o ventitré anni, con una treccia ordinata e
un’eruzione di puntini rossi sul mento, la cui vulnerabilità la rendeva in
qualche modo incapace di fingere, apparentemente (ed erroneamente, come
avrei scoperto in seguito) – le credetti quando disse che eravamo a Maida
Vale; non sapendo dove fosse Kilburn rispetto a quel campo elisio, o a quella
valle elisia come suggeriva il nome, e lasciandomi ingannare, questo va detto,
dal sole che splendeva tra gli alberi e dal porticato appena ridipinto, non alzai
nemmeno lo sguardo passando di fronte allo squallido edificio con i
drappeggi di velluto verde e l’insegna New Kilburn Tandoori.
Lo ammetto: feci una sciocchezza. Mi lasciai ammaliare dall’affitto alto.
Stavo cercando da qualche giorno e cominciavo a non sopportare più il mio
hotel di Paddington, scialbo, puzzolente e troppo costoso. Tra l’altro, l’agente
immobiliare mi disse – e fu la sua unica vera bugia, una bugia importante di
cui le faccio una colpa e per la quale le auguro un’eruzione cutanea perenne
che il canale di Little Venice, un’attrazione piacevole e serena, abbastanza
sgombra di turisti da far credere a ogni turista di averla scoperta per primo, e
il motivo principale per cui avevo cercato un appartamento a Maida Vale
piuttosto che a Hampstead o Chelsea o nella centrale Pimlico, trascurata da
molti e placidamente triste – mi disse che il canale era a qualche breve isolato
di distanza. Forse non disse «breve». Sicuramente disse «qualche isolato». E
solo dopo avere firmato il contratto scoprii che per raggiungere il canale
dovevo camminare per venti minuti a passo spedito sui marciapiedi afosi
(d’estate, con le dita di mani e piedi gonfie e i gas di scarico che mi
annerivano le mucose) nel tratto superiore di Edgware Road tartassato da
clacson e trivelle (subito dopo il punto in cui confluisce in Kilburn High
Road, a dire il vero). E quando lo feci, forse per la rabbia e il caldo, forse
perché era estate, il canale mi sembrò meno piacevole e sereno di quanto
ricordassi, e avrei potuto descriverlo più esattamente (affidandomi ai miei
occhi stanchi) come fetido e torbido, una distesa d’acqua nera e salmastra
sulla quale galleggiavano foglie e detriti di plastica, più simile a una fossa
biologica che non all’idillio veneziano della mia memoria. Dopo quella visita
sgradevole avrei evitato Little Venice per il resto dei miei mesi a Londra,
anche una volta tornato il tipico clima londinese, umido e frizzante e grigio.
Non ci avrei più messo piede – pur passandovi accanto qualche volta in
autobus e in taxi, naturalmente – e non l’ho più fatto sino a oggi, nonostante
io sia ormai una persona diversa.
In realtà presi l’appartamento perché mi piaceva. La risposta onesta
sarebbe questa, catapultandomi di nuovo al pomeriggio di fine maggio in cui
lo visitai insieme all’agente immobiliare – Sheila, si chiamava così: Sheila
Cooke. Sebbene stessero per succedere cose che avrebbero alterato la mia
idea di quel posto – e ne stavano per succedere tante, ma anche nessuna, in un
certo senso – non posso dire che l’agente mi indusse a prenderlo con
l’inganno. L’appartamento mi colpì. Non sto ad analizzarne il motivo, ma
all’epoca ero triste, quasi sempre in solitudine, e sembrava che lì fossero
vissute persone felici. Nella maggior parte degli alloggi arredati che avevo
visto non c’era un’aura, solo la spietata bruttezza dei mobili e la spartana
praticità degli armadietti della cucina, con una manciata di piatti male
assortiti e un mucchio di forchette di stagno. Invece quell’appartamento,
composto da un piccolo ingresso, un ampio soggiorno, una camera da letto e
una cucina separata e abitabile bella grossa, sembrava proprio una casa. O
parte di una casa – era questo, a rigor di termini. Si trovava al primo piano
(nel senso britannico) sul retro di un grande edificio diviso in appartamenti.
Aveva soffitti alti, pavimenti di legno coperti da kilìm variopinti, e tutte le
stanze erano dominate da finestre immense e pulitissime, enormi lastre di
vetro che partivano all’altezza dei fianchi, come nello studio di un artista,
inondando l’appartamento di luce e dando un senso di ariosità, di apertura,
che all’epoca bramavo. Le finestre affacciavano sul giardino del piano di
sotto – un rigoglio di peonie, gigli e clematidi rampicanti, ombreggiato da un
antico melo – e su tutti gli altri giardini, in entrambe le direzioni, a destra e a
sinistra, delimitati da una palizzata. Affacciava anche sulle abitazioni oltre i
giardini, dirimpetto alla mia, che da quella prospettiva sembravano tante case
delle bambole, con persone in miniatura dietro le finestre che conducevano la
loro vita bambolesca.
Gli arredi dell’appartamento erano essenziali ma di buongusto, come se li
avesse scelti qualcuno che avrebbe voluto viverci, e tutti gli elettrodomestici
in cucina erano nuovi. Il bagno aveva una vasca bianca, piastrelle blu scuro e
la giusta illuminazione, e poiché era estate non importava che la finestrella
non si chiudesse del tutto. Ma a convincermi fu il tavolo della cucina, un
vecchio mobile ampio, robusto e graffiato, con la vernice che si scrostava
dalle gambe tondeggianti, e dava un’impressione di compagnia. Era proprio
ciò che desideravo in quel periodo: un’impressione di compagnia, che non
interferisse concretamente nella mia esistenza controllata in modo
meticoloso. Ecco perché le persone che guizzavano tra i vari accessori nelle
case di fronte mi allettavano: c’erano e non c’erano allo stesso tempo, un
segnale che la vita andava avanti, anche se non c’entrava niente con me.
Affittai l’appartamento per poco più di tre mesi – potei farlo perché i
pagamenti erano a cadenza settimanale. Firmai e tirai fuori un assegno
circolare quello stesso pomeriggio soleggiato, con uno zelo che lasciò
alquanto sconcertata la giovane Sheila Cooke. Mi aveva mostrato parecchie
case prima di quella, circa una decina, e ogni volta avevo reagito con una
cortese evasività da cui aveva dedotto, ho il sospetto, che non riuscissi a
farmi coinvolgere da un posto e che alla fine avrei optato svogliatamente per
l’ennesimo appartamento sostanzialmente identico al primo. Forse aveva
ragione: la cosa non mi interessava molto, o così credevo fino a quel
pomeriggio, quando scoprii all’improvviso che mi interessava tantissimo, e
sul momento mi parve un buon segno.
Ero a Londra per l’estate. Ero lì per fare ricerche su un libro, il mio. Non
avevo compagnia, inutile dirlo, anche se non lo avevo previsto. O meglio, lo
avevo solo vagamente previsto, nei mesi precedenti al mio viaggio: dovevo
partire con qualcuno, in via ufficiale, e sempre in via ufficiale le cose erano
rimaste così fino ad appena dieci giorni prima che solcassi l’oceano
Atlantico. Non si erano registrati mutamenti percettibili, non a occhio nudo,
dalla condizione in cui era stato elaborato il piano iniziale – vale a dire di
coppia – alla condizione – disaccoppiata – in cui avevo finito per trovarmi:
non c’era stato uno spiccato deterioramento dei rapporti, né liti memorabili e
neppure una rivelazione da annotare furtivamente. No, la rottura era stata una
semplice rottura, un cambiamento imprevedibile e inspiegabile avvenuto di
punto in bianco, si potrebbe dire. Di punto in bianco, i miei piani erano
cambiati. Benché questa sia la versione ufficiale, e vera a giudicare dai fatti,
c’è anche una mia versione personale, che è più vera, almeno per me, pur non
essendo verificabile in alcun modo e da nessuno. Infatti, se allo scoccare del
nuovo anno mi aveste chiesto – con una confidenza profonda e quasi
inesprimibile, come se foste il mio alter ego, dentro la mia testa – se mi
avrebbe accompagnato qualcuno in questo lungo viaggio di ricerca a Londra
(che era nell’aria già allora, alla fine dell’anno, del secolo, del millennio),
avrei risposto: “Per qualche ragione, penso di no”. Non lo avrei mai detto ad
alta voce, e non lo avevo fatto, e poi non mi pare che qualcuno me lo abbia
chiesto perciò non ho dovuto mentire apertamente; tra l’altro, prima degli
eventi in questione non avevo mai esternato questa sensazione viscerale,
perciò nessuno a parte me potrebbe assicurarvi che l’avevo provata davvero
fin dal principio e non solo a posteriori, alla luce di quanto stava per
succedere. Dovrete fidarvi di me a tal proposito. Perché più tardi – nel
periodo di cui sto parlando, proprio nell’appartamento situato senza ombra di
dubbio a Kilburn – quella sensazione viscerale, per usare la mia definizione,
mi gettò in un dilemma irrisolvibile: era stata una sorta di premonizione di un
disastro del tutto imprevedibile o piuttosto la causa stessa, silenziosa e
strisciante, di quel disastro? Possibile che inavvertitamente – ma senz’altro, a
un livello più profondo, del tutto deliberatamente – avessi causato lo
scioglimento della mia coppia, anche se avrei sostenuto, e lo sosterrei ancora
adesso, che era l’ultima cosa che volevo? Nell’istante stesso in cui, nei taciti
recessi del mio cuore, avevo capito che avrei potuto viaggiare in solitudine e
che lo avrei fatto, era forse diventato il mio destino ineluttabile? Ero l’artefice
della mia stessa distruzione?
Non è su questo dilemma che voglio concentrarmi, anche se ha le sue
ragioni. Non è per questo che sto tornando alla mia prima estate del terzo
millennio – che fu per me empia, con buona pace di Malraux; anche se
probabilmente, con buona pace di Malraux, io non c’entravo un bel niente
perché non miro a raccontare la mia storia. Era un periodo, mi preme
chiarirlo, in cui non avevo una vita. O meglio, in cui non avevo una vita
visibile. Anzi, certe sere nel mio appartamento di Kilburn, mentre osservavo
con le luci spente i vicini delle case di fronte gesticolare o spostarsi da una
stanza all’altra come bambole, mi sentivo più che invisibile (cosa che per loro
ero senz’altro); mi sentivo Dio. Trascorrevo giorni, e più di una volta intere
settimane, senza scambiare altro che frasi di circostanza con leccapiedi di
vario genere – impiegati e cassiere e tassisti e bibliotecari – sapendo che
nessuno avrebbe studiato il mio volto o ne avrebbe anche solo notati i
lineamenti. Se la polizia mi avesse chiesto un alibi per uno di quei giorni
solitari non avrei potuto fornirlo, perché nessuno mi vedeva; c’era chi
conversava con me e mi metteva in mano la spesa o il resto, certo, ma avevo
e ho tuttora la convinzione che non mi vedessero.
Non fraintendetemi: non mi sto lamentando. Non ero in pena per me,
senz’altro non per questo. Se dicessi che in quel periodo ero triste sarebbe
una verità inconfutabile, ma è anche vero che nei miei miseri spostamenti
quotidiani, ermetici e frugali, dall’appartamento alla British Library di nuovo
all’appartamento, con qualche incursione intermedia da Marks and Spencer
(ah, la korma di pollo! ah, i bignè nelle confezioni da due!) – ero addirittura
esultante in quei giorni. Ero triste, sì, per la verità quasi incline al suicidio
sotto un certo aspetto (e incapace di scrollarmi di dosso la preoccupazione di
morire prima di completare le mie ricerche, prima di scrivere il mio libro),
ma per altri versi ero anche in uno stato di beatitudine. Non ero così felice dai
tempi della prima infanzia. Questo mi fece pensare a varie cose: al fatto che
avevo raggiunto uno stato canino, che come un animale stavo conducendo
una vita senza interrogativi e che il mio piacere era dovuto proprio a questo.
Era un periodo limitato: ero a Londra solo per l’estate, dopodiché avrei fatto
ritorno a casa. Ed era un periodo significativo, o almeno non più futile di
qualsiasi altro momento della mia vita, di qualsiasi vita. Non avevo ostacoli.
E questa cosa, questa avventata euforia che pareva presagire uno stato
animalesco, sembrava anche divina. Mi sentivo davvero Dio. Avevo come
l’impressione di guardare i mortali intorno a me dall’alto dei cieli. Osservavo
l’ansia, la rabbia, la speranza sui volti dei miei compagni con un salutare
moto di compassione; eppure, era come se la loro esperienza della vita, così
densa di emozioni, così logorante, impantanata negli infiniti e inutili ostacoli
delle loro giornate, fosse tutt’altra cosa rispetto alla mia. E la mia libertà dalle
emozioni, paradossalmente, mi faceva immergere di più e non di meno nella
vita; mi faceva sentire che loro, tutti quelli che provavano sentimenti, se ne
lasciavano solo distrarre ed erano meno vivi di me. Mi sentivo un’entità
divina e canina insieme, e non erano due esperienze contraddittorie.
Dovevo molto ai comfort protettivi dell’appartamento che Sheila Cooke
aveva trovato per me. Non solo l’esposizione a sud, la cui luce persistente mi
svegliava nelle mattine di sole, e anche nei giorni più grigi spandeva una
luminosità opalescente nella stanzetta bianca; non solo la disposizione
estetica di mobili e tappeti; e nemmeno i piaceri mutevoli ma sempre
verdeggianti del giardino fiorito di sotto, dal quale di tanto in tanto un bombo
solitario si levava, grazioso e rumoroso, sospinto verso l’alto dalle fragranti
brezze del giardino – no, il piacere più grande dell’appartamento rientrava
nella categoria dell’ineffabile cui ho già fatto riferimento: sembrava che vi
avessero vissuto persone felici. E che quella felicità, alla stregua del sudore o
di un profumo, avesse intriso la tappezzeria e velato le superfici oppure, come
filaccia, si fosse annidata negli angoli polverosi, diventando irraggiungibile.
Mi avrebbe sconvolto scoprire che in quelle stanze era stata commessa
un’atroce violenza? O che dietro quelle lastre di vetro trasparente si era
consumata un’orribile prigionia? Credo che nel mio iniziale stato divino e
canino non ci avrei semplicemente creduto. Quel posto, per come lo avevo
conosciuto all’inizio, ed era il solo modo in cui avrei potuto conoscerlo,
trasudava felicità, a prescindere dal complesso di emozioni che avevo portato– oppure no, fallendo clamorosamente – entro le sue quattro mura. Ma tutto
questo poteva cambiare. E sarebbe cambiato.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :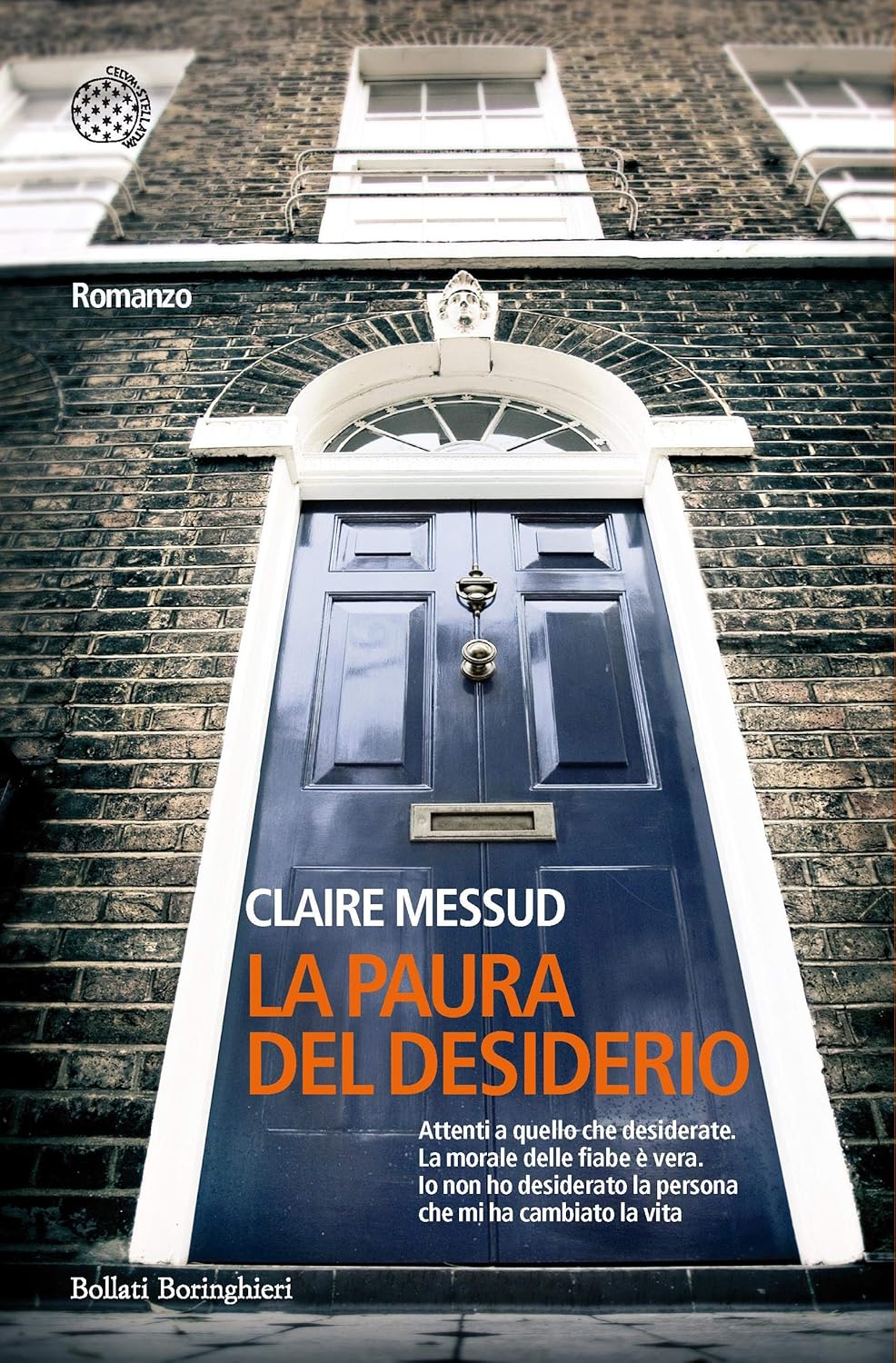






Commento all'articolo